|
|
La vera novità storica del cosiddetto decreto Ronchi, puntualmente convertito con la fiducia lo scorso novembre, sta nel rendere obbligatorio quanto fino a quel momento era solo possibile. Purtroppo era possibile già da tempo gestire l’acqua tramite società private. Diversi comuni italiani già lo fanno (Arezzo, Agrigento), e da tempo le loro popolazioni sperimentano quanto la ricerca del profitto abbia come conseguenza certa la riduzione degli investimenti (Autostrade Benetton docet).
Interessante osservare come la retorica (ipocrita) dominante presso quanti sostengono la privatizzazione sia proprio quella secondo cui il privato può trovare i famosi 60 miliardi che sarebbero necessari per migliorare il sistema degli acquedotti in Italia. I fatti provano il contrario.
La seconda grande ipocrisia che accompagna questa vicenda la si ritrova nella posizione di quanti sostengono (molti purtroppo ancora nel Pd) che anche con il decreto Ronchi l’acqua resta pubblica e che ad essere privatizzato è il servizio, non il bene. Qui occorre essere molto chiari. L’acqua è un bene essenziale per noi umani soprattutto in quanto potabile. La potabilizzazione e il trasporto dell’acqua sono servizi strutturalmente collegati al suo stesso valore d’uso, determinandolo in larghissima parte (quasi interamente in zone piovose). Nell’attuale fase dell’antropizzazione, soprattutto cittadina, l’acqua potabile allo stato naturale è un fenomeno di importanza trascurabile. Ciò che conferisce “valore” anche economico all’acqua è la possibilità di essere bevuta o utilizzata per usi domestici (tralascio quelli industriali o agricoli, in cui la potabilizzazione non è necessaria), cosa che richiede il suo trasporto. Nel caso dell’acqua potabile questo può avvenire o tramite acquedotto o successivamente all’imbottigliamento. Dal punto di vista ecologico, il primo sistema è del tutto sostenibile, mentre il secondo non lo è. Un acquedotto che perde non fa che restituire acqua alla terra, producendo esternalità positive (una piantina nascerà). Un camion che trasporta acqua imbottigliata inquina e produce rischi, e a seguito della consumazione la bottiglietta dovrà essere smaltita con altro inquinamento.
Un sistema attento all’interesse pubblico e all’ecologia favorisce il consumo di acqua trasportata tramite acquedotto e scoraggia l’imbottigliamento. In Italia andiamo esattamente nel senso opposto: le concessioni idriche (come del resto quasi tutte le concessioni su beni pubblici) sono date quasi gratis, con margini enormi per chi imbottiglia privatamente. Forse che il fatto che l’acqua di sorgente sia tecnicamente pubblica (cioè parte del demanio idrico) rende meno privato il profitto enorme di Ferrarelle, Lete, Levissima, Evian etc. (testimoniato fra l’altro dalle grandi spese in pubblicità)?
Il ragionamento di chi sostiene che il servizio può essere privatizzato purché il bene resti pubblico non potrebbe che dare una risposta assurda a questo interrogativo retorico. La verità è che gli stessi gruppi che già gestiscono privatamente l’acqua imbottigliata sono interessati ad entrare nel business della gestione privatizzata degli acquedotti. Se il referendum “sì acquapubblica” non dovesse avere successo lo faranno ad un prezzo stracciato (proprio come quello che già pagano per le concessioni) perché col decreto Ronchi hanno ottenuto che tutte le quote di partecipazione andranno sul mercato nello stesso momento e quindi il prezzo crollerà. Ancora una volta il pubblico è costretto a svendere per legge. Naturalmente questi soggetti avranno tutto l’interesse a che l’acqua del rubinetto sia pessima, in modo da vendere le loro bottiglie di plastica, magari saccheggiando poi soldi pubblici anche per lo smaltimento. Tutto ciò è perfettamente possibile anche mantenendo la proprietà pubblica sul bene e privatizzando solo il servizio connesso, con buona pace di quanti ritengono sufficiente lo statuto pubblico del bene e non quello del servizio.
La Commissione Rodotà aveva affrontato questi particolari problemi legati all’acqua e aveva concluso la sua proposta di legge delega classificandola, proprio nel cuore del Codice civile, non già come bene pubblico ma come bene comune. Secondo questa definizione il bene comune deve necessariamente essere gestito in regime pubblicistico anche nell’interesse delle generazioni future. È interessante osservare che il Pd ha ufficialmente accolto questa definizione, visto che tutti i suoi senatori (Bonino inclusa) hanno sottoscritto la presentazione della legge delega Rodotà in Senato (imitando la Regine Piemonte dove la proposta Placido, che contiene esattamente questa definizione, è stata sottoscritta addirittura da Pdl e Lega locali). A giudicare dal balbettio nel Pd romano nessuno se ne deve essere accorto, e poi chissà quando mai la proposta andrà in aula.
Terza ipocrisia è contenuta nel preambolo del decreto Ronchi, laddove si dice che l’Unione Europea obbligherebbe a privatizzare il servizio idrico. Siamo qui di fronte ad un’inedita figura di menzogna per decreto. Chiunque conosca trattato, direttive e principii fondamentali sa benissimo che la cosa semplicemente non è vera. Tuttavia, dando la colpa all’Europa il decreto Ronchi cerca di sgravare la maggioranza della responsabilità politica per un disastro annunciato. E inoltre, ancor più furbescamente, essa cerca di accreditare il decreto Ronchi come una di quelle leggi «comunitariamente necessarie» che la Corte Costituzionale ha in passato ritenuto immunizzare dal referendum ex art. 75. Riteniamo che questa volta molto difficilmente la Corte ci cascherà e confidiamo perciò che, raccolte entro estate 2010 le firme, si possa nella primavera 2011 concentrarsi su questo decisivo referendum che, parlando al cuore e al cervello degli italiani, potrebbe far rivivere il nostro solo strumento di democrazia diretta. Purtroppo dall’Idv si minacciano lenzuolate di referendum tutti condivisibili in linea di principio ma il cui solo effetto sarà quello di rendere molto difficile per tutti il raggiungimento del quorum.
da ilmanifesto ugo mattei 19/3/010
Oggi cambia la composizione dell’Ftse/Mib, l’indice delle 40 maggiori società quotate
Esce la Mondadori. Azienda Italia spa, ecco come in 15 anni siamo rimasti indietro
Oggi cambia la composizione dell’indice Ftse/Mib: il paniere delle 40 maggiori società quotate, che meglio rappresenta Piazza Affari. Esce Mondadori, un’icona della nostra industria, ed entra Azimut, risparmio gestito. Il cambiamento della composizione di un indice di Borsa è un fatto marginale sia per il mercato azionario, sia per le società coinvolte; e irrilevante per l’economia nel suo complesso. Ma ha una valenza simbolica. Ed è un buon pretesto per fotografare il nostro capitalismo, e confrontarlo con quello degli altri, dopo i postumi della crisi e a 15 anni dall’avvio del processo di risanamento economico, privatizzazioni, liberalizzazioni, regolamentazioni, sfociato nella costituzione dell’Eurozona.
L’immagine del capitalismo italiano che si riflette nello specchio dell’indice Ftse/Mib sembra una fotografia ingiallita di 15 anni fa. La cosa dovrebbe farci riflettere perché rappresenta un’ipoteca sul nostro futuro benessere. Invece, sembra provocare solo scarso interesse, se non paradossali sussulti d’orgoglio per una ipotetica “via italiana” al capitalismo che, come l’isola di Peter Pan, non c’è, ma è un mito troppo bello per essere sfatato.
La Borsa italiana oggi è fatta da pochissime grandi imprese. Le 40 del Ftse/Mib rappresentano l’87% della capitalizzazione totale (valore di mercato di tutte le imprese quotate). Dei primi 150 titoli del listino, la metà ha una capitalizzazione inferiore ai 696 milioni. Il numero delle società quotate è limitato, non molto distante da quello di 25 anni fa. L’intero mercato azionario italiano vale, ai prezzi attuali, solo il 30% del Pil 2009. Non è neppure pensabile un confronto con gli Stati Uniti: basti ricordare che negli USA, anche dopo la crisi, il rapporto tra valore della Borsa e Pil è al 103%, e nelle prime 150 società, la metà vale più di 25 miliardi euro. Ma siamo il fanalino di coda anche dell’Europa Continentale: il nostro rapporto borsa/Pil è meno della metà di quello francese (74%), ed è inferiore anche a quello tedesco (40%), anche se in Germania, tradizionalmente le imprese si sono sviluppate al di fuori del mercato azionario; ma dove, tra le prime 150 società, la mediana è grande il triplo della nostra.
Questa non è l’inevitabile conseguenza del nostro capitalismo, familiare e manifatturiero. Anche in Francia e Germania molte imprese sono controllate da un gruppo spesso ricollegabile al fondatore, ma il peso delle grandi imprese nei settori dei beni di consumo e industriali è il doppio del nostro: tra le principali 40 società quotate francesi e tedesche ci sono colossi in settori come moda, beni per la persona, alimentare (Luis Vuitton, Adidas, Danone, Beiersdorf, Hermes, …) anche cinque, dieci volte più grandi delle nostre medie imprese d’eccellenza. Per non parlare della meccanica. I vantaggi delle economie di scala ci sono, e notevoli, anche nel settore manifatturiero tradizionale, specie se la fonte di crescita dell’economia mondiale è sempre più lontana dall’Europa. Vantaggi non solo per le aziende, ma pure per il Paese, visto che i grandi gruppi necessitano di figure più qualificate sotto il profilo professionale, richiedono mediamente maggiori competenze e pagano quindi remunerazioni più elevate. La quotazione è poi indispensabile per permettere l’espansione all’estero tramite acquisizioni, come dimostrano anche i rari casi italiani presenti nel Ftse/Mib: Luxottica, Lottomatica, Mediaset, Autogrill, Campari.
Ma è la composizione settoriale delle maggiori società quotate che ci distacca maggiormente dal resto dell’Eurozona, per non parlare degli Stati Uniti. Da noi, anche dopo la crisi, il 35% dell’indice è costituito da banche e servizi finanziari: quasi il doppio di Francia e Germania. Negli Usa, dove la bulimia del settore finanziario aveva innescato la crisi, banche e finanza pesano oggi la metà che in Italia. Un ridimensionamento drastico quanto salutare.
Il resto di Piazza Affari è fatto di servizi di pubblica utilità ed Eni: insieme alle banche, fanno quasi l’80%. È il retaggio del peso dominante nella nostra economia dello Stato imprenditore. Un peso però ancora presente, dato che il 41% delle aziende nel Ftse/Mib ha un’azionista di riferimento pubblico, Stato o Ente locale (tra le banche ho considerato il solo Monte Paschi). Se a queste aggiungiamo le società interamente cedute dallo Stato ai privati (come Autostrade, Sme, Telecom o le genco dell’Enel), si arriva all’assurdo che il 69% delle nostre grandi aziende quotate è pubblica o nata dalla mano pubblica. Inevitabile in un capitalismo storicamente senza capitali? No. È vero che 20 anni fa, senza mobilità internazionale dei capitali, il risparmio degli italiani doveva necessariamente finanziare il deficit pubblico. E in mancanza di un mercato finanziario, tutto passava per le banche. Ma l’Euro, le liberalizzazioni, lo sviluppo e l’integrazione dei mercati, avrebbero dovuto liberare i nostri capitalisti dallo storico vincolo della carenza di capitali.
Invece, il mercato dei corporate bond è stato ucciso sul nascere da Cirio e Parmalat. Possono emettere un bond solo le poche aziende private che hanno accesso ai mercati esteri. E la crisi ha affossato anche quel poco di cartolarizzazioni non bancarie che c’erano in Italia. La Borsa è servita soprattutto allo Stato per vendere e far cassa; a molti gruppi privati di vecchio lignaggio, per compiere operazioni ad alta leva finanziaria; e a troppi imprenditori per sfruttare le ricorrenti ondate di facili entusiasmi per collocare a caro prezzo quote di minoranza (investendo altrove il ricavato): la triste scia di perdite causate dalle matricole è li a rammentarcelo. Negli Usa la bolla delle dot. com ha provocato tanti disastri, ma l’euforia per gli investimenti azionari ha anche reso possibile la nascita di giganti, come Google, Amazon, Qualcomm, o Cisco. Da noi, invece, l’unica realtà di successo sopravvissuta al Nuovo Mercato è Fastweb: non esattamente un caso da indicare a esempio.
Con il pretesto di difendere l’italianità si è sbarrato la strada ai capitali esteri. Così, i flussi finanziari in Italia sono tornati a passare obbligatoriamente per il sistema bancario nazionale. Come vent’anni fa. Solo che ora il numero delle banche si è ridotto e l’influenza della politica è meno trasparente (ma forse non meno efficace). Da un capitalismo senza capitali, siamo passati a un capitalismo senza capitalisti: gestire relazioni e rapporti col settore pubblico è altro che creare imperi economici.
L’ultimo elemento della fotografia che dovrebbe far riflettere è la totale assenza in Italia di grandi imprese nei settori a maggior crescita della produttività: non solo tecnologia, informatica e farmaceutica (39% negli Stati Uniti) ma anche settori tradizionali che incorporano innovazione tecnologica e manageriale come i beni di largo consumo per il tempo libero e la grande distribuzione. In questo, anche il resto dell’Europa non tiene il passo degli Usa, e non sembra capace di sfruttare la crisi per cambiare il modello produttivo. In Italia il gap sembra incolmabile. Ma, purtroppo, il reddito delle generazioni future dipende proprio dalla capacità di spostare le risorse nei settori a maggior crescita della produttività.
da la repubblica 22 marzo 2010 di alessandro penati
Ersilio Mattion da Il Giorno 18 marzo 2010
Il govematore: idea strampalata. Il rivale: i fondi si possono trovare
DUELLANO SULLE TASSE, Roberto Formigoni e Filippo Penati. E non usano il fioretto, arrivando ai limite dell’insulto. Secondo il governatore, candidato presidente del centrodestra, il suo avversario ®non capisce nulla di bilancio regionale e non conosce nemmeno le tabelline che si studiano in quinta elementare». Secondo l’ex presidente della Provincia, invece, gli attuali amministratori del Pirellone non sono neppure capaci di trovare 250 milioni, in un bilancio di circa 23 miliardi di euro, per i 30 mila lavoratori precari lombardi che hanno perso il posto di lavoro e non hanno alcuna protezione sociale».
LA POLEMICA scoppia ieri, a margine del congresso regionale della Cgil che riserva applausi a Penati e qualche fischio a Formigoni. Il candidato del Pd gioca in casa. Ma il punto è un altro: la proposta del leader del centrosinistra lombardo che, in caso di vittoria, promette di assegnare ®un buono scuola diverso non solo per chi frequenta le private e un assegno da 700 euro mensili, per un anno, a favore dei precari disoccupati». Penati fa i conti. E calcola che quest’operazione costerebbe 250 milioni. Da cià la sua logica conclusione: è possibile, dal momento che si impegnerebbe ®meno dell’uno per cento del bilancio regionale». Il candidato Pd rinfresca la memoria agli elettori: ®Ho sempre trovato i soldi rispetto alle iniziative da proporre, cosi come ho trovato 25 milioni (nel 2009, da presidente della Provincia, ndr) per aiutare 20 mila famiglie milanesi a uscire dalla crisi e per incentivare le imprese a stabilizzare il lavoro precario e a fare nuove assunzioni». I conti, perà, li fa pure Formigoni che battezza la promessa elettorale del suo sfidante come ®strampalata». Il governatore entra poi nei dettagli: I precari in Lombardia sono all’incirca 300 mila, a 700 euro per dodici mensilità sono 8 mila e 400 euro per ogni precario. Moltiplicati per 300 mila perfanno 2 miliardi e 520 milioni di euro all’anno. Dove andrà Penati a prendere i soldi per mantenere i suoi impegni? Ha una sola strada da percorrere: aumentare a dismisura le tasse regionali, sballando i conti delle famiglie e mandando sul lastrico artigiani, imprenditori, commercianti e tutti coloro che lavorano». i
- A ottobre 2009 il Consiglio dei ministri approvò la nuova regolamentazione sulle retribuzioni. Il dietrofront arriva a febbraio 2010. Per il ministro Tremonti era “una norma incostituzionale”
-
- ROMA – Via il tetto agli stipendi dei manager inserito nella Legge Comunitaria al Senato. E’ quanto prevede un emendamento al testo a firma del governo presentato ieri allo scadere del termine per le proposte di modifica in commissione Politiche Ue. La misura amplifica gli effetti di una analoga proposta formulata al testo dalla commissione Finanze.
-
La vicenda era iniziata a ottobre del 2009 quando il Consiglio dei ministri aveva dato il via libera alla regolamentazione che poneva un tetto agli stipendi dei manager pubblici. Su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, il governo aveva approvato uno schema di regolamento, concertato con il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, che poneva un limite massimo alle retribuzioni per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo (compresi i contratti d’opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto) direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica. Le retribuzioni non avrebbero potuto superare il trattamento economico complessivo della carica di Primo presidente della Corte di Cassazione.
Ma la regolamentazione non ha retto. Il dietrofront del governo arriva il 24 febbraio di quest’anno. Un voltafaccia annunciato. In breve tempo il contrasto tra il sentimento popolare e le regole di mercato si è risolto a favore delle seconde. “La questione del tetto è un tema importante ma la norma che è stata votata dal Senato verrà cambiata dal governo – aveva detto il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti – Abbiamo fatto sapere che questa è una norma incostituzionale”.
Il testo è poi arrivato alla Camera dove è stato modificato dalla commissione Finanze. Come previsto dal regolamento di Montecitorio, l’emendamento si intendeva accolto salvo che la commissione per le Politiche Ue non lo avesse respinto per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
da la Repubblica.it
Il premier si conferma così il più ricco tra i parlamentari della Repubblica
Il reddito del presidente del Consiglio cresce di 9 milioni di euro. Bersani invece perde 13 mila euro
Il premier si conferma così il più ricco tra i parlamentari della Repubblica
Berlusconi sempre più ricco
Il reddito del presidente del Consiglio cresce di 9 milioni di euro. Bersani invece perde 13 mila euro
MILANO – Il reddito di Silvio Berlusconi del 2009 è stato di 23.057.981. L’anno precedente era invece di 14.532.538. Il presidente del Consiglio si conferma così il più ricco tra i parlamentari della Repubblica. Tra i beni immobili a lui intestati risultano anche 5 appartamenti a Milano, 2 box sempre a Milano, e un terreno ad Antigua. Alla voce «variazioni in aumento» compare l’acquisto di un immobile a Lesa (Novara) e la costruzione di un immobile sul terreno di Antigua. Lo rivelano le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009, relativamente alle entrate percepite nel 2008, rese note dal Parlamento.
BERSANI – Se il leader Pdl nell’anno nero della crisi si arricchisce di 9 milioni di euro, il segretario del Pd perde circa 13 mila euro in un anno. La sua dichiarazione Irpef del 2008, segnalava infatti un reddito imponibile di 163mila 551 euro. Tra l’altro, Bersani non risulta in possesso di beni immobili.
FINI – Il presidente della Camera Gianfranco Fini ha invece un reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi 2009 di 141.176 euro. L’anno precedente aveva denunciato al fisco 105.633 euro. Da quando è diventato presidente della Camera, insomma, Fini avrebbe guadagnato circa 35 mila euro in più.
LETTA E BERTOLASO – E’ invece Gianni Letta il più ricco tra i componenti non parlamentari del governo. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha dichiarato 1.315.186 euro di redditi imponibili. Guido Bertolaso, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Protezione civile, dal canto suo, ha dichiarato 613.403 euro. L’anno precedente aveva dichiarato poco più di un milione di euro. Anche il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, supera i 600mila euro: reddito 2008 dichiarato 634.968 euro.
da Il corriere on line
|
|









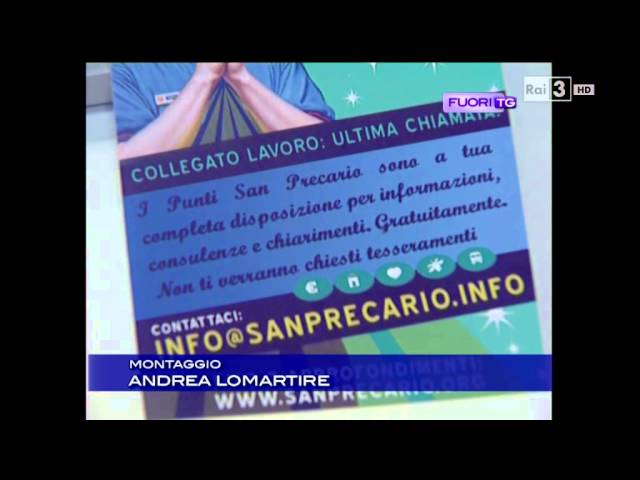









![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/ai/20210620161937im_/https://www.precaria.org/wp-content/uploads/valid-rss.png)
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](/ai/20210620161937im_/https://www.precaria.org/wp-content/uploads/valid-atom.png)