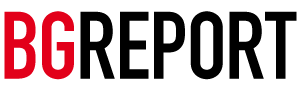Bergamo – Oggi, 24 settembre, è stato sciopero nazionale degli educatori e degli assistenti scolastici. A indirlo il sindacato USB, con un comunicato sulla sua pagina web in cui vengono messi nero su bianco il timori che inevitabilmente accompagna queste figure professionali: come verrebbe gestito un eventuale nuovo lockdown della scuola? In quale estremamente precaria situazione si troverebbero gli assistenti all’educazione scolastica? Lo stesso comunicato recita: “L’aver toccato il fondo ha imposto a tutte e tutti i lavoratori del settore, da Nord a Sud del Paese, un nuovo ordine di ragionamento: non siamo più disposti a rinunciare ad una visione del nostro lavoro che non riconosca il ruolo pubblico e fondamentale dei servizi che svolgiamo, non siamo più disposti a regalare il nostro presente e il nostro futuro agli imprenditori dei servizi pubblici, quelle cooperative sociali e quel terzo settore che da ormai vent’anni ha perso ogni spinta propulsiva e mutualistica, costringendoci a condizioni di lavoro da fame, precarietà e caporalato. In questi mesi, appena ne abbiamo avuto la possibilità, in tutte le principali città siamo scesi in piazza per chiedere la reinternalizzazione dei servizi scolastici, il riconoscimento della funzione pubblica del nostro lavoro, la garanzia della tutela salariale e di condizioni di lavoro degne. È questa la parola d’ordine che, comune per comune, regione per regione, da oggi deve informare l’orizzonte e il ragionamento di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei servizi scolastici in appalto.”
A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, già di per sé estremamente delicato dato il periodo, ecco infatti che gli educatori e le educatrici addetti all’assistenza e alla cura di giovani affetti da fragilità psico-motorie lievi o gravi si ritrovano a dover fare inevitabilmente parte di un teatrino che chi lavora da più tempo nel settore conosce ormai fin troppo bene: la totale incertezza nella quale si muovono queste figure professionali di anno in anno risulta sconcertante, dal momento che, ogni settembre, fino all’ultimo, salvo rari casi, l’educatore o l’educatrice che dovrà lavorare a scuola non ha minimamente idea di quale sarà l’alunno o l’alunna con cui lavorerà, né di quante ore lavorerà e, di conseguenza, della retribuzione che percepirà. I contratti a tempo indeterminato, anche a giovanissimi, non mancano, ma all’agghiacciante condizione di accettare senza battere ciglio una precarietà che praticamente azzera la possibilità di condurre un’esistenza “normale”, fatta ovviamente anche di spese e costi, come gli affitti da pagare, spesso insostenibili se in proporzione agli stipendi del settore, stipendi che, appunto, variano di anno scolastico in anno scolastico (e che, quindi, possono drasticamente diminuire ogni settembre). L’inferno dell’educatore comincia con l’inizio dell’anno scolastico e non sembra finire mai, in un continuo di incertezze, a partire appunto dallo stipendio, per arrivare all’assurdità secondo la quale, in caso di assenza dell’alunno o dell’alunna seguiti, l’educatore/educatrice non percepirà la paga per quelle ore, passando per gli accordi territoriali, firmati dai sindacati confederali, che mirano a trattenere il 30% dello stipendio dalla busta paga dei lavoratori per far fronte ai mesi estivi durante i quali le scuole sono chiuse (ne abbiamo parlato qui).
L’INFERNO DELL’EDUCATORE AI TEMPI DEL COVID:
La critica situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, e Bergamo in maniera se possibile ancora più tragica, pareva quanto meno aver messo in luce le condizioni di lavoro degli educatori e delle educatrici, e in generale dei lavoratori e delle lavoratrici del terzo settore. Come per medici e infermieri in prima linea negli ospedali a combattere l’emergenza da Covid-19, anche queste altre figure professionali sono stati vittime della narrazione che li dipingeva come “eroi”, “angeli”: esseri umani, anzi, ibridi capaci di compiere miracoli ed azioni fuori dal comune pur di salvare il prossimo, pur di sacrificare la loro stessa vita o, se non è quella, il loro tempo e le loro energie per aiutare chi si ritrova in una condizione più debole, più svantaggiosa. I lavoratori e le lavoratrici del terzo settore dell’assistenza socio-sanitaria alla persona si sono ritrovati così a dover fare i conti, oltre che con la realtà dei fatti, ben distante dagli scenari epici o mistici che definizioni del genere suggerirebbero, anche con un discorso pubblico che li ha voluti definire con questi termini: termini che non valorizzano il loro lavoro, ma che anzi lo pongono come in un senso di predestinazione, in linea con la narrazione che già avviene da anni secondo la quale svolgere un lavoro che abbia a che vedere con la cura della persona sia sinonimo di una qualche vocazione missionaria disposta a sopportare di tutto pur di portare a termine il proprio compito. Ebbene, nonostante un’inclinazione individuale ad avere uno sguardo più attento nei confronti di chi si ha davanti sia senza dubbio il cardine su cui si apre la porta dell’assistenza e dell’educazione, definire “eroi” coloro i quali spendono le loro competenze e le loro energie nella cura di altri esseri umani risulta quanto meno ridicolo, se non proprio riduttivo del lavoro che svolgono. E’ un termine che toglie la dignità e, conseguentemente, il sentore di poter rivendicare dei diritti per lavoratori e le lavoratrici in esame: come se il loro fosse un compito che si ritrovano costretti a compiere per salvare il mondo, senza badare a quale costo. Nel periodo in cui gli effetti della pandemia sono stati più devastanti queste enfasi e riconoscenza nei confronti di tali figure professionali si sono fatte più insistenti, e così il barlume di speranza era quello che, con la ripresa dell’anno scolastico, non ci si sarebbe dimenticati del fondamentale ruolo da loro giocato. Ma, passato il lockdown e riprese pian piano tutte le attività, l’ombra è calata di nuovo su questo inferno in terra.
Sebbene il tema non venga spesso affrontato, non si può negare che chi lavora in ambiti quali centri diurni e residenziali, ma anche appunto scuole, centri aggregativi, comunità e affini, svolga un lavoro di cura e attenzione alla persona non indifferente. In qualsiasi circostanza, Covid o meno. L’emergenza sanitaria ha di fatto prodotto un paradosso che vede questi lavoratori e queste lavoratrici, solitamente condannati a stipendi da fame e relegati a una posizione di assidua precarietà, in un settore facilmente sottoposto negli anni a numerosi tagli, complici la privatizzazione dei servizi erogati e la riorganizzazione territoriale del welfare, d’un tratto divenire figure considerate essenziali, importantissime per l’andamento del sistema socio-sanitario, tant’è che sono moltissimi i dipendenti in Italia che, durante il lockdown, non si sono fermati, che hanno continuato a lavorare nei contesti di cui sopra. Inutile dire che gli stessi dipendenti, essendo il loro un lavoro di cura, che oltre a specifiche competenze sanitarie ed educative richiede anche un investimento mentale ed emotivo di un certo spessore, si sono ritrovati sì a continuare a lavorare, consci del loro ruolo determinante finalmente riconosciuto, almeno a livello ufficioso, ma lo hanno fatto a denti stretti, senza la possibilità di scioperare o fermarsi anche laddove il rischio per la salute era alto, poiché a livello etico e morale farlo sarebbe stato considerato come un oltraggio, sia alla loro professionalità che all’utenza della quale si prendono cura. La figura dell’educatore e dell’educatrice cambia nei suoi obbiettivi e nella sua metodologia in base al contesto in cui si svolge: confini tanto labili rendono questa professione da sempre soggetta a una flessibilità di ruoli e mansioni che pochi altri lavori richiedono, e finiscono con l’assoggettare i dipendenti a ogni sorta di condizione lavorative. Come per gli educatori dell’assistenza scolastica: assunti tramite cooperative, con contratti che solo attraverso un intricato puzzle di incastri di orari arrivano a un monte ore settimanale che consente un paga più o meno dignitosa, i lavoratori e le lavoratrici si sono ritrovati ad essere considerati “essenziali”, eppure in balia delle decisioni delle singole cooperative, come avvenuto, per esempio, per la questione della continuità del reddito nel momento più nero dell’emergenza sanitaria.
In alcune zone del Paese i sindacati si sono fatti sentire, pretendendo l’applicazione da parte degli enti appaltanti dell’articolo 48 del decreto Cura Italia, che autorizzava gli enti a erogare i fondi già messi a bilancio per i servizi educativi quali le scuole, i servizi residenziali e tutti quelli che erano stati temporaneamente sospesi. Nelle Marche è stato richiesto che la Regione intervenisse e facesse di questa possibilità di erogazione un obbligo, senza la diversificazione territoriale che troneggia in questo settore. La conseguente strada più auspicabile diviene allora quella della re-internalizzazione di tutti questi servizi: secondo i dati Istat la spesa sociale dei comuni, su cui grava gran parte dei costi socio-assistenziali, è allo 0,41% del Pil totale, numero solo ultimamente in crescita, e presenta comunque enormi diseguaglianze territoriali tra il basso investimento del Sud Italia rispetto a quello che avviene al Nord. Poter invece contare su finanziamenti stabili e standard vincolanti e uniformi a livello nazionale per l’erogazione dei servizi, togliendo questo settore dalla malsana logica del contenimento della spesa pubblica, sarebbe una svolta essenziale che donerebbe di nuovo dignità e professionalità a un lavoro che si prende cura di soggetti che troppo spesso vengono considerati meri costi, soggetti non produttivi in un sistema che vive di produzione e guadagno.