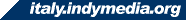"Da quel momento mi convertii al dubbio metodico cessando per sempre di credere che due più due fa quattro, che la ruota della storia gira in avanti, che il progresso si misura sui listini di borsa, che gli ultimi saranno i primi."
Per chi ha già letto Servabo, per chi ha l'abitudine di cercare su il manifesto i suoi editoriali, questo ultimo libro di Luigi Pintor rappresenta il nodo cruciale di una ricerca intellettuale e letteraria da una parte, umana e politica dall'altra.
La bellissima prosa è ricca di citazioni nascoste, di riferimenti letterari e di cronaca politica e chiede al lettore una complicità intima con l'autore, un "comune sentire" che permette di capire anche le pagine più allusive, meno esplicite. Sottintendere i fatti per esprimere le emozioni residuali, le sedimentazioni nella memoria è il tono generale dell'intero libro, così come il doloroso senso di sconfitta, umana e politica. La citazione iniziale (ripresa nelle ultime pagine) in cui un Anonimo pensatore dichiara che "si può essere pessimisti riguardo ai tempi e alle circostanze, riguardo alle sorti di un paese o di una classe, ma non si può essere pessimisti riguardo all'uomo", potrebbe apparire in contraddizione con l'amarezza, talvolta tragica, delle pagine de La signora Kirchgessner. Eppure è forse solo la storia recente, gli uomini dell'oggi che non paiono salvarsi: le pagine relative all'infanzia, le figure del padre e della madre, pur senza assumere mai carattere agiografico, rappresentano il polo positivo della vita dell'autore. Ricorrente è il rimpianto per non aver saputo, o potuto, chiudere lì, in quei luoghi assolati e a quell'età, la propria esistenza, quando ancora tutto era intatto, quando l'armonia tra sé e la natura, il mondo circostante e gli uomini del proprio tempo, non era stato infranto, quando i propri errori o le proprie verità non erano ancora così difficili da sopportare. E proprio questo mi sembra, in questa autobiografia così povera di eventi espliciti, di fatti narrati, ciò che resta maggiormente impresso nella coscienza del lettore: pochi uomini hanno saputo vivere con tanta coerenza le proprie scomode scelte, pochi hanno saputo, con tanta onestà, dichiararsi sconfitti. E questo sul piano pubblico e politico, ma anche nel proprio privato. Pochi accenni in apertura, un paio di capitoli e molte frasi sparse lungo l'intero libro, riguardano il figlio morto appena un anno fa. Un senso di inadeguatezza profonda, di incomprensione colpevole, di incapacità nel saper riempire il dolore esistenziale di quel ragazzo, "uomo non pratico, ostinato idealista, pessimo soggetto in un mondo straniero", e infine il tormento di averlo fatto "crescere in sofferenza e morire in solitudine". Eppure quel figlio era stato tanto amato se, come dice nel capitolo Il tempio, l'evento di certo più importante del 1956 per lui (anno cruciale per chi, comunista, aveva dovuto assistere alla violenza dei carri armati sovietici che invadevano l'Ungheria) era stato la grave malattia che aveva colpito il piccolo Giaime.
Una vita, quella di Pintor, trascorsa ad affermare quelle scomode verità che il ceto politico non ha mai tollerato, che gli sono costate davvero molto, ma che non ha mai voluto tacere per irriducibile onestà intellettuale e coerenza etica. Oggi, dopo tanti anni di militanza, attraverso le pagine di un giornale da lui fondato, ancora continua ad esprimere la sua rabbia e la sua indignazione davanti alla mistificazione, all'ingiustizia, alla meschinità dei tempi. Oggi, colpito ancora una volta da una morte, quella della figlia strappatagli nel giro di un mese da una malattia incurabile, l'unico omaggio che gli possiamo tributare è il dichiararci inadeguati, ma ancora capaci di farci attraversare e ferire dalla sua penna così vera e raffinata, così poetica e dolorosamente ironica.
|