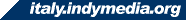“Io mi ricordo”, diceva il Vecchio Antonio, “di una Terni piena di rumori, di canto notturno delle sirene, dei tonfi del grande maglio che facevano sussultare il giaciglio su cui dormivamo, e i magli multipli, e le berte della collina che rintronavano nella città. Di come, turno dopo turno, fu forgiato l’acciaio e di come, assieme all’acciaio, furono forgiate le nostre armi nuove”.
A ripensarci oggi vengono quasi le lacrime agli occhi. Rabbia. Dolore. Indignazione. La multinazionale tedesca Thyssen-Krupp, proprietaria unica e incontrastata delle acciaierie di Terni dall’indomani della loro privatizzazione, ha ormai annunciato, tra lo sprezzante disinteresse del governo nazionale e delle associazioni degli industriali, la prossima chiusura del reparto acciai magnetici, la punta più avanzata di tutta la filiera produttiva, e la messa in mobilità di oltre 900 posti di lavoro tra diretto e indotto. Posti di lavoro – si sappia – già fortemente incerti e vacillanti anche a causa delle nuove forme di contratto atipiche e precarie imposte dall’azienda di Essen e dalle imprese contoterziste a tutti i nuovi assunti.
A viale Brin, ci vengono a dire, non è più tempo per noi. E, non è certo un caso se a finire tra l’incudine e il martello delle più scellerate politiche industriali e finanziarie del management tedesco – che, detto qui solo per inciso, si è lasciato deliberatamente sfilare di mano anche gran parte delle sue più importanti quote di mercato interne e internazionali – non sono soltanto le condizioni di vita e di lavoro degli ultimi operai di quello che, a detta di tutti, è il più importante polo siderurgico italiano. Ad essere rimesse pesantemente in discussione da un’eventuale chiusura, più o meno preannunciata, delle acciaierie di viale Brin sono anche e soprattutto le stesse prospettive di sviluppo economico e finanziario dell’intero bacino produttivo territoriale che, come si sa, ruota ancora – indistintamente tutto – attorno alla centralità strategica dell’industria siderurgica. Per non parlare poi, qui, degli inevitabili effetti a catena che un fatto di questa portata verrebbe infine ad innescare anche a carico dello stesso sistema produttivo nazionale che, come sa bene chi con l’acciaio ci campa, è anche il principale consumatore mondiale di laminati magnetici.
Tutti, a questo punto, pensano al peggio. Noi no. L’insubordinazione operaia e lumpenproletaria del 29 e 30 gennaio scorso – giacché, che piaccia o meno, a fianco degli operai in lotta per la difesa del loro posto di lavoro c’erano anche ampi spezzoni di quello sterminato bacino di lavoro precario che, anche qui come altrove, un posto di lavoro certo e sicuro ancora non ce l’hanno tra le mani – non ci ripropone affatto le solite domande ricorsive di maggiore equità e giustizia sociale. Domande sacrosante e indiscutibili, sia ben chiaro, ma che, per loro stessa natura, si lasciano facilmente ricondurre all’interno del solito quadro di tutele e di garanzie date da tutti per scontate, ma che, a conti fatti, sono sempre più inaccessibili per la stragrande maggioranza del nuovo lavoro operaio.
Non ci si venga dunque a parlare di riassorbimenti a singhiozzo, di prepensionamenti fantasma o di ammortizzatori sociali da somministrare con il contagocce ai pochi – si fa solo per dire – fortunati. Parliamo invece di che fine andranno a fare gli operai dell’indotto, delle imprese contoterziste, di tutte quelle piccole e medie imprese che gravitano attorno alla acciaierie di viale Brin e che sono solite rimpolpare i loro lauti guadagni lucrando sui diritti dimezzati dei loro dipendenti. Dipendenti che, è inutile starlo a ricordare, il più delle volte non hanno alcun accesso a nessun tipo di copertura sociale. I tumulti di quei giorni e quelli dei giorni a seguire, i picchetti diuturni e il blocco di tutte le merci in uscita dalla fabbrica, i blocchi di tutte le principali vie d’accesso alla città non sono stati – ci è fatto l’obbligo di pensare – la cartina di tornasole di forme di lotta meramente difensive o di retroguardia. Lotte gradualistiche e destinate allo scacco. Lotte che puzzano ancora di anni cinquanta. Tutt’altro, e non potrebbe essere altrimenti.
Lo sappiamo bene. L’istante in cui scocca la freccia dell’essere, il punto temporale esemplare in cui si apre ogni nuovo ciclo di lotta (le dieci di mattina all’Hotel Garden, un tardo pomeriggio lungo la Terni-Orte, un altro ancora sotto le finestre di Palazzo Chigi, un giorno come un altro, ma lungo più di cinquant’anni, bloccati all’incrocio di viale Brin ad aspettare il corteo degli operai), un momento come questo dev’essere continuamente riaperto e alimentato da una soggettività costituente altrettanto esemplare e innovativa. Nuova, anzi nuovissima. E, se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, ad animare e a dar corpo a questo nuovo ciclo di lotte che attraversa e scompagina da capo a fondo ogni assetto politico e sindacale di questo territorio non sono più i vecchi operai di mestiere espulsi dalla fabbrica nel lontano ’53, attaccati come mitili alla professionalità del loro lavoro e finiti, sia pure loro malgrado, a fare i piccoli imprenditori o i commercianti al dettaglio. Niente affatto.
A bussare alle porte della città dell’acciaio, a reclamare reddito, lavoro e dignità per tutti e per ciascuno è una nuova razza operaia, una forza lavoro per la gran parte giovane e ad alta scolarizzazione, una rude razza pagana che – come avrebbe detto un vecchio compagno che ha un piccolo appezzamento di terra dalle parti di Ferentillo – è irriducibile ad ogni compromesso e mediazione. E quand’è così, si capisce, anche l’idea di disobbedire ai più timorosi incomincia a farsi strada da sé.
Giovani Comunisti/e
Movimento delle/dei Disobbedienti
|