|
|
Da RepubblicaMotori di Vincenzo Borgomeo
In Italia ci sono più supercar che stipendi pari al prezzo delle auto vendute: meno dell’1% degli Italiani dichiara più di 100 mila euro l’anno al fisco
Qualcosa non quadra: incrociando i dati di vendita delle vetture di lusso con le dichiarazioni dei redditi si scoprono dati incredibili. In un Paese dove lo scorso anno si sono vendute 620 Ferrari, 151 Lamborghini, 180 mila fra Mercedes, Bmw, Audi e un totale di 206 mila auto dal prezzo medio di 103 mila euro, solo 76 mila italiani (ossia, lo 0,18 per cento dei 41 milioni e 66.588 contribuenti, poco meno di due su mille) hanno dichiarato al fisco più di 200 mila euro lordi. Questo significherebbe che solo meno della metà di chi ha comprato una macchina di questa categoria – spendendo fra l’altro in un colpo solo tutti i soldi guadagnati in un anno – si sarebbe potuto permettere davvero una macchina del genere. Il discorso non cambia allargando la fascia dei potenziali clienti ai contribuenti che hanno denunciato al fisco più di 100 mila euro, cioè a quelle persone che avrebbero dovuto impegnare due anni di guadagni in una macchina: sono stati solo 382.662, meno dell’uno per cento del totale. Di questi, 218.198 (cioè ben oltre la metà) erano lavoratori dipendenti. Numeri impressionanti, che diventano ancora più incredibili se si vanno a fare i conti in tasca alle marche di lusso. E già perché l’Italia per questi produttori di sogni riveste un’importanza fondamentale: siamo il secondo mercato al mondo per vendite di Lamborghini e Ferrari, il terzo di esportazione per Mercedes e Bmw e il quarto per le Porsche. Siamo battuti (a seconda dei marchi e a volte di pochissimo…) solo da Paesi del calibro di Stati Uniti e Germania. Solo che la nostra ricchezza “ufficiale” non è minimamente paragonabile a quella di altri Paesi che comprano supercar a un ritmo di gran lunga inferiore al nostro.
Incrociando poi i dati di vendita con la produzione si ha un’altra – tragica – fotografia della nostra situazione: l’Italia è il secondo mercato europeo per acquisti di auto dopo la Germania. Da noi infatti si vendono più di due milioni di vetture l’anno ma se ne producono solo mezzo milione (nel 2008 erano state 659 mila e 910 mila nel 2007). Questo significa che oggi compriamo solo e non costruiamo quasi più: i nostri volumi di produzione sono inferiori di 7 volte ai 3,6 milioni della Germania, e la metà di quanto si produce in Francia e soprattutto in Spagna. Ma anche questo è strano: non si capisce che interesse ci possa essere in Italia a vendere tante macchine se – sempre secondo le dichiarazioni dei redditi denunciate dalle società concessionarie d’auto – il guadagno per ogni vettura venduta è di appena 50 centesimi…
di Naomi Wolf
Mentre il mondo lotta per uscire dal semi-collasso economico dello scorso anno, c’è un sottogruppo che è scivolato al di sotto della linea di galleggiamento: le donne che un tempo appartenevano al ceto medio.
Mentre il mondo lotta per uscire dal semi-collasso economico dello scorso anno, c’è un sottogruppo che è scivolato al di sotto della linea di galleggiamento: le donne che un tempo appartenevano al ceto medio. Secondo un’inchiesta recente, quest’anno in America un milione di queste donne comparirà davanti al tribunale fallimentare. Un numero superiore, dice l’economista Elizabeth Warren, a quello delle donne che «prenderanno la laurea, avranno una diagnosi di cancro o chiederanno il divorzio». La loro difficile situazione – sintomatica di una condizione comune nel mondo – contiene una lezione utile per tutte noi.
Queste donne rovinate sono più istruite dei loro omologhi maschi: la maggior parte ha fatto l’università, più della metà è proprietaria della casa dove vive. A farle cadere da uno stile di vita medio-borghese a redditi di poco al di sopra del limite di povertà sono stati verosimilmente tre fattori: due economici e uno emotivo.
In primo luogo, queste donne nuotano nei debiti. Molte hanno lavori che impongono di tuffarsi nelle linee di credito solo per stare a galla. Altre sono state bersagliate – e raggiunte – dai produttori di beni di lusso e dalle società che emettono carte di credito, che beneficiano del modo in cui la cultura di massa lega certi tipi di consumo – gli abiti all’ultima moda, la borsa-must della stagione, l’ultimo modello di auto sportivo – ai racconti di una femminilità di successo.
Questa pressione non è limitata agli Stati Uniti. Nuove classi medie stanno emergendo globalmente e riviste come Cosmopolitan e Vogue si rivolgono, con gli stessi identici beni di lusso, a donne dell’India e della Cina appena ascese socialmente – molte delle quali appartengono a una generazione che, per la prima volta nella storia delle loro famiglie, dispone di un suo reddito.
La seconda ragione di questa bancarotta femminile è che una legge del 2005 contrappone nei tribunali le donne – che non possono permettersi costosi pareri legali – ai gestori di carte di credito per stabilire chi venga primo nei pagamenti quando l’ex marito, mancando ai suoi doveri, nega sia l’assegno di mantenimento dei figli sia il saldo degli acquisti.
C’è poi un terzo fattore, di cui poco si parla: le attese emotive e le proiezioni sul denaro. Nel programma sulla leadership delle giovani donne cui io collaboro al Woodhull Institute, vediamo regolarmente che ragazze del ceto medio – in percentuale superiore a quelle della classe operaia – provano imbarazzo a parlare di denaro. Quando lo devono introdurre in un colloquio – per esempio con il loro datore di lavoro – si scusano con parole controproducenti. Sono restie a negoziare lo stipendio e raramente sanno come farlo.
Ritengono che chiedere del denaro in cambio del lavoro sia «poco femminile». Danno per scontato che lavorare il doppio degli altri – senza mai chiedere riconoscimenti del loro valore – porterà un aumento perché qualcuno di importante se ne accorgerà.
Queste giovani donne tendono anche ad avere un’idea poco realistica delle loro finanze. Spesso non si curano di risparmiare perché danno per scontato – ancora! – che a salvarle economicamente arriverà il matrimonio. Per loro l’acquisto di un paio di scarpe costose o un bel taglio dei capelli è un «investimento» per un futuro romantico. E non si preoccupano di fare piccoli investimenti mensili. Questo cliché è spesso vero anche per le borghesi più anziane, che non sanno gestire le finanze della famiglia, perché hanno sempre delegato ai mariti il compito di pagare contributi, mutui, tasse e assicurazioni. Così, in caso di divorzio o vedovanza, sono economicamente vulnerabili.
Paradossalmente, le donne della classe operaia (e quelle di colore) raramente si rifiutano di interessarsi alle questioni economiche. Secondo la nostra esperienza, esse tendono a padroneggiare l’abc delle finanze e imparano a negoziare il salario, perché non possono permettersi il lusso di aspettare un cavaliere su un cavallo bianco che arriva a salvarle economicamente.
Questo pragmatismo economico delle donne povere è la ragione del successo, nel mondo in via di sviluppo, del microcredito, che mette il denaro nelle mani femminili. Sarei sorpreso se le donne borghesi nel resto del mondo – cresciute considerando certe forme di ignoranza e ingenuità economica come socialmente appropriate – riuscissero, senza un duro apprendimento, a essere affidabili e accorte come quelle più povere dimostrano di essere.
«Financial intimacy», l’ultimo saggio di Jacquette Timmons, una talentuosa coach finanziaria, fornisce delle verità che sarebbero state preziose per qualunque donna della classe media ora in crisi: «Oggi molte guadagnano ben più delle generazioni precedenti. Questo però non ha prodotto un più alto grado di sicurezza economica». La colpa è del tabù di-soldi-non-si-parla. Le donne della middle class ovunque nel mondo lo supereranno quando noi tutte avremo capito che i soldi non sono mai solo soldi e che diventare economicamente preparate significa allontanarsi dal ruolo sociale assegnato alle donne: quello di persone educate, economicamente assenti, sottopagate e abbagliate dallo shopping. Tutte le altre tremende pressioni che le spingono alla rovina continueranno a esistere, ma almeno un numero crescente di loro le affronterà con gli occhi bene aperti e, si spera, con molte alternative migliori.
La riforma del Welfare targata Boeri, che piace tanto alla pseudosinistra
 Da cinque anni a questa parte l’insicurezza di reddito è diventata di moda. Il tabù di un tempo, guai a parlare di precarietà, è diventato trendy ed è tutto un fiorire di libri, articoli, film, opere teatrali che trattano dell’argomento. Da cinque anni a questa parte l’insicurezza di reddito è diventata di moda. Il tabù di un tempo, guai a parlare di precarietà, è diventato trendy ed è tutto un fiorire di libri, articoli, film, opere teatrali che trattano dell’argomento.
Finchè si tratta di operazioni commerciali non meritano risposte. Troppo il disgusto per chi traveste il marketing di ipocriti ‘scopi sociali’. Ma quando la paura del futuro e la competizione per il reddito, riguarda milioni di persone e a scriverne sono economisti del calibro del professor Tito Boeri, una risposta è d’obbligo.
Non fosse altro perché l’esimio docente della Bocconi, nonché editorialista della Repubblica, coordinatore del sito www.lavoce.info, è tenuto in grande considerazione da tutti quei soggetti politici e sindacali che ancora si sforzano di definirsi ‘riformisti’ o addirittura di ‘sinistra’. Le sue proposte trovano estimatori nella segreteria nazionale Cgil.
Il maggior pregio di ‘Un nuovo contratto per tutti’ di Boeri e Garibaldi, edito nel 2008 da Chiarelettere editore, è quello di svelare quali siano le idee di riforma del lavoro di un’ampia area delle elites italiane che puntualmente si tramutano in leggi, contratti e scelte di politica economica.
Prosegui la lettura »
 Se guardiamo alla congiuntura economica, il 2009 si chiude con segnali contrastanti. Se guardiamo alla situazione sociale, l’anno si chiude in modo tragico. Se guardiamo alla congiuntura economica, il 2009 si chiude con segnali contrastanti. Se guardiamo alla situazione sociale, l’anno si chiude in modo tragico.
Prosegui la lettura »
Il manifesto – 13 Dicembre 2009
INTERVISTA | di Cosma Orsi
Il modello dominante di attività economica, basato sulla finanza e sulla conoscenza, ha la sua genesi nella deregulation dei mercati e i suoi necessari corollari sono la privatizzazione dei servizi sociali e una flessibilità produttiva e del lavoro La compressione dei salari aggrava la crisi. Servono interventi mirati a garantire continuità di reddito, l’accesso alla formazione e all’apprendimento
La genesi della crisi attuale sta nella deregulation dei mercati finanziari degli anni Ottanta, che ha segnato il tramonto di un regime di accumulazione fondato sulla grande impresa, su un mercato del lavoro incentranto su un comprosmesso sociale tra lavoro e capitale. Da allora, il confine tra sfera produttiva e sfera finanziaria si è progressivamente dissolto e il capitale finanziario e la conoscenza sono divenute gli assi su cui far ruotare la produzione della ricchezza e, cosa più importante, a una precariazzazione dei rapporti di lavoro e una privatizzazione dei servizi sociali.
La tesi presentata in questa intervista da Andrea Fumagalli, che si aggiunge a quelle già pubblicate nella serie «il capitalismo invecchia?», cerca di individuare anche delle forme di resistenza al capitalismo cognitivo.
Le domande fondamentali a cui gli economisti cercano una risposta possono essere riassunte così: qual è la natura di questa crisi; è una crisi finanziaria o reale, ciclica o sistemica? Ha senso un confronto con la crisi del ’29?
La crisi economica attuale è una crisi sistemica e una crisi globale. È la crisi dell’intero sistema capitalistico così come si è andato configurando dagli anni Novanta del secolo scorso. Ha quindi senso un confronto con la crisi del ’29.
La maggiore analogia sta nel fatto che l’attuale crisi può essere definita, a differenza di quella degli anni Settanta, come «crisi di crescita». Essa trova i suoi prodromi agli inizi quando iniziano a configurarsi le caratteristiche del capitalismo cognitivo-finanziario e ha termine la fase di fuoriuscita dalla crisi del paradigma fordista-taylorista. La maggiore differenza sta nel fatto che il meccanismo di accumulazione e valorizzazione oggi dominante è strutturalmente diverso da quello industriale-fordista, fondato su una struttura sociale disciplinare, un modello omogeneo di organizzazione del lavoro (grande impresa, sfruttamento di economie statiche di scala, operaio-massa), sulla preminenza della produzione materiale manifatturiera e un meccanismo di sfruttamento centrato sull’estrazione di plusvalore relativo (sussunzione reale). Oggi, il sistema capitalistico si fonda su una flessibilità produttiva e del lavoro, sul ruolo centrale della conoscenza e dello spazio come fattori produttivi grazie alla diffusione delle tecnologie linguistico-comunicative, lo sfruttamento di economie dinamiche e sociali di scala (apprendimento e rete), l’allargamento della base produttiva anche alla riproduzione e al consumo, il peso crescente della produzione immateriale, la sussunzione totale della vita al capitale (accumulazione bioeconomica). Si tratta di cambiamenti che richiedono interventi di risoluzione alla crisi decisamente diversi da quelli sperimentati con il new-deal roosveltiano dopo il ’29.
Quanto ha giocato, nella loro incapacità di valutare la probabilità della crisi, la predilezione degli economisti mainstream per la formalizzazione matematica, a scapito della conoscenza della storia dell’analisi economica – e della storia in generale?
Molto, al punto che Roger Bootle, managing director di Capital Economics, uno dei più importanti centri di consulenza macroeconomica della City londinese, ha dichiarato che gran parte della moderna teoria economica «è un disastro e una disgrazia» (The Observer, 18 ottobre).
La scienza economica ha sempre rappresentato un «sapere» fondamentale per la gestione della governance politica e sociale. Essa è spesso stata presentata come «oggettiva» e «neutrale» e, a tale fine, la logica formale non si è limitata solo ad essere uno strumento di analisi ma è diventata anche «sostanza» con elementi autoreferenziali, con l’effetto di rendere i modelli teorici funzionali sì alla struttura di potere ma totalmente incapaci di leggere la dinamica del reale. Per quanto riguarda nello specifico i mercati finanziari, va registrata la crisi di gran parte delle teorie sviluppate negli ultimi quaranta anni e che sono alla base dell’operare di tali organismi; tali teorie hanno peraltro fruttato negli ultimi decenni tanti premi Nobel per l’economia a diversi tra i loro inventori. Nel 1997, il premio Nobel dell’Economia fu assegnato a R. Merton e a M. Scholes per lo sviluppo di «un nuovo metodo per la valutazione dei derivati» (modello di Black, Sholes, Merton). Nel 2003 il premio Nobel per l’economia è stato invece assegnato a R. Engle, e a C. Granger, per lo sviluppo di «metodi di analisi delle serie storiche economiche con volatilità variabile nel tempo», applicati poi ai mercati finanziari.
Da tempo commentatori autorevoli avevano fatto notare che la libera e frenetica circolazione dei capitali (risultato delle liberalizzazioni e deregolamentazioni della finanza) mina le basi stesse della democrazia economica, cioè della democrazia stessa. Ritiene che il ruolo della politica, oggi, dovrebbe essere soltanto quello di regolatore del mercato o dovrebbe spingersi più in là?
La libera circolazione dei capitali è l’esito della deregulation dei mercati finanziari e non a caso si sviluppa appieno negli anni Ottanta, quando comincia la transizione al capitalismo cognitivo. I mercati finanziari ne sono oggi il cuore pulsante.
Provvedono infatti, al finanziamento dell’attività di accumulazione, soprattutto nel caso delle produzioni cognitive immateriali (conoscenza e spazio). In secondo luogo, in presenza di plusvalenze, svolgono il ruolo di moltiplicatore dell’economia e redistribuzione, seppur distorta, del reddito. In terzo luogo sostituiscono lo stato come assicuratore sociale (canalizzazione forzata di parti crescente dei redditi da lavoro: tfr, previdenza, istruzione, salute).
Da questo punto di vista, i mercati finanziari rappresentano la privatizzazione della riproduzione della vita. Sono quindi biopotere. Infine sono il luogo dove si cerca di misurare, capitalisticamente, il valore della cooperazione sociale (di apprendimento e di rete) che sta oggi alla base dell’accumulazione. Sulla base di queste considerazioni, occorre prendere atto che non vi è più separazione netta tra sfera produttiva e sfera finanziaria. La transizione al capitalismo bioeconomico cognitivo è stata la reazione politica (sia conservatrice che di centro-sinistra), per uscire dalla crisi del capitalismo industriale-fordista degli anni ’70. È quindi chiaro che finché la politica oggi si limita a essere lo strumento di governance (meglio: il tentativo di governance) del capitalismo contemporaneo, parlare di regolazione dei mercati finanziari è del tutto fuori luogo e ipocrita. In tale contesto, parlare di democrazia è puro ideologismo. La democrazia (intesa, qui, come la supremazia della res pubblica/commonia sulla res oeconomica) è morta negli anni Settanta.
Molti ritengono che la soluzione della crisi non possa avvenire che sull’asse Washington – Pechino. È ipotizzabile che il modello europeo di stato sociale, se ancora di un modello europeo si può parlare, possa rappresentare un riferimento per politiche economiche alternative tanto al Washington Consensus, quanto al capitalismo di stato cinese? O c’è il rischio che nel futuro assetto economico-politico mondiale l’Europa (con il sud del mondo) venga confinata ad una posizione marginale?
La crisi attuale rimette in discussione l’egemonia finanziaria degli Stati Uniti. La fuoriuscita da questa crisi segnerà necessariamente uno spostamento del baricentro finanziario verso oriente e in parte verso il Sud (America). Già a livello commerciale, i processi di internazionalizzazione hanno sempre più evidenziato uno spostamento del centro produttivo verso oriente e verso il Sud del mondo.
In questa prospettiva, l’attuale crisi finanziaria mette fine a una sorta di anomalia che aveva caratterizzato la prima fase di diffusione del capitalismo cognitivo: lo spostamento della centralità tecnologica e del lavoro cognitivo verso India e Cina in presenza del mantenimento dell’egemonia finanziaria in Occidente. Il primato tecnologico e quello finanziario tendono a ricongiungersi anche a livello geo-economico. In tale contesto, cresce anche l’instabilità internazionale, dal momento che non sembra ravvisabile al momento una stabile gerarchia valutaria internazionale (un impero senza egemonia). In questa situazione di «contesa» l’Europa potrebbe giocare un ruolo fondamentale, ma è nelle condizioni di non poterlo fare, perché sconta il fatto di aver puntato esclusivamente sull’unione monetaria (primato della ragione economica sulla ragione sociale), senza preoccuparsi di creare le premesse per una politica europea fiscale con un budget autonomo dall’influenza degli stati-nazione membri. Non ci sono così gli strumenti per un intervento socio-economico coordinato in grado di poter attutire i contraccolpi della crisi economica. È un ulteriore sintomo del fallimento della costruzione economica dell’Europa.
L’attuale aumento della spesa pubblica non riguarda la spesa sociale (istruzione, sanità, pensioni e sussidi di disoccupazione), bensì il salvataggio di banche, società finanziarie e grandi gruppi. Ciò avviene però comprimendo i redditi da lavoro (salari reali e le pensioni): un intervento dal lato dell’offerta, anziché della domanda, è la giusta strategia per uscire dalla crisi, tornando a livelli accettabili di disoccupazione?
L’utilizzo della spesa pubblica ha la finalità di ristabilire la capacità di governance dei mercati finanziari. L’attuale crisi finanziaria mostra che non è possibile una governance istituzionale dei processi di accumulazione e distribuzione fondati sulla finanza. I tentativi di governance (ex-post) che sono stati varati nei mesi scorsi non sono in grado di incidere più tanto sulla crisi in atto. E non può essere diversamente, se si considera che la Bri (Banca dei Regolamenti Internazionali) stima il valore dei derivati in circolazione in circa 556 trilioni di dollari (pari a 11 volte il Pil mondiale). Nel corso dell’ultimo anno, tale valore si è ridotto di oltre il 40%, distruggendo liquidità per oltre 200 trilioni di dollari. Ciò ha significato distruzione reale di liquidità per circa 18 trilioni di dollari (dati Bri). Ora, gli interventi monetari di iniezione di nuova liquidità finora realizzati in tutto il mondo non superano i 9 trilioni di dollari: una cifra insufficiente per compensare le perdite. È tale differenza che spiega come mai, nonostante i tanti timori, non vi sia stato finora nessun effetto inflazionistico. La creazione di nuova moneta è finora inferiore a quella distrutta dalla crisi.
Tuttavia, a partire da giugno 2009, il calo del Pil tende ad arrestarsi. La compressione dei salari e dei redditi ha l’effetto di peggiorare la situazione di crisi. Bisognerebbe invece rivitalizzare la cooperazione sociale alla base dell’accumulazione odierna con interventi mirati a garantire continuità di reddito, accesso ai beni comuni relazionali, di formazione, di apprendimento (commonfare). Ma tali misure (che si traducono in una regolazione salariale basata sulla proposta di basic income e in una capacità produttiva fondata sulla libera e produttiva circolazione dei saperi) minano alla base la stessa natura del sistema capitalista, ovvero la ricattabilità del reddito dal lavoro e la violazione del principio di proprietà privata dei mezzi di produzione (ieri le macchine, oggi la conoscenza). In altre parole, un compromesso sociale (new deal) adeguato alle caratteristiche del nuovo processo di accumulazione è solo un’illusione teorica, ed è impraticabile da un punto di vista politico. Siamo dunque in un contesto storico in cui la dinamica sociale non consente spazio allo sviluppo di pratiche e soprattutto «teorie» riformiste. Ne consegue che, poiché è la praxis a guidare la teoria, solo il conflitto e la capacità di creare movimenti «dal basso» possono consentire – come sempre – il progresso sociale dell’umanità.
Quale sarà il prezzo che le future generazioni dovranno sopportare a fronte delle forme e delle dimensioni dell’indebitamento a cui oggi i governi hanno fatto ricorso nel tentativo di non far naufragare l’economia mondiale?
Il prezzo che le future generazioni dovranno sopportare è inversamente proporzionale alla loro capacità di mobilitazione e conflitto, oggi e nell’immediato futuro.
|
|





 Se guardiamo alla congiuntura economica, il 2009 si chiude con segnali contrastanti. Se guardiamo alla situazione sociale, l’anno si chiude in modo tragico.
Se guardiamo alla congiuntura economica, il 2009 si chiude con segnali contrastanti. Se guardiamo alla situazione sociale, l’anno si chiude in modo tragico.





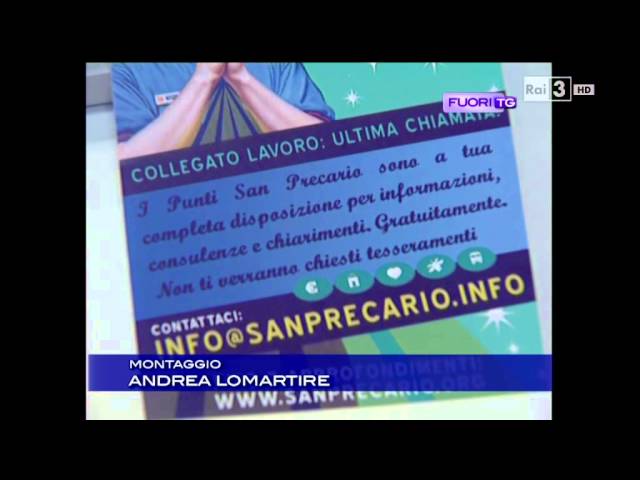









![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/ai/20180729152947im_/https://www.precaria.org/wp-content/uploads/valid-rss.png)
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](/ai/20180729152947im_/https://www.precaria.org/wp-content/uploads/valid-atom.png)