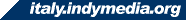La vita culturale in Iraq
All’inizio delle operazioni militari in Afghanistan nell’ottobre 2001, le immagini di donne col burqa erano diventate il simbolo di ciò che il paese non sarebbe più stato.
Quattro anni dopo, solo in alcuni quartieri di Kabul il burqa non è la divisa di ordinanza, mentre nel resto del paese la situazione è rimasta uguale, quando non è peggiorata sotto il comando dei “signori della guerra”.
Anche nell’Iraq si diceva che avrebbero soffiato i venti di libertà politica, sociale, intellettuale.
Quasi tre anni dopo la caduta di Saddam Hussein, nulla di ciò che si sognava si è realizzato.
Dopo l‘aprile del 2003, sembrava che tutto dovesse cambiare: la vita culturale veniva descritta come attiva e vivace, cinema e teatri riprendevano i loro spettacoli, la musica – quella antica, tradizionale, e quella nuova, mutuata dall’occidente – si diceva risuonasse per le strade.
Di questo desiderio di comunicare ne sono testimonianza alcuni libri pubblicati da artisti iracheni e stranieri collettivamente. Libri sull’arte, sulla poesia, sul teatro, sul cinema: sono soprattutto riflessioni sugli anni passati, sugli anni dell’embargo, sulla difficoltà di trovare anche i semplici materiali per poter lavorare – tele, colori, pellicole da film-.
Molti, per continuare a lavorare alle loro opere, sono fuggiti dall’Iraq, rifugiandosi prevalentemente in Libano, a Beirut.
“Parole di donne irachene”, di Inaam Kachachi, pubblicato anche in Italia, riflette, nei racconti di quindici scrittrici irachene, tutto questo. Ma non è l’unico libro, né l’unica testimonianza.
Nell’agosto del 2003, un comunicato stampa della Casa Bianca informava che la vita culturale irachena era in ripresa: “Le orchestre musicali e i teatri stanno riaprendo a Baghad”, diceva con soddisfazione Robert Blake.
Con molta fatica, gli intellettuali iracheni hanno cercato il loro posto nel “nuovo Iraq”, barcamenandosi tra le difficoltà burocratiche e quelle pratiche. Molti teatri e cinema erano stati distrutti (tra cui il Teatro Nazionale di Baghdad), e la loro ricostruzione non rientrava tra le priorità del governo.
In una intervista del gennaio 2004, l’allora Ministro della Cultura, Mufid Muhammad Jawad Al-Jaza'iri, interrogato su quanti fossero i fondi per la cultura, non aveva difficoltà ad ammettere che “ (…) la cifra è molto bassa. E’ un piccolo numero se lo paragonate ad altri ministeri, e questo è in qualche modo logico perché la cultura per molta gente - per molta gente nel governo -non è una priorità. Non pensano che la cultura sia una priorità o [ che ] sia una priorità urgente”.
L’unica soluzione, cercare i finanziamenti stranieri, che, soprattutto nella cinematografia, non si fanno attendere. Meno bene andrà per le altre forme di arte, meno esportabili.
Nonostante queste difficoltà, non sono stati pochi i gruppi di artisti che hanno cercato di risollevare la cultura.
Impresa non facile, per molti motivi.
Nonostante la dichiarazione della fine delle “operazioni principali”, le bombe non hanno mai smesso di cadere a Baghdad: “Abbiamo perso la sicurezza. Il pubblico è mentalmente esausto, come potrebbe guardare per due o tre ore una commedia?”. Così Khailil Ibrahim, del Teatro Nazionale di Baghad, nell’ottobre del 2004.
Funzionano abbastanza bene le matineé, ma è difficile che la gente vada a teatro la sera. Coprifuoco, assenza di elettricità, paura per gli attacchi nel buio. Uno dei primi spettacoli messo in piedi dopo la caduta di Saddam ha avuto fino ad 800 spettatori durante la festa di conclusione Ramadam. Dopo, il numero è sceso a 18, tanto da far togliere lo spettacolo dal cartellone.
Non ci vuole nulla a tirare una bomba in un teatro, dicono gli spettatori, e una granata costa tanto poco. Così piano piano muore il teatro, che pure era sembrato uno degli strumenti per combattere proprio quella paura. Persino per i bambini erano stati organizzati corsi teatrali, per insegnare loro a trasformare la paura in realtà, ed esorcizzarla.
Molto più facile, più sicuro, restare a casa. E’ il trionfo delle televisioni, non solo quelle straniere che trasmettono via satellite, ma delle televisioni locali e nazionali che nascono sotto l’egida di partiti ed associazioni.
Si contano, già nel 2003, numerose televisioni, prevalentemente espressione di partiti politici, e notevole fonte di propaganda.
Il programma più famoso è sviluppato sulla linea dei reality show: si chiama Terror in the Hands of Justice e lo trasmette la tv Al Iraqya, nata in Iraq con i fondi statunitensi, come anche la tv Al Hurryah. Nel programma, condotto in studio, si mostrano le confessioni estorte ai detenuti, spesso sotto tortura.
Non stupisce che, parlando di diritti umani, il Ministro competente arrivi a dire che non bisogna indignarsi più di tanto, poiché “la violenza è parte della nostra cultura, ormai”.
Il programma, lanciato nel 2004, ha tenuto banco per tutta la durata della sua programmazione. In assenza di indici di rilevamento internazionali, ci si basa su quelli “casalinghi”, ma sembra certo che tra le nove e le dieci di sera questo sia il programma più seguito a Baghdad.
Il successo del reality delle torture ha stimolato a cercare altri temi da trattare con lo stesso spirito: è nato così Chaif Kheir (Nozze benedette) trasmesso dalla Tv Al-Sharqiya, nata nel giugno 2004, di proprietà dell’editore del quotidiano iracheno (ma edito a Londra) Az-zaman.
Qui non ci sono le torture visibili nel reality di Al Iraqya, ma la violenza è sempre sullo sfondo.
Il tema è semplice: una coppia di futuri sposi viene accompagnata fino al matrimonio, filmando tutto quello che succede loro nel periodo che lo precede. La prova dell’abito che viene spostata perché il negozio è stato colpito da una bomba, il ricevimento prima delle nozze fatto in casa perché uscire è pericoloso, la scelta dei mobili, la lista di nozze.
In cambio del consenso ad essere filmati, i protagonisti si vedranno pagare le spese del loro matrimonio, nonché l’arredamento della casa, dalla produzione.
Prima ancora, era stata trasmessa un’altra serie di reality, “Labor and Materials”, episodi di 15 minuti in cui le case distrutte di famiglie troppo povere per ricostruirle vengono rimesse a nuovo, piano piano, in sei settimane.
I telespettatori vedono così crescere le mura, riparare le finestre, restituire gli arredi.
A pagare i costi, quelli che in occidente verrebbero chiamati “sponsor”, ma che in Iraq sono imprenditori che fanno donazioni, e le donazioni contano come zakat, che corrisponde alla percentuale di reddito che annualmente ogni musulmano deve dare alla carità.
Alla stazione televisiva sono arrivate circa 3000 domande da famiglie irachene che sognano di vedere la loro casa ricostruita. In molti casi, si decidono a scrivere dopo aver provato di tutto: dalle richieste alla municipalità, a quelle al governo, persino agli Stati Uniti.
Non ci sono solo i reality, nella tv irachena. Si producono anche serie televisive, come “Al- Hawasin”, trasmesso sempre da Al-Sharqiya . Venti episodi, per un costo totale di 100.000 dollari, per vedersi raccontare la stessa violenza che ogni iracheno può vedere appena esce di casa.
Molto spazio è dato alla musica, con le esibizioni di star libanesi, egiziane, ma anche star irachene in esilio. Negli ultimi tempi, sono i programmi finiti nel mirino degli estremisti: troppo poco vestite le donne, troppo leggeri i testi delle canzoni, e troppo forse anche l’idea stessa di canzone.
Proprio l’estremismo islamico è stata la causa della chiusura di molte attività ricreative: i negozi di alcolici, gestiti prevalentemente da cristiani, sono stati oggetto di attacchi anche mortali; la stessa sorte tocca adesso ai negozi di dischi, colpevoli di vendere musica “occidentale” e “impura”. Vietate le sale da ballo in molte città irachene.
Per molti intellettuali iracheni, la sensazione è che ad una censura, quella di Saddam, se ne sia sostituita un’altra, spesso peggiore.
La situazione non è uguale in tutto l’Iraq, e varia da città a città: là dove sono forti e indisturbate le milizie islamiche, qualsiasi espressione di dissenso è punita, al punto di arrestare – anche se per poche ore- dei giovani colpevoli di indossare jeans. E’ accaduto a Najaf, era il luglio 2005.
Le culture giovanili sono le più colpite da questa nuova censura: nell’abbigliamento, nella musica, nelle espressioni artistiche, in tutto c’è qualcosa che può essere considerato “nocivo”.
Durante gli anni di Saddam Hussein, la musica moderna era tollerata, e lo stesso Uday Hussein, uno dei figli del leader, ne era portavoce. La stazione radiofonica da lui ideata (Voci della gioventù) ha trasmesso il meglio e il peggio della musica occidentale, dai R.E.M a Eminem, e persino nelle strade era possibile vedere esponenti iracheni della breakdance esibirsi.
Oggi resiste la musica tradizionale irachena, che ha anche molti estimatori all’estero – il maqam è stato di recente dichiarato “patrimonio dell’umanità" - anche se nei piccoli negozi di dischi è possibile ancora recuperare la musica straniera.
Un sito, nato nel 1997 -iraq4u.com – si pone come obiettivo quello di conciliare queste due diverse esigenze: la tradizione irachena, con i suoi massimi cantori, e la nuova musica, irachena e straniera.
Se una rinascita c’è stata, ha coinvolto sicuramente il cinema, che è stato il settore economicamente più aiutato.
Il cinema iracheno, che vede la sua nascita ufficiale nel 1945, con la creazione del “Centro di documentazione del teatro e del cinema” , ha avuto per lungo tempo un partenariato con gli altri paesi arabi, senza mai arrivare a produzioni eclatanti.
Dal 1975, quando la produzione cinematografica e teatrale viene separata da quella musicale e radiofonica, inizia uno sviluppo coerente della filmica irachena, sovvenzionata sia privatamente sia statalmente.
Pesa sempre la situazione di una assenza di democrazia, e dell’adesione ad un patriottismo spesso di maniera che svuota le sale anziché riempirle. Negli anni dell’embargo la produzione cinematografica diminuisce sensibilmente, poiché in questo settore l’assenza di materie prime si fa sentire più che nelle altre arti.
E’ comprensibile che, alla caduta di Saddam, sia il cinema a nutrire le migliori speranze per un suo futuro diverso: le immagini colpiscono più delle parole, i finanziatori abbondano, tutti i festival più importanti sono pronti a contendersi le produzioni locali.
Non tutto quello che esce in questo periodo è degno di nota. Anche nel cinema, ad una propaganda se ne sostituisce un’altra: è il caso di “Voices of Iraq”, una coproduzione statunitense, che sulla carta dovrebbe raccontare l’Iraq del dopo Saddam, e che su pellicola riesce solo a trasmettere sentimenti filo-americani.
Stesso giudizio per WDM, prodotto anch’esso nel 2004, che ancora tenta di accreditare l’idea che la guerra sia stata fatta a causa del possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, nonostante fosse già noto, quando il documentario è stato girato, quanto questa ipotesi fosse errata.
C’è da considerare che molte istituzioni “indipendenti” del nuovo cinema iracheno sono in realtà finanziate dagli Stati Uniti, come ad esempio FilmIraq, che ha la sua sede a Washington, ma che si presenta come istituzione libera e in cerca di finanziamenti.
Va molto meglio per altre coproduzioni, in particolare per con Francia e Germania, che non a caso sono i paesi europei che si sono opposti alla guerra. A poco a poco al modello del documentario, teso a raccontare in maniera che si vorrebbe imparziale – ma è difficile – l’attuale Iraq e la guerra in corso, si sostituisce il modello del racconto, con poche e sincere storie di amore e di vita quotidiana.
Ma per i cineasti iracheni non è facile ancora raccontare la loro vita, ed è quasi impossibile girare film in Iraq.
Un progetto iraqo-tedesco, il Filmclub Berlino-Bagdad, voluto tra gli altri dal regista iracheno Oday Rasheed, autore del primo film del dopo Saddam, Underexposure, si è bloccato pochi mesi dopo la sua nascita.
Sul sito del progetto, si legge della difficile situazione attuale in Iraq, e si rimanda a tempi migliori.
Nella cultura come nel resto delle strutture irachene, la ricostruzione è ancora un’illusione.
Liberazione, aprile 2006
|