|
|
Sblilanciamoci.info – 2 luglio 2013
All’introduzione di un reddito di base dovrebbe accompagnarsi quella di un salario minimo. Pubblichiamo un testo estratto dall’ultimo libro di Andrea Fumagalli, “Lavoro male comune”
Perché le forze sindacali e non liberiste (queste ultime più propense allo smantellamento e alla privatizzazione di ogni intervento di welfare) sono perplesse e poco propense a inserire misure di reddito di base incondizionato nel proprio programma di governo. Che la proposta di un welfare fondato su un unico intervento di sostegno al reddito venga ritenuta politicamente inaccettabile dalla classe imprenditoriale non stupisce più di tanto, anche se, (….), garantire un reddito stabile aiuterebbe la crescita della produttività e della domanda di consumo (quindi, in ultima analisi, anche del profitto). Il vero problema è che una regolazione salariale basata sulla proposta di reddito di base incondizionato (magari unita a un processo di accumulazione fondato sulla libera e produttiva circolazione dei saperi) mina alla base la stessa natura del sistema capitalista, ovvero la necessità del lavoro e la ricattabilità di reddito come strumento di dominio e controllo, oltre alla violazione del principio di proprietà privata dei mezzi di produzione (ieri le macchine, oggi la conoscenza).
Se il diritto al lavoro viene sostituito dal diritto alla scelta del lavoro, la maggior libertà che ne consegue può assumere connotati eversivi e potenzialmente sovversivi.
La posizione contraria a qualsiasi proposta di reddito di base da parte dei sindacati deriva invece da due principali fattori: da un lato, buona parte del sindacato italiano (non solo quello confederale ma anche quello di base) è ancora fortemente imbevuta dell’etica del lavoro e accetta difficilmente di dare un reddito a chi non lavora, soprattutto se incondizionato e non finalizzato all’inserimento lavorativo; dall’altro, viene visto con preoccupazione il fatto che il reddito di base possa influire negativamente sulla dinamica salariale (effetto sostituzione) e ridurre gli ammortizzatori sociali.
Riguardo al primo punto, la posizione dei sindacati, non dissimile da quella delle controparti, rispecchia il ritardo – sia culturale sia politico – con cui le forze sociali prendono atto dei cambiamenti intervenuti nel passaggio dal capitalismo fordista al biocapitalismo cognitivo. L’idea che bisogna guadagnarsi il pane con il sudore della propria fronte rispecchia proprio quell’ideologia del lavoro di cui abbiamo discusso nel primo capitolo, sino a declinarsi nella “falsa” parole d’ordine di “lavoro bene comune”.
Il secondo punto pone invece una questione più importante. Il rischio che l’introduzione di un reddito di base possa indurre una riduzione dei salari è effettivamente reale. Per questo una simile misura deve essere accompagnata dall’introduzione in Italia di una legge che istituisca il salario minimo, ovvero stabilisca che un’ora di lavoro non può essere pagata meno di una certa cifra, a prescindere dal lavoro effettuato. Inoltre, occorre anche considerare che la garanzia di reddito diminuisce la ricattabilità individuale, la dipendenza, il senso di impotenza di lavoratori e lavoratrici nei confronti delle imprese. Richiedere un reddito minimo è la premessa perché i precari, i disoccupati e i lavoratori con basso salario possano sviluppare conflitto sui luoghi di lavoro. Oggi il ricatto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto, senza nessun tipo di tutela, è troppo forte. Il reddito, unito a garanzie contrattuali dignitose e a un salario minimo, renderebbe tutti meno ricattabili e quindi più forti. E permetterebbe di chiedere il miglioramento delle proprie condizioni lavorative e contrattuali.
Infine, in tema di ammortizzatori sociali, è necessario prendere atto che attualmente essi sono del tutto inadeguati e iniqui. Ad esempio, solo un quarto di chi è realmente disoccupato possiede i requisiti per accedere al sussidio di disoccupazione: ovvero, avere lavorato 52 settimane negli ultimi due anni e aver pagato i relativi contributi. Tali parametri sono diventati un lusso che la maggior parte dei lavoratori precari non è in grado di garantire. L’indennità di mobilità viene invece applicata solo ai lavoratori che escono da una situazione di cassa integrazione.
A sua volta, le diverse forme di cassa integrazione esistenti (ordinaria, straordinaria e in deroga) sono applicate in modo diverso e selettivo a seconda del settore dell’impresa, della dimensione, delle qualifiche, con l’effetto di creare pesanti discriminazioni sul suo utilizzo. Immaginare un unico ammortizzatore sociale a carico della fiscalità collettiva, uguale per tutti, che vada progressivamente a sostituire quelli vecchi, sembra ragionevole, anche perché consentirebbe di ridurre quel cuneo fiscale sul lavoro rappresentato dai contributi sociali a favore di un maggiore salario in busta paga.
Riassumendo, la proposta di un reddito di base incondizionato come strumento di remunerazione di quella produzione sociale e valorizzante che oggi sfugge alla regolamentazione del lavoro si fonda su quattro parametri non emendabili. Il primo requisito è l’individualità, dal momento che il lavoro è tendenzialmente individuale, anche se poi fa riferimento a una cooperazione sociale e a beni comuni come la conoscenza.
Il secondo parametro è la garanzia di continuità nella distribuzione del reddito, che deve essere erogato a tutti coloro che operano in un territorio, a prescindere dalla cittadinanza, dal sesso, dalla religione. Il tema della residenzialità è delicato, perché fa riferimento al concetto di cittadinanza, fondato sull’idea di ius soli o ius sanguinis. In Italia e in buona parte d’Europa il concetto di cittadinanza è fondato sullo ius sanguinis, per cui un figlio di immigrati nato in Italia non ha automaticamente la cittadinanza italiana in quanto il diritto di sangue prevale sul diritto di suolo. Ne consegue che il requisito della cittadinanza deve essere sostituito da quello della residenzialità.
Il terzo parametro è quello dell’incondizionalità: garantire continuità di reddito significa garantire continuità di remunerazione di un’attività produttiva (diretta o indiretta che sia) di ricchezza già svolta e quindi non richiede in cambio alcuna ulteriore contropartita. Garantire continuità di reddito a prescindere dalla condizione lavorativa non è quindi una misura assistenziale. Il quarto parametro consiste nel finanziamento del reddito di esistenza sulla base della fiscalità sociale progressiva (cioè un aumento dell’aliquota al crescere dello scaglione di reddito).
È questo il punto principale, poiché dalle forme di finanziamento dipende la natura compatibile o non compatibile del reddito di esistenza in un ambito di capitalismo cognitivo. A partire dal 2012, su questi temi si è sviluppata in Italia una campagna dal basso che raccolto le 50.000 firme necessarie per portare in parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare a favore dell’introduzione di un reddito minimo garantito.
Si tratta di un risultato non scontato nell’attuale situazione politico-culturale dell’Italia e che fa ben sperare per il futuro.
Di fatto ciò significherebbe modificare l’art. 1 della costituzione italiana. Non più «l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro», bensì: l’Italia è una repubblica fondata sul diritto di scelta del lavoro.
 Quello che sta per iniziare è un mese di assoluto rilievo per ciò che concerne la lotta alla precarietà. Andiamo in ordine. Quello che sta per iniziare è un mese di assoluto rilievo per ciò che concerne la lotta alla precarietà. Andiamo in ordine.
Il 9 di aprile ci sarà l’iniziativa “Il nostro tempo è adesso”, indetta da una serie di associazioni e realtà precarie e spalleggiata con forza dalla Cgil che ha messo a disposizione i suoi mezzi e le sue strutture. Dal 15 al 17 a Roma si terranno gli Stati generali della precarietà, patrocinati da San Precario, l’icona pop dei precari e delle precarie. Gli Stati generali giungono alla terza edizione è sono l’espressione più verace delle lotte autorganizzate dei precari e delle precarie. È una grande fucina di idee che riunisce comitati, realtà in lotta, gruppi grandi e piccoli, e una miriade di precari e precarie che si muovono più o meno coordinati a partire dal lavoro, dal sociale o dalla rete.
Prosegui la lettura »
 - La sfida del sindacato moderno
Storia Bilaterale
La vita degli enti bilaterali è una lunga storia che secondo alcuni studiosi, getta le sue radici nella seconda metà dell’Ottocento, con la nascita delle Società di Mutuo Soccorso.
Nate come associazioni volontarie con lo scopo di ottimizzare le condizioni dei lavoratori ed accrescerne i diritti, tali società si basavano sulla solidarietà dei loro appartenenti ed erano intimamente legate al territorio in cui nascevano. Esse si fondavano sulla comunione delle forze per il raggiungimento del progresso materiale e morale dei ceti dei lavoratori e maturavano nell’esigenza di affrontare quelle situazioni di sfruttamento a cui le istituzioni politiche sembravano incapaci di mettere fine. Si trattò di un esperimento di protagonismo civile che vide tra i suoi primi protagonisti gli ambienti ecclesiastici, il cui impegno morale di fondo non poteva restare cieco di fronte a problematiche del genere, pur conservando un certo carattere legato più al concetto di elemosina. Non ci interessa in questa sede approfondire tali argomentazioni, ma ci limiteremo a segnalare come da un primitivo paternalismo assistenziale si sia passati nel corso dei secoli alla nascita di un vero e proprio stato sociale, impegnato in interventi pubblici tesi a fornire servizi indifferenziati a garanzia dei cittadini. Le società di mutuo soccorso costituirono una primitiva forma di previdenza collettiva, che offriva ai suoi associati in cambio del pagamento di una quota più o meno irrisoria. In realtà, vi sono delle differenze tra le due esperienze, ma un possibile filo conduttore si può rinvenire nel tentativo di sopperire alle carenze dello Stato per fornire un primitivo apparato di difesa ai lavoratori.
Bilateralismo contro antagonismo
La bilateralità si presenta come una dinamica di evoluzione delle prassi relative al modo di concepire le relazioni industriali, e si attua nel momento in cui si sceglie di superare le eventuali tensioni antagonistiche e di concentrarsi sul livello della condivisione degli interessi. La prerogativa di un tale approccio è il dialogo tra le parti sociali, pur sempre nel quadro di una serie di regole condivise e definite. Condizione necessaria affinché ciò si realizzi è il rispetto del principio della pariteticità, caratteristica propria di quasi tutte le forme bilaterali, in quanto devono essere rispettati l’apporto e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
Gli organismi bilaterali, costituiti da soggetti che sono controparti nel sistema di relazioni industriali, si presentano con una varietà che è direttamente proporzionale alla eterogeneità e complessità dei compiti che devono assolvere.
Cosa fanno oggi gli enti bilaterali?
Al giorno d’oggi, gli enti bilaterali svolgono sul territorio una serie di funzioni: dall’integrazione del reddito nei periodi di sospensione del lavoro a favore dei lavoratori licenziati alla formazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori e gli imprenditori; dall’integrazione alle prestazioni economiche spettanti in caso di malattia, infortunio e maternità all’assistenza e sostegno per soddisfare particolari bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, fino ad arrivare all’assistenza per le vertenze in materia di lavoro. Tali enti hanno una derivazione contrattuale, in quanto sono stati istituiti ed inseriti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Essi rappresentano uno strumento di attuazione ed amministrazione del contratto collettivo in aree e settori produttivi nei quali la parte datoriale è frammentata ed è soggetta ad un alto tasso di variabilità, con conseguente frammentazione e variabilità della rappresentanza dei lavoratori. Difatti, l’esperienza della bilateralità ha riguardato per lo più alcuni settori, vale a dire quello dell’edilizia, del commercio, dell’artigianato e del turismo, in cui le rigidità di un’impostazione tradizionale del sindacato si sarebbero fatte sentire.
Bilaterali per legge
Giurdicamente gli enti bilaterali vengono considerati associazioni non riconosciute e in quanto tali disciplinati dal Codice Civile. In realtà possono essere configurati come enti di fatto, dotati di autonomia ed idonei ad essere titolari di rapporti giuridici propri, distinti dai soggetti che ad essi hanno dato vita e da coloro ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni che ne costituiscono gli scopi. Tutte la società democratiche presentano una qualche forma di sistema bilaterale, proprio perché la crescita della partecipazione permette la stabilizzazione della democrazia. In questo modo essi diventano uno strumento di politica industriale e provvedono a vigilare sul rispetto della contrattazione categoriale.
Tra progresso e corporativismo
Il fenomeno del bilateralismo nelle relazioni industriali costituisce una delle realtà più attuali del nostro sistema. A tal proposito, alcuni non possono fare a meno di considerare gli enti bilaterali come un modo grazie al quale i sindacati potrebbero recuperare le proprie funzioni, accettando le sfide del postfordismo, mentre per altri essi non sono altro che una riproposizione sotto nuove forme delle corporazioni di lavoratori e imprese istituite durante il regime fascista. La crisi economica, i cambiamenti in atto, si sono ripercossi sul modo di fare sindacato riproponendo l’urgenza di un modello di dialogo partecipato, un modello non più conflittuale e rivendicativo, ma, per l’appunto, partecipativo. I punti di forza della bilateralità concepita in questo senso si riconoscono nella conoscenza del territorio, nel coordinamento tra le forze, nella concertazione sociale ed istituzionale e nella collaborazione tra le parti sociali e gli enti di controllo, seppur nella reciproca autonomia e secondo quello che deve essere il loro ruolo.
Nuovo welfare: sussidiarietà neocorporativa
Il sistema di welfare andrebbe ripensato tenendo conto di una logica partecipativa e solidaristica che preveda il coinvolgimento di soggetti intermedi che si occupino della governance di prestazioni e servizi alle imprese ed ai lavoratori garantendo forme aggiuntive di sostegno e protezione in nome della sussidiarietà. Su un altro versante, la bilateralità viene, invece, vista come una regressione che potrebbe comportare una eccessiva implicazione dei sindacati con il mondo aziendale, fattore che ne corromperebbe la naturale natura universalistica e conflittuale. Inoltre, gli enti bilaterali non riescono a risolvere il problema di tutte quelle categorie che non si sentono rappresentate dal sindacato perché inquadrate in forme contrattuali atipiche ed in settori non tradizionali.
I sindacati confederali hanno manifestato maniere diverse di concepire l’esperienza della bilateralità. Mentre Cisl e Uil tendono a riconoscervi un nuovo modo di fare sindacato in un mercato che si presenta, per sua natura costitutiva, estremamente frammentato, la Cgil ha manifestato alcune perplessità. Una generalizzazione del modello bilaterale avrebbe come effetto l’eliminazione del conflitto e la svalutazione del peso della contrattazione collettiva.
Relazioni industriali: riforma post Pomigliano
I sindacati da interpreti del conflitto sociale e da soggetti di rappresentanza degli interessi collettivi, verrebbero trasformati in semplici erogatori di servizi, privati di qualsiasi autonomia. Tale esperienza andrebbe vissuta come un’opportunità nel contesto di una concezione moderna e pragmatica di relazioni industriali, ma il modello partecipativo non dovrebbe mai escludere il modello conflittuale/contrattuale e ciò perché gli spazi ed i ruoli di gestione che competono agli enti bilaterali dovrebbero restare nettamente distinti da quelli che sono i compiti di rappresentanza e contrattazione che competono alle parti sindacali. Gli enti bilaterali dovrebbero rimanere l’emanazione di una contrattazione a cui non devono sostituirsi, anche per evitare che questo strumento burocratizzi eccessivamente il sindacato.
La bilateralità permette di avvicinare il mondo delle aziende a quello sindacale, ma ciò non dovrebbe avvenire invadendo campi che sono propri di altre funzioni. Difatti, restano aperte tutta una serie di problematiche: l’intercettazione dei nuovi attori del mercato del lavoro, il possibile svuotamento dei diritti universalistici sanciti dallo Statuto dei Lavoratori, l’ambigua connivenza dei sindacati col mondo delle imprese, per citarne solo alcuni. Inoltre, il campo di interesse e di azione degli enti bilaterali si sta estendendo sempre più dalle politiche passive a quelle attive del lavoro in quanto tali enti stanno conquistando spazi sempre nuovi, anche estranei alla loro storia di partenza, adeguandosi alle pieghe del sistema e configurandosi sempre più come possibili protagonisti di politica industriale.
 Con questo articolo inizia una serie di reportage dal nostro inviato in California. Potete seguirlo anche su Twitter. Con questo articolo inizia una serie di reportage dal nostro inviato in California. Potete seguirlo anche su Twitter.
Come introduzione ai movimenti che organizzano i lavoratori/trici dal basso mi sono letto questo Working for justice. The L.A. model of organizing and advocacy e poi sono andato a pranzo con Josh, uno degli autori. I capitoli del libro sono stati scritti in collaborazione con gli stessi attivisti, e sono focalizzati in particolare sul modello del worker center, cioè piccoli centri territoriali o di settore, forme ibride tra minisindacati e movimenti di base, che supportano i lavoratori e le loro lotte. In molti casi si tratta di lavoratori migranti, soprattutto latinos e coreani che formano la spina dorsale della forza lavoro losangelina. Si va dalla famosa KIWA, l’alleanza dei lavoratori di Koreatown, alle lotte di Justice for Janitors, fino a tassisti, lavoratori del tessile e degli autolavaggi.
Prosegui la lettura »
 La vicenda di Pomigliano d’Arco pone delle questioni ineludibili per le forze di sinistra, sul piano sindacale come sul piano politico. La vicenda di Pomigliano d’Arco pone delle questioni ineludibili per le forze di sinistra, sul piano sindacale come sul piano politico.
Prosegui la lettura »
|
|






 Con questo articolo inizia una serie di reportage dal nostro inviato in California. Potete seguirlo anche
Con questo articolo inizia una serie di reportage dal nostro inviato in California. Potete seguirlo anche 






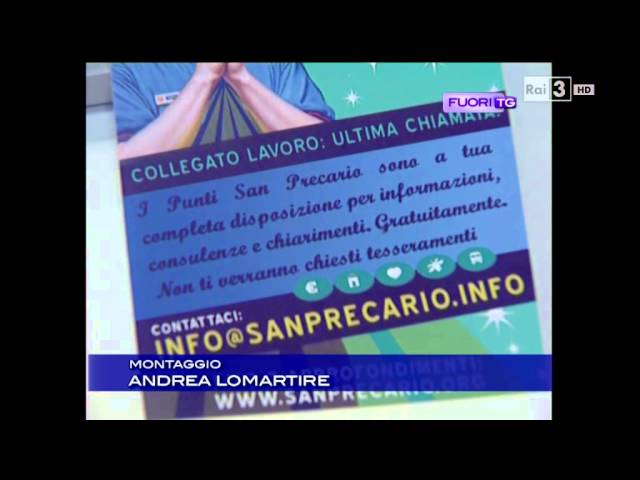









![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/ai/20210620161937im_/https://www.precaria.org/wp-content/uploads/valid-rss.png)
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](/ai/20210620161937im_/https://www.precaria.org/wp-content/uploads/valid-atom.png)