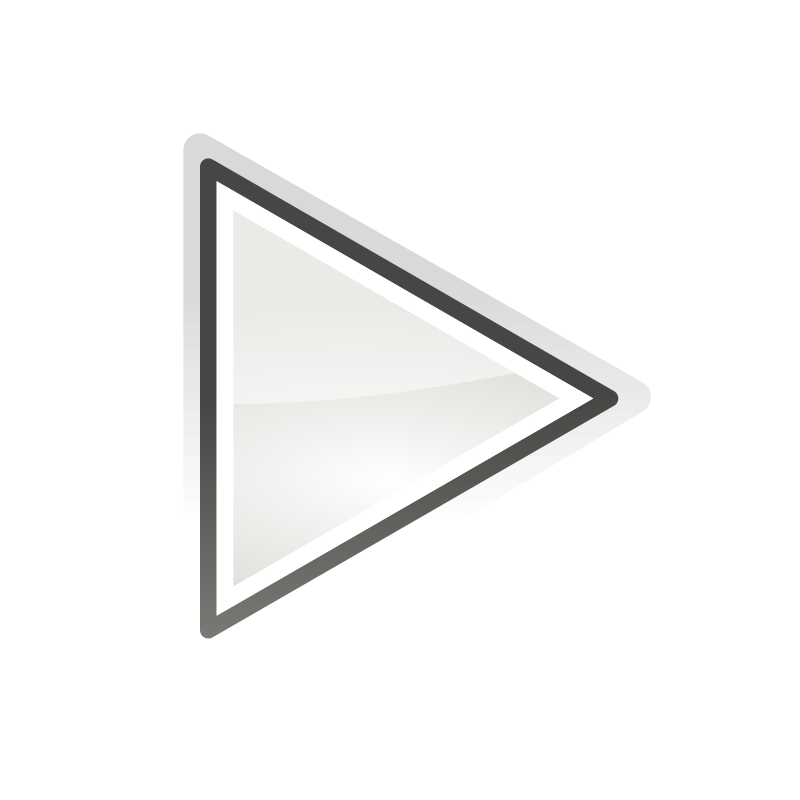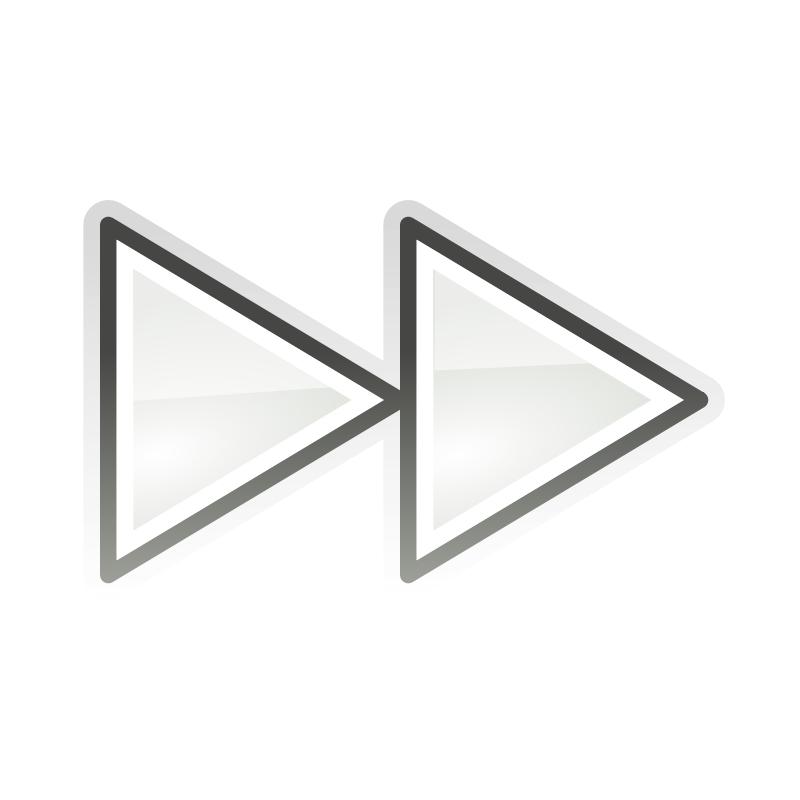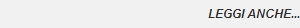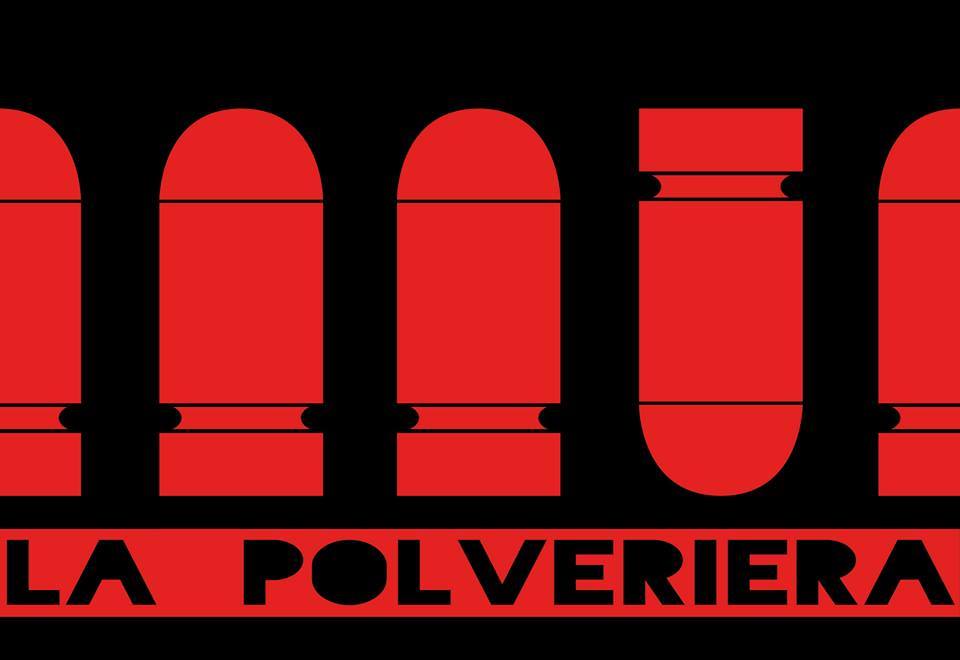Dopo l’Onda: riflessioni sulle traiettorie del movimento universitario
 Le mobilitazioni studentesche del 2008 e del 2010 contro la riforma Gelmini hanno prodotto un salto di qualità nel dibattito e nelle pratiche del movimento studentesco rispetto al ciclo di proteste che nel 2005 aveva accompagnato la riforma Moratti. Se la difesa del «diritto allo studio» e un’alleanza trasversale tra studenti-ricercatori-docenti per un’astratta salvaguardia dell’università pubblica erano state le caratteristiche del ciclo del 2005, con il movimento dell’«Onda» si è riconosciuto che la crisi finanziaria scoppiata proprio nel 2008 e i pesanti tagli all’istruzione previsti dalla finanziaria di Tremonti e dall’ancillare riforma della Gelmini erano strettamente connessi: sono le altalenanti dinamiche di valorizzazione del capitale a determinare ciò che avviene nel mondo della formazione.
Le mobilitazioni studentesche del 2008 e del 2010 contro la riforma Gelmini hanno prodotto un salto di qualità nel dibattito e nelle pratiche del movimento studentesco rispetto al ciclo di proteste che nel 2005 aveva accompagnato la riforma Moratti. Se la difesa del «diritto allo studio» e un’alleanza trasversale tra studenti-ricercatori-docenti per un’astratta salvaguardia dell’università pubblica erano state le caratteristiche del ciclo del 2005, con il movimento dell’«Onda» si è riconosciuto che la crisi finanziaria scoppiata proprio nel 2008 e i pesanti tagli all’istruzione previsti dalla finanziaria di Tremonti e dall’ancillare riforma della Gelmini erano strettamente connessi: sono le altalenanti dinamiche di valorizzazione del capitale a determinare ciò che avviene nel mondo della formazione.
Lo slogan dell’Onda, «noi la crisi non la paghiamo», alludeva compiutamente a questo intreccio, come l’aspirazione a un collegamento col mondo del lavoro (ricercato negli incontri con i delegati FIOM e COBAS, nelle visite ai lavoratori di Mirafiori e ai lavoratori Alitalia e nell’attraversamento degli scioperi generali delle diverse sigle) mirava a una conseguente generalizzazione delle lotte.
L’insufficienza di una rivendicazione circoscritta al solo «diritto allo studio» è apparsa chiara a un’analisi approfondita del ciclo di riforme avviato dal socialista Ruberti all’inizio degli anni ’90 e proseguita poi da Berlinguer e Zecchino per il governo di centro-sinistra, fino a Moratti e Gelmini per il centro-destra: tutte queste riforme sono da intendere come tentativi di sincronizzare l’intero ciclo della formazione con le trasformazioni sociali e con le mutate esigenze del sistema produttivo.
E’ dal 1968, con la riforma Gui, che le classi dirigenti si sono poste il problema, invece che chiudere le porte dell’università, di come mettere al proprio servizio un’università che vedeva progressivamente aumentare le richieste di accesso. Un uso privato dell’università, più che una privatizzazione vera e propria: i soldi è meglio se continua a metterli lo Stato. Gli esiti di questo tentativo sono stati alterni fino agli anni ’90; poi, sulla spinta del «processo di Bologna» (un accordo del 1999 tra i Ministri dell’Istruzione di trenta paesi dell’UE per l’armonizzazione dell’istruzione superiore in Europa), hanno profondamente condizionato la natura della didattica, della ricerca e del ruolo dell’università italiana.
Il modello scelto doveva rafforzare la produttività, didattica e finanziaria, degli atenei, portando il numero dei laureati in linea con le medie europee, dando una maggior varietà di percorsi formativi agli studenti, avvicinandoli agli sbocchi sul mercato del lavoro, attraverso una maggiore autonomia nelle scelte didattiche che ogni singola università (al cui interno era instituito un consiglio d’amministrazione composto al 40% da rappresentanti delle imprese e degli enti locali) poteva compiere.
Come gli indici sulla disoccupazione giovanile (superiore al 30%) e le statistiche di Almalaurea indicano, è in corso una precarizzazione dei laureati, in base alla quale i laureati da una parte tendono in misura crescente a occupare i posti di lavoro normalmente a disposizione dei diplomati e persino della forza lavoro priva di istruzione formale, mentre dall’altra si assiste a un netto peggioramento delle condizioni di lavoro e del salario dei laureati stessi. Secondo il «processo di Bologna», gli studenti non devono essere espulsi in massa dall’università, ma servono come strumento di differenziazione e di concorrenza al ribasso all’interno della forza lavoro nazionale.
A un mercato del lavoro organizzato secondo le direttive del just in time, corrispondono percorsi di studio organizzati just in time secondo le esigenze del mercato (autonomia didattica e sistema dei crediti formativi), che abbisogna di una manodopera adeguata alle esigenze tecniche di un’economia deindustrializzata e basata sul terziario (più del 67% degli occupati lavora nel terziario) come quella italiana.
L’università pubblica intende oggi produrre un esercito di lavoratori in sovrannumero (e quindi più ricattabili), mediamente qualificati e capaci di apprendere (e dimenticare) velocemente nuove «istruzioni» (o «skills» come c’è scritto sul curriculum europeo) per muoversi in un mercato del lavoro segnato da precarietà, insicurezza e continua necessità di «aggiornarsi». E’ uno strumento, tra tanti, della deregolamentazione del mercato del lavoro a vantaggio dei profitti delle imprese a cui assistiamo in Italia. La proliferazione di tirocini formativi e di stage post-laurea gratuiti, gestiti in accordo da università e imprese, non fanno che aggravare questa situazione di attacco ai diritti del lavoro.
Il «diritto allo studio» va dunque ripensato, assumendo la constatazione che la cosiddetta «università di massa» è uno strumento delle imprese nel ciclo di valorizzazione. Senza però ritenere che la selezione di classe operata dall’università sia sparita. Questa si ripropone da una parte nella distanza tra un’università pubblica in corso di smantellamento grazie ai tagli e un’università privata dove si comprano, più che saperi qualificati, relazioni e «conoscenze» personali («conoscenze» nel senso di «contatti») utili alla riproduzione di classe. La selezione della classe dirigente, quindi, si fa altrove: nelle università d’élite, come la Luiss o la Bocconi, o in università di prestigio all’estero, per chi può permetterselo, o nei vari corsi post-laurea, master e specializzazioni costosissime a cui possono accedere solo fasce sociali privilegiate.
Dall’altra parte, esiste ancora una selezione di classe nell’accesso all’università pubblica, ma essa si è diversificata e complicata. Sempre più diplomati si iscrivono all’università, ma un buon 40% di giovani esaurisce il suo percorso formativo tra scuole medie e superiori. In più, si iscrive all’università quasi il 100% di chi ha frequentato un liceo, mentre solo la metà di chi ha frequentato un istituto Tecnico e ¼ di chi ha frequentato un istituto Professionale. Esiste dunque ancora un problema di «diritto allo studio», che si complica a partire dal riconoscimento che frequentare l’università non garantisce più alcun «ascensore sociale». In termini pratici, oggi, i figli della classe media (nelle sue più diverse sfaccettature), si iscrivono all’università nel tentativo di, se non elevare, quantomeno mantenere il proprio status. Tentativo che fallisce nella maggioranza dei casi. L’università appare sempre meno un «buon affare», visto che se ne esce tra i 25 e i 30 anni con una qualifica che non è garanzia di niente. Nel frattempo coloro che hanno iniziato a lavorare da giovanissimi, benché non se la passino comunque meglio in termini di condizioni lavorative, possono vantare un curriculum per certi versi più appetibile e in qualche caso anche un piccolo gruzzolo di risparmi.
Le lotte del 2008 e del 2010 sono state comunque un fenomeno molto articolato. Diverse anime componevano il movimento, che non a caso si è frammentato nelle pratiche, nelle alleanze e nelle parole d’ordine a partire dai differenti riferimenti politici e territoriali. Le aree maggioritarie, rappresentate da Uniriot, da Atenei in Rivolta e dai sindacati studenteschi, hanno infine trovato come unico comun denominatore la tradizionale rivendicazione del «diritto allo studio», perchè nelle pratiche di generalizzazione della lotta hanno palesato tutte le loro differenze. L’area romana di Uniriot ha insistito sulla centralità del lavoro cognitivo nei processi produttivi contemporanei, pretendendo che gli studenti, in quanto produttori di conoscenze, fossero in grado di rappresentare su di sé, in autonomia, il conflitto capitale-lavoro: ciò rischia di trasformare le istanze espresse in rivendicazioni corporative. I sindacati studenteschi, a loro volta, si sono appoggiati al sindacato di riferimento, riproducendo le stesse dinamiche concertative al ribasso che caratterizzano i sindacati confederali italiani. Atenei in Rivolta si è focalizzata sulla costituzione di una rappresentanza democratica del movimento, di modo da non lasciare ai rapporti di forza tra gruppi la direzione delle proteste, mancando l’obiettivo.
Dopo i cortei del 14 dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011 appare chiaro come sia necessario anche fare i conti con le istanze conflittuali poste da una composizione sociale giovanile e precaria, che rifiuta i terreni della concertazione e dell’opinione pubblica, e che pone immediatamente il tema della generalizzazione delle lotte.
Le diversificazioni produttive, le delocalizzazioni, le differenti condizioni contrattuali, come l’accesso a percorsi formativi diversi per qualità e quantità, hanno frammentato la forza-lavoro. La necessità è quella di attuare percorsi di ricomposizione e, per la logica stessa del capitalismo contemporaneo, l’università è uno dei luoghi da attraversare.
Sonic Death – Rui Cola