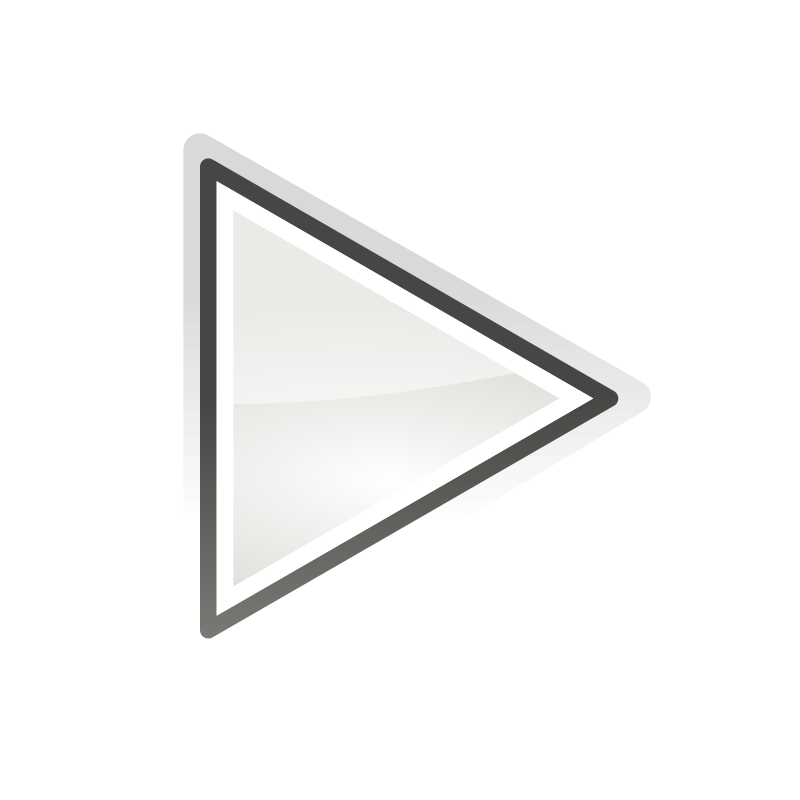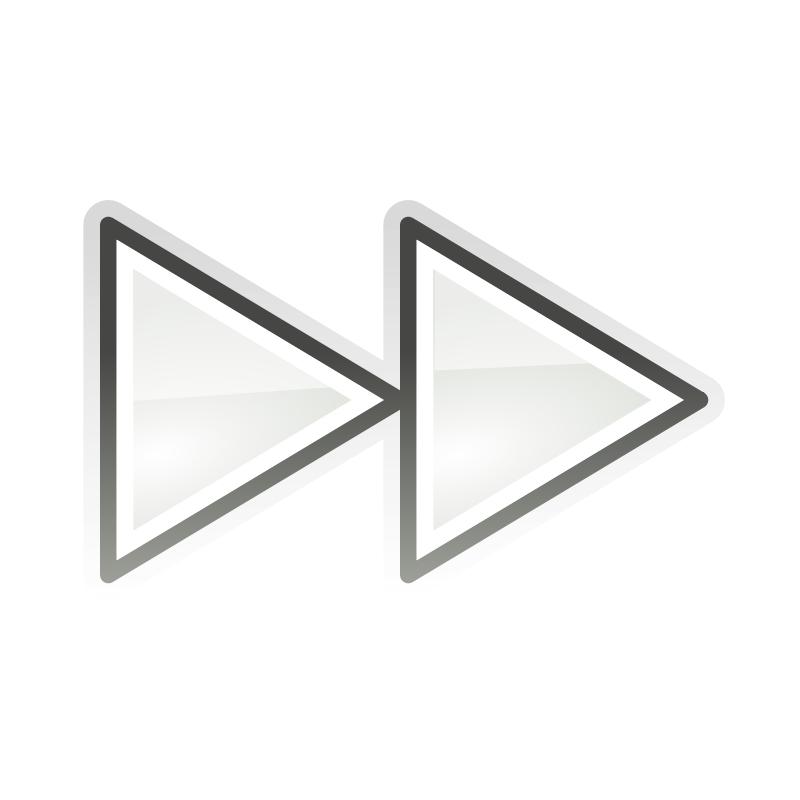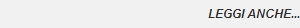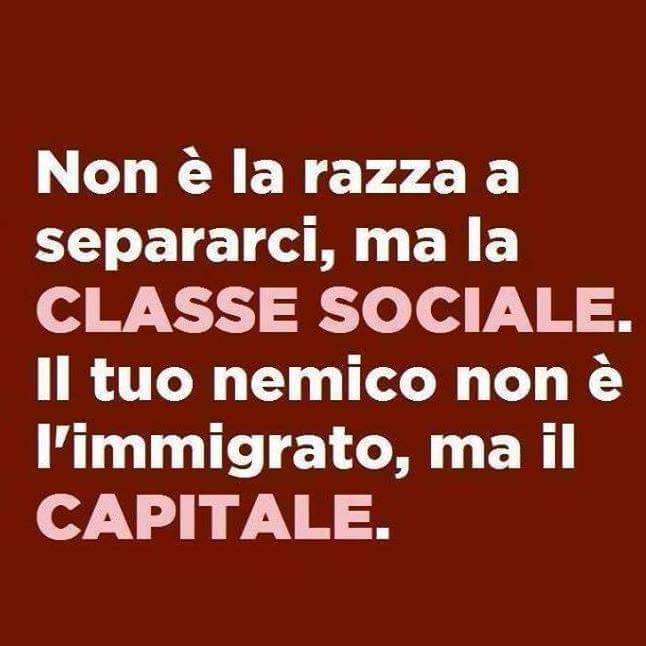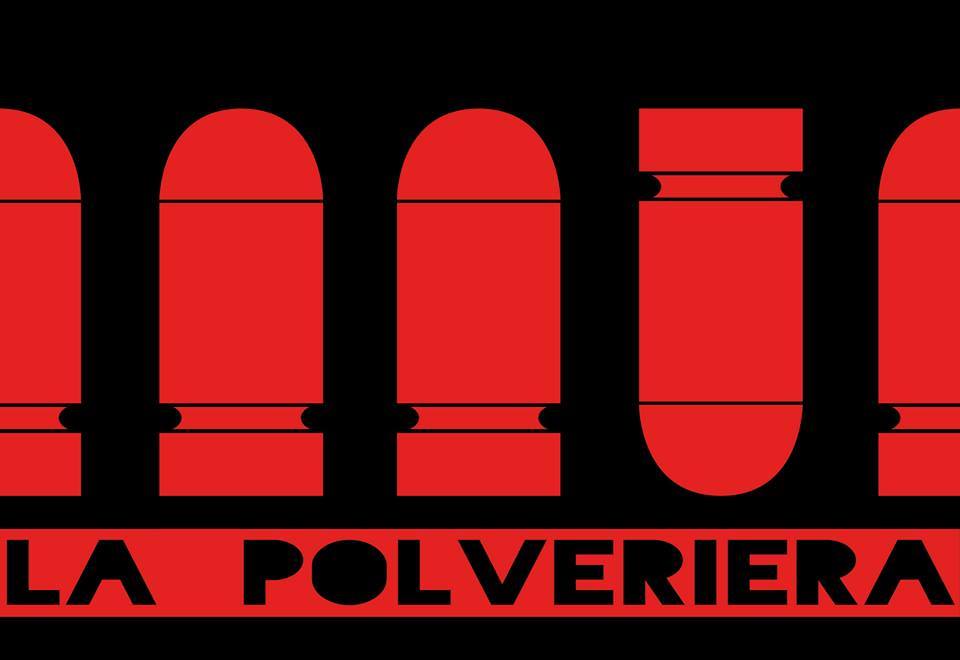Il petrolio, i monopoli, l’imperialismo – Parte 7
continua da parte 6
In quello stesso tempo la crescente tensione tra lo Stato di Israele e gli Stati arabi minacciava di far da detonatore allo scoppio di tutta l’area. La seconda guerra arabo-israeliana del 1956 aveva mantenuto le linee di confine stabilite alla fine della prima guerra del 1948. La sorveglianza delle frontiere era stata affidata alle truppe Onu. Nessuna soluzione era mai stata apportata al problema dei profughi che avevano abbandonato la Palestina ebraica nel 1948 e vivevano da allora soprattutto in Giordania e in Egitto in campi di raccolta in condizioni di vita miserabili. Il canale di Suez restava chiuso ad Israele, che però poteva comunicare con il Mar Rosso attraverso il porto di Eilat situato in fondo al golfo di Aqaba: l’ingresso del golfo era controllato dall’Egitto, ma i caschi blu dell’Onu assicuravano il passaggio delle navi israeliane.
Una iniziativa di Nasser, probabilmente su pressione della Russia, pose fine a questa situazione, mettendo in pericolo l’economia di Israele: il 18 maggio 1967, su richiesta di Nasser, il segretario dell’Onu U-Thant ritirò i caschi blu, permettendogli di sbarrare l’accesso nel golfo di Aqaba non solo alle navi israeliane ma anche a quelle che trasportavano prodotti strategici per Israele, compreso il petrolio.
Il 5 giugno 1967 Israele invase l’Egitto dando inizio alla guerra detta dei Sei Giorni. Il suo esercito, lo Tsahal, attaccò il grosso dell’esercito egiziano concentrato a nord del Sinai, mentre l’aviazione distruggeva a terra gran parte dell’aviazione egiziana di fabbricazione sovietica. La sorpresa fu totale: il 6 giugno lo stato maggiore israeliano annunciò la conquista di Gaza; il 7 di Sharm el Sheikh, che controllava l’ingresso del golfo di Aqaba all’estremità meridionale del Sinai. Inoltre gli israeliani occuparono la penisola desertica del Sinai, ciò che permise loro di impadronirsi di tutta la riva orientale del canale di Suez, molto oltre le linee del 1956. L’esercito israeliano occupò la città vecchia di Gerusalemme, che apparteneva alla Giordania, e proseguì l’offensiva occupando tutta la riva occidentale del Giordano. Infine le forze israeliane si impadronirono di importanti posizioni strategiche in Siria. In sei giorni quella che avrebbe dovuto essere la riscossa degli Stati arabi si era trasformata nella loro totale disfatta: la Siria aveva perso le alture del Golan, oltre a gran parte della sua aviazione; la Giordania aveva dovuto rinunciare a tutta la Cisgiordania, alla sua aviazione e a gran parte del suo equipaggiamento militare. Chi aveva subito però il colpo letale era stato l’Egitto: il suo esercito aveva subito quasi 15 mila caduti, enormi perdite di armi e munizioni, la sua aviazione era stata quasi totalmente distrutta, e soprattutto Israele gli aveva strappato l’intero Sinai. Nasser, travolto dalla disfatta, rassegnò le dimissioni la sera del 9 giugno.
Da tempo i paesi arabi minacciavano di usare l’arma del petrolio contro l’Occidente e l’occasione fu loro fornita proprio dalla guerra. Il 6 giugno, il giorno successivo all’attacco israeliano, l’Opec decise di attuare l’embargo petrolifero verso i paesi che appoggiavano Israele, andando ad aggravare la crisi provocata dalla chiusura del canale di Suez e degli oleodotti. Il blocco colpì soprattutto l’Europa, che dal Medio Oriente e dal Nord Africa dipendeva per i tre quarti delle sue importazioni. Verso la fine di giugno anche la Nigeria, alle prese all’epoca con la rivolta del Biafra, cessò le sue esportazioni, sottraendo ad un mercato già in condizioni critiche altri 500 mila barili al giorno.
Ma il boicottaggio si dimostrò un fuoco di paglia, dato che l’Iran e la Libia continuarono tranquillamente a vendere il loro petrolio, non solo ai paesi occidentali ma anche ad Israele, mentre il Venezuela aumentò addirittura la produzione. Re Faysal, che si trovava di fronte ad una imminente crisi finanziaria, su consiglio del ministro del petrolio Yamani, limitò l’embargo a Stati Uniti e Inghilterra, considerati paesi aggressori (peraltro nessuna delle due potenze ritirava allora molto petrolio dall’Arabia Saudita). Di fatto, per l’assenza di un fronte comune dei paesi arabi produttori, l’embargo non ottenne gli effetti voluti. Già dopo un mese, i paesi che lo avevano decretato cominciarono a dare segni di irrequietezza per la diminuzione delle entrate, Arabia Saudita ed Egitto in testa. Ai primi di settembre l’embargo venne annullato, a scorno completo del mondo arabo, che all’umiliazione militare aggiungeva l’impotenza politica.
Ma la situazione era destinata a cambiare all’inizio degli anni Settanta quando gli avvenimenti libici fornirono l’occasione per dare slancio all’ascesa dell’Opec (che ora comprendeva dodici paesi membri: ai cinque originari si erano aggiunti Qatar, Emirati Arabi, Libia, Algeria, Indonesia, Nigeria, Gabon) e dettare alle Compagnie nuove condizioni contrattuali.
Nel 1955 un petrolio di alta qualità – il cosiddetto light – era zampillato in Libia. Per la verità già negli anni Venti il geologo francese Conrad Kilian aveva scoperto il petrolio nella regione del Fezzan, nel sud della Libia, nella totale indifferenza da parte della Francia, ma non dei servizi segreti britannici e del generale gollista Leclerc. Quest’ultimo nel 1942, abbandonando la Libia, aveva lasciato una guarnigione a difesa dei giacimenti cartografati da Kilian, nella prospettiva di annettere il Fezzan al Sahara francese. Nel novembre del 1947, mentre Leclerc stava ispezionando i confini libici, l’aereo sul quale viaggiava precipitò (come accadrà a Mattei) in circostanze rimaste misteriose. Nel 1951 le mire francesi vennero definitivamente frustrate dalla decisione dell’Onu, su pressione degli inglesi, di decretare l’indipendenza della Libia mettendo sul trono Idris al Senussi, il cui primo provvedimento fu la concessione agli Usa di una base militare e il rilascio alle Compagnie anglo-americane dei permessi per effettuare ricerche petrolifere sul territorio libico. Sei delle Sette Sorelle e altre otto Compagnie indipendenti si accaparrarono le concessioni, e finalmente nel 1955 il nuovo petrolio libico iniziò a navigare verso gli Usa sulle petroliere Exxon. Graziosamente, le Compagnie americane lasciarono alcune briciole all’italiana Eni e alla francese Cfp.
Finché restò al potere il corrotto regime di re Idris le Compagnie petrolifere non furono seriamente minacciate. Il re si lamentava del basso prezzo del petrolio, ma a tenerlo buono bastava l’esempio di Mossadeq. Tutto cambiò nel momento in cui, il 1° settembre 1969, Idris venne deposto da un gruppo di giovani ufficiali dell’esercito guidati dal colonnello Muammar Gheddafi. Il gruppo, deciso ad usare il petrolio come arma contro Israele e l’Occidente, entrerà inevitabilmente in rotta di collisione con l’imperialismo americano e le Sette Sorelle. Il primo provvedimento messo in atto dai giovani colonnelli fu di ordinare agli americani di evacuare la loro più grande base militare del Nord Africa e di lasciare il paese.
All’inizio il nuovo governo più che verso la nazionalizzazione delle Compagnie si orientò verso un aumento del prezzo del barile: il 20 gennaio 1970 Gheddafi diede il via ai negoziati con ciascuna delle ventuno società operanti in Libia, annunciando che se non avessero accettato di aumentare i prezzi di 40 centesimi di dollaro al barile avrebbe agito unilateralmente. Affermò con boria che «il popolo libico aveva vissuto senza petrolio per cinquemila anni e poteva continuare a farne a meno ancora per qualche anno pur di vedere riconosciuti i propri diritti». In fondo la richiesta era ragionevole, in considerazione dell’alta qualità del greggio (a bassa gradazione di zolfo e quindi particolarmente adatto alla trasformazione in carburante per auto e aerei) e della vicinanza della Libia ai mercati europei. Questo fatto diventerà ancora più importante dopo il maggio 1970, quando un sabotaggio interromperà in Siria la Tap-line proveniente dall’Arabia Saudita. I governanti libici ricevettero un aiuto inatteso dall’esperto di petrolio del Dipartimento di Stato James Akins il quale, preoccupato dalle prospettive di una crisi energetica, sollecitò le Compagnie a scendere a patti con Gheddafi.
La richiesta fu respinta al mittente dalle grandi Società, con alla testa la Exxon, ma in Libia l’anello debole della catena era costituito dalle Compagnie indipendenti che non potevano permettersi di perdere le loro concessioni come minacciato da Gheddafi in caso di mancato accordo. La prima a cedere fu la Occidental Petroleum del miliardario statunitense Hammer, in quel momento sotto i riflettori perché accusato di aver corrotto alcuni funzionari del vecchio regime libico. Negoziando separatamente anche la Continental aveva rotto il fronte degli operatori. Le Sette Sorelle, dopo aver chiesto invano l’intervento del Dipartimento di Stato e del Foreign Office, capitolarono in ottobre, accettando le condizioni imposte alla Occidental.
Ben presto le richieste di aumento di prezzo si diffusero oltre i confini della Libia: l’Iraq, l’Algeria, il Kuwait, l’Iran chiesero tutti un aumento dell’aliquota fiscale dal 50 al 55%. Nella conferenza di Caracas del 12 dicembre 1970 l’Opec sancì il principio che i 30 centesimi di aumento ottenuti dalla Libia divenivano il prezzo ufficiale di riferimento per tutti i paesi membri. All’inizio del 1971 la Libia di Gheddafi si trovava in una posizione di assoluto vantaggio nei confronti delle Compagnie che di fatto avevano perso il controllo sui volumi di produzione ed erano soggette al gioco al rialzo dei prezzi ed esposte alla minaccia di nazionalizzazioni.
Le Major sotto la guida della Bp formarono un fronte comune di “difesa”: i rappresentanti di ventitré Compagnie sottoscrissero a New York, nel quartiere generale della Mobil, una lettera all’Opec nella quale si sollecitava un accordo generale tra le Compagnie e l’insieme degli Stati, allo scopo di evitare negoziati separati. Niente male, se si pensa che soltanto dieci anni prima le Compagnie si erano rifiutate di riconoscere l’esistenza stessa dell’Opec. Inoltre, fu siglato un documento, rimasto segreto per tre anni, con cui ciascun firmatario prometteva di non concludere alcun accordo con il governo libico senza il consenso di tutti gli altri e si impegnava ad uno scambio di aiuto reciproco. Per l’occasione il Dipartimento di Giustizia, preposto all’anti-trust, girò la testa dall’altra parte.
In risposta alla lettera delle Compagnie, lo Scià convocò una conferenza dell’Opec a Teheran al termine della quale, nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio 1971, fu firmato un accordo che riconosceva un extra di 30 centesimi sul prezzo ufficiale del barile, da elevare a 50 a partire dal 1975. Ma solo gli Stati del Golfo furono totalmente favorevoli: l’accordo escludeva specificamente ogni impegno per i prezzi del petrolio nel Mediterraneo. La Libia, il Venezuela e altri Stati “radicali” si dichiararono contrari perché ritenevano che l’accordo limitasse il margine di azione dei singoli Stati membri nei confronti delle Compagnie.
A soli quattro giorni dalla riunione di Teheran il governo di Tripoli, con l’appoggio dell’Algeria, dell’Iraq e dell’Arabia Saudita, iniziò nuove trattative separate con le Compagnie presenti nel paese e riuscì a strappare un aumento di 76 centesimi portando il prezzo base a 3,30 dollari al barile, oltre al rincaro delle imposte governative al 60%. L’accordo di Tripoli scavò un fossato tra la Libia e gli Stati del Golfo favorevoli a Teheran.
36. La crisi economica mondiale – 1973: il primo choc petrolifero
Nel dicembre 1972, nell’ambito del G-10, si arrivò ad un accordo, che il presidente americano Nixon enfatizzò come “il più importante nella storia del mondo”, in base al quale i tassi di cambio delle valute potevano avere una banda di oscillazione del 2,25% rispetto alla parità. Ma questo non impedì una seconda svalutazione del dollaro nel febbraio 1973.
Grave fu il disappunto soprattutto dei paesi produttori di petrolio, visto che tasse e royalty erano calcolate in dollari. La dipendenza di questi paesi dal dollaro era accentuata dal fatto che il surplus accumulato poteva essere assorbito solo dal mercato finanziario americano e che la gran parte dei titoli finanziari detenuti al di fuori degli Usa erano anch’essi denominati in dollari.
Questa dipendenza assoluta dalla divisa americana e la necessità di proteggere i propri investimenti aveva spinto l’Opec, dopo lo smantellamento del sistema di Bretton Woods, a concentrare i suoi sforzi sulla ricontrattazione del prezzo del petrolio. L’aumento che ci fu nell’ottobre 1973, per quanto elevato in termini assoluti, fu in realtà contenuto se riferito al valore dell’oro. Fino al 1971 infatti il valore dell’oro in petrolio non era mai uscito dall’intervallo di 10-15 barili per oncia, mentre alla vigilia dello choc dell’ottobre 1973 il rapporto era arrivato a 34 barili di petrolio per un’oncia d’oro.
Ma andiamo con ordine. Il 6 ottobre 1973, giorno della festività ebraica dello Yom Kippur, Egitto e Siria, forti degli armamenti loro forniti dall’Urss e probabilmente su ispirazione dei consiglieri sovietici presenti nei due paesi, aprirono le ostilità contro Israele pensando di cogliere impreparato il nemico. Ma anche questo conflitto, dal punto di vista militare si risolverà con una sconfitta degli arabi: gli israeliani, equipaggiati dalle armi americane, alla fine della guerra avevano sottratto territorio strategico sia alla Siria sulle alture del Golan sia all’Egitto sulla sponda occidentale del canale di Suez.
Gli avvenimenti bellici furono strettamente intrecciati con la Conferenza dei paesi Opec che in quegli stessi primi giorni di ottobre si teneva a Vienna per discutere con le Major una revisione generale dei prezzi del greggio. Il giorno 9, all’offerta delle Compagnie di un aumento del 15% del posted price (il prezzo formale di listino) e di un aggiustamento verso l’alto dell’indicizzazione sull’inflazione, il Cartello aveva rilanciato chiedendo un aumento del 100% e un aggancio all’inflazione basato sull’indice generale dei prezzi.
Il 10 ottobre gli Stati Uniti proposero il cessate il fuoco su tutte le linee di combattimento: ma sia Israele sia l’Egitto opposero il loro rifiuto. Da quel momento, l’Unione sovietica prese una più decisa posizione nel conflitto organizzando un ponte aereo per rifornire e soccorrere soprattutto la Siria che era in difficoltà contro le forze israeliane. Anche Washington decise per un ponte aereo di sostegno ad Israele.
L’arrivo in Israele dei primi cargo americani carichi di armi provocò l’interruzione delle trattative viennesi. Il 16 ottobre i delegati dei paesi del Golfo (cinque arabi e un iraniano) riuniti a Kuwait City annunciarono unilateralmente la decisione di un aumento del 70% del prezzo del greggio (da 2,90 dollari a 5,12), allineandolo ai prezzi del mercato libero. La proposta irachena di nazionalizzare le Compagnie americane, ritirare i capitali dalle banche Usa e istituire l’embargo contro gli Stati Uniti e gli altri amici di Israele non trovò l’appoggio dell’Arabia Saudita, contraria ad una aperta dichiarazione di guerra economica agli americani.
Il 17 ottobre, mentre le forze israeliane avanzavano verso la Siria, venne deciso dai ministri arabi riuniti in Kuwait di usare il petrolio come arma politica procedendo ad un taglio della produzione nella misura del 5% al mese. Due giorni dopo, il 19 ottobre, in risposta ad un pacchetto di aiuti militari forniti dagli Usa ad Israele del valore di 2,2 miliardi di dollari, la Libia stabilì l’embargo totale del trasporto di petrolio verso gli Stati Uniti (esteso poi a Olanda, Portogallo, Danimarca, Sudafrica e Zaire in quanto alleati di Israele) e la riduzione del trasporto verso altri paesi “non amici”, da mantenere fino a quando lo Stato ebraico non si fosse ritirato dai territori occupati nella guerra del 1967. Il giorno 20, un analogo provvedimento fu preso dall’Arabia Saudita e dagli altri Stati arabi.
Il 21 ottobre il Consiglio di sicurezza approvò la Risoluzione n. 338 che imponeva il cessate il fuoco sulle linee raggiunte in quel momento dai due eserciti. Ma non fu sufficiente a fermare i combattimenti perché gli israeliani proseguirono la loro offensiva sul fronte del Sinai, decisi a chiudere in trappola la terza armata egiziana e a non mollare il vantaggio ottenuto sul campo. Ci vollero altre due Risoluzioni (la 339 del 23 ottobre e la 340 del 25) per arrivare finalmente a bloccare le operazioni militari, anche per la minaccia di un possibile intervento sovietico a fianco degli arabi.
Questi avvenimenti concitati furono l’occasione tanto attesa dai paesi produttori per girare la bilancia a loro favore e dare una risposta concreta alla svalutazione della moneta americana. La pretesa delle Compagnie di negoziare i prezzi direttamente con i paesi produttori era ormai un ricordo del passato. Questo sconvolgimento è passato alla storia con il termine di primo choc petrolifero, primo di una serie dunque: il secondo seguirà nel 1979 in concomitanza con la guerra Iran-Iraq, il terzo nel 2008 quando il prezzo del petrolio raggiungerà il picco di 145 dollari/barile, in parte per motivi di pura speculazione. Nel periodo 2001-2007, infatti, mentre la domanda mondiale di petrolio aumenterà di nove milioni di barili/giorno, il cartello dei paesi produttori non attuerà nessun intervento di sostegno alla domanda e i paesi non-Opec aumenteranno l’estrazione di greggio per meno del 50% del fabbisogno.
Quella prima, improvvisa impennata dei prezzi provocò il panico generalizzato: ogni paese cercò di accumulare riserve negoziando separatamente con i paesi arabi produttori. Il 24 ottobre 1973 la Comunità europea e il Giappone approvarono, in disaccordo con gli Usa, la risoluzione 242 dell’Onu che condannava Israele e ne esigeva il ritiro dai territori occupati. I paesi europei, fortemente dipendenti dal petrolio mediorientale, erano pronti a dissociarsi dalle posizioni americane per sposare la causa dei paesi arabi, con Inghilterra e Francia vogliose di prendersi la rivincita per lo smacco subito dagli americani durante la crisi di Suez di vent’anni prima.
Di fronte ai prezzi crescenti e alle pessimistiche previsioni del Club di Roma sui limiti dello sviluppo basato sulle fonti di energie fossili non rinnovabili, i paesi industrializzati cominciarono ad imporre politiche di risparmio energetico e di sviluppo di fonti alternative di energia. La Francia introdusse misure draconiane di restrizione, soprattutto in materia di energia elettrica, benché l’Algeria continuasse i rifornimenti; anzi, cogliendo l’occasione, si lanciò ben presto in un massiccio programma di costruzione di centrali nucleari attingendo all’uranio della Nigeria e del Kazakistan. In Italia tutto si ridusse alle famose “domeniche a piedi”. Anche l’Olanda si esercitò nel razionamento dei combustibili, nonostante che Rotterdam possedesse le più grandi riserve petrolifere del mondo!
In realtà, in nessun momento vi fu una vera penuria di petrolio. Gli analisti sono concordi nel ritenere che l’effettiva carenza non fu superiore al 5-7% rispetto al periodo precedente la crisi, e in parte fu compensata dal fatto che le Compagnie ripartirono le loro scorte accumulate più o meno verso tutti i mercati, senza ovviamente tener conto dell’embargo voluto dall’Opec. Peraltro l’embargo fu troppo breve per avere serie ripercussioni sulle economie dei paesi colpiti, soprattutto di quei paesi come Francia e Inghilterra che, grazie alle proprie Compagnie nazionali, avevano accesso diretto alla produzione mediorientale e potevano così rifornire i rispettivi mercati. Per le Compagnie americane invece le direttive ufficiali furono quelle di mantenere una politica di neutralità e distribuire il greggio “nel modo più equo possibile” (che significava portare verso gli Stati Uniti quanto più petrolio possibile). Tra i paesi Opec, l’Iran addirittura non solo non rispettò l’embargo, ma aumentò la sua produzione, mentre il prezzo del barile continuava a salire! La commedia finì a marzo del 1974, quando l’embargo fu ufficialmente annullato, dopo che alla fine di gennaio Israele ed Egitto, con la mediazione del Segretario di stato americano Kissinger, avevano cominciato a negoziare i termini per il ritiro delle truppe israeliane dal Sinai.
Gli alti prezzi del petrolio furono una manna per le Compagnie, e resero vantaggiosi gli investimenti in aree e campi altrimenti antieconomici a causa delle difficoltà tecniche e degli elevati costi di produzione. Le multinazionali del petrolio iniziarono a sfruttare in modo intensivo soprattutto i pozzi del golfo del Messico (Texas), del mare del Nord e dell’Alaska. Il greggio dell’Alaska, scoperto negli anni Sessanta dalla Exxon e dalla Bp, convogliato attraverso un oleodotto lungo 1.280 km entrato in funzione nel 1977, con i suoi 2 milioni di barili/giorno arriverà a coprire un quarto della produzione complessiva di petrolio degli Stati Uniti.
Dal mare del Nord il primo carico di greggio, proveniente dai grandi giacimenti di Forties e di Brent (che da allora darà il nome al greggio di riferimento dei mercati), giunse in una raffineria britannica nel giugno 1975. All’inizio degli anni Ottanta la produzione superò i due milioni di barili/giorno. Il mare del Nord diventò la nuova frontiera petrolifera fuori dal controllo Opec oltre che luogo di sperimentazione di nuovi sistemi di ricerca e di estrazione degli idrocarburi. Tra il 1990 e il 1995 quest’area coprirà oltre il 50% dell’incremento nella domanda mondiale di petrolio ma, nonostante questo exploit, il mare del Nord ha riserve per appena 16 miliardi di barili (pari all’1,5 delle riserve mondiali).
Quanto al Messico, dopo la nazionalizzazione del petrolio avvenuta negli anni Trenta, esso era rimasto ai margini del sistema petrolifero mondiale. L’inversione di rotta si ebbe nel 1974 con la scoperta di enormi campi petroliferi offshore nella baia di Campeche: l’afflusso di ingenti investimenti e prestiti internazionali porteranno la produzione messicana a quasi due milioni di barili/giorno.
La guerra arabo-israeliana era stata il classico specchietto per le allodole, perché alla base degli avvenimenti di allora c’era la crisi di sovrapproduzione venuta a maturazione in tutto il mondo capitalista (e a tutt’oggi ancora irrisolta) che provocò un rallentamento nel consumo di petrolio, dopo i vertiginosi aumenti dei decenni precedenti. Sotto i colpi della recessione che faceva il giro del mondo la stampa occidentale si interrogava sul ruolo effettivamente svolto dalle Compagnie petrolifere nell’esplosione della crisi, mentre gli Stati Uniti venivano additati quali principali responsabili dell’aumento dei prezzi perché in quei mesi importarono oltre il doppio del loro fabbisogno interno, mettendo fine ad anni di contingentamento.
In conseguenza di questa decisione, la domanda Usa di greggio mediorientale crebbe rapidamente, ben più di quanto diminuivano le esportazioni arabe e più che controbilanciando la caduta delle importazioni europee e giapponesi. Probabilmente, con una diversa politica americana, la crisi petrolifera del 1973 si sarebbe risolta in breve tempo e con aumenti di prezzo irrisori. Alla fine, dopo molto clamore, le Compagnie uscirono indenni da un’indagine promossa dal Senato americano per accertare eventuali loro responsabilità nello scoppio della crisi. Ma il vento era cambiato, e le Compagnie dovettero dire addio alle grandi concessioni petrolifere mediorientali che erano state alla base della loro espansione mondiale, e anche a quella sorta di regime extraterritoriale che avevano messo in piedi in quelle regioni.
L’aumento dei prezzi consentì un passaggio di della proprietà dei giacimenti dalle Compagnie ai governi arabi, i quali in cambio dell’esproprio concessero alle società straniere compensazioni e accordi di cooperazione nella gestione dei giacimenti stessi. In altri termini il dominio dell’Opec nel periodo dal 1973 al 1985 è stato reso possibile dalle scelte strategiche del maggior paese consumatore, gli Stati Uniti, e dalla continua cooperazione di Washington con le grandi Compagnie.
Dopo le concessioni irachene e libiche, nel 1974 cadde quella della Kuwait Oil Company, partecipata da Bp e Gulf: il governo kuwaitiano acquisì dietro indennizzo prima il 60% della compagnia e poi nel marzo del 1975 il restante 40%. Poi fu la volta della concessione più ricca, quella della Aramco in Arabia Saudita: fondata nel 1947 per volere dell’amministrazione statunitense dalle quattro maggiori Compagnie petrolifere americane, Exxon, Texaco, Mobil, Chevron, possedeva da sola oltre un quarto delle riserve petrolifere allora esistenti. Nel giugno 1974, dopo ripetute pressioni del governo di Riyadh che pretendeva una più equa ripartizione dei profitti, la quota di capitale saudita passò dal 25 al 60%. Nel dicembre dello stesso anno l’Arabia Saudita manifestò l’intenzione di operare una completa nazionalizzazione della società, concedendo alle quattro Compagnie ex-proprietarie condizioni molto vantaggiose: la possibilità di continuare a fornire assistenza tecnica per l’estrazione del greggio ricevendo ventuno centesimi di dollaro per barile estratto e l’opportunità di commercializzare l’80% del petrolio prodotto acquistandolo a prezzo di favore.
Tuttavia, questa politica di esclusione delle Compagnie occidentali dalle riserve mediorientali e di chiusura della maggior parte dei paesi Opec agli investimenti stranieri spingerà l’industria petrolifera a concentrare le ricerche in altre parti del mondo, facendo diminuire drasticamente la fetta di mercato controllata dall’Opec. Anche le guerre mediorientali, soprattutto quella fra Iran e Iraq, contribuiranno a creare un mercato di esportatori esterni al Cartello di Vienna (oggi circa il 60% del petrolio venduto nel mondo proviene da aree non-Opec).
Tuttavia l’Opec, nonostante la messa fuori gioco delle Compagnie occidentali, non aveva la coesione interna necessaria a gestire la questione dei prezzi. A partire dal 1976, con la ripresa della domanda mondiale, i paesi produttori che avevano accumulato eccedenze negli anni di bassi consumi, cominciarono a vendere petrolio sottobanco per fare cassa, alimentando così i cosiddetti mercati “liberi” (o “spot”), alternativi e in concorrenza con il mercato gestito dall’Opec. Il più importante tra questi mercati era senza dubbio quello centrato sul porto di Rotterdam, attivo fin dagli anni Trenta ma che fino alla nascita dell’Opec aveva sempre rivestito un ruolo secondario nella pianificazione dei rifornimenti di prodotti raffinati da parte delle Compagnie. Agli inizi degli anni Settanta, il mercato spot copriva circa l’1% del commercio mondiale di greggio, con carichi trasportati via nave soprattutto da operatori indipendenti che lucravano sui differenziali di prezzo. Con l’entrata in campo di nuovi attori – Compagnie petrolifere nazionali dei paesi arabi, Compagnie pubbliche e private dei paesi consumatori, società di trading e di mediazione, mercati finanziari – Rotterdam diventerà in breve tempo il mercato petrolifero di riferimento a livello mondiale e funzionerà come una vera e propria Borsa del petrolio, per quanto modeste fossero le quantità scambiate (arriverà a gestire il 5% del volume mondiale degli scambi).
La formazione del prezzo del petrolio è cosa alquanto complessa in cui entrano molti fattori, non ultimi la consistenza delle riserve e la speculazione. I produttori manipolano il prezzo attraverso la gestione delle riserve e la disponibilità del bene. Il prezzo viene determinato nei mercati spot e nei mercati finanziari. Nei mercati spot, come quello di Rotterdam, sono acquistati volumi fisici di greggio al di fuori da ogni accordo di fornitura. Nei mercati finanziari invece si scambiano barili di carta: quel che viene scambiato in una serie più o meno lunga di compravendite non è una data quantità di greggio, ma un impegno all’acquisto futuro di un dato volume di greggio. I titoli scambiati sono futures, swap e opzioni. Nel mercato futures viene computato il rischio sulle oscillazioni di prezzo.
Tutte le multinazionali del petrolio possiedono proprie raffinerie a Rotterdam, facendo sì che questo mercato costituisca un barometro per le quotazioni mondiali del greggio e un luogo privilegiato di osservazione per le situazioni di surplus o di penuria della materia prima. Conoscere in anticipo, prima degli altri, le aree dove il petrolio scarseggia mette le ali alla speculazione: i compratori si disputano il prodotto e i prezzi salgono. In caso di penuria, i paesi produttori preferiscono vendere a prezzo più caro nei mercati spot piuttosto che ai loro clienti abituali al prezzo fissato. Senza dimenticare che molti paesi Opec utilizzano questi mercati proprio per superare la loro quota di produzione assegnata dal cartello.
Nel 1973-74 l’aumento dei prezzi, più che alla penuria di petrolio, fu dovuto a questo genere di speculazione, dal momento che ciascun paese consumatore agiva in ordine sparso e ricorreva al mercato di Rotterdam per accumulare riserve. Questo farà la fortuna dei commercianti indipendenti, broker o intermediari che li si voglia chiamare, i quali diventeranno i padroni incontrastati del mercato petrolifero mondiale. Ad esempio, riforniranno i paesi colpiti da embargo (Israele, Sudafrica, ecc.) noleggiando i cargo di armatori indipendenti. Uno di questi era il greco Aristotele Onassis, in attività dal 1938, che nel dopoguerra non esiterà ad entrare in contrasto con le Compagnie americane dotandosi di una flotta di superpetroliere.
Data la diversa qualità dei greggi, ogni area geografica ha il suo prezzo di riferimento. Attualmente i più importanti prezzi sono quelli del Brent del Mare del Nord, molto pregiato, di riferimento per l’Europa, l’Africa e il Mediterraneo, ed è anche il principale riferimento a livello mondiale, e il Wti del Texas, greggio di riferimento per il nord America nel circuito delle quotazioni della borsa-merci Nymex. Questi due petroli, al contrario del greggio del paniere Opec, hanno il vantaggio di essere “leggeri”, cioè poveri di zolfo e a bassa viscosità, il che ne facilita il trasporto e nella fase di raffinazione consente di ottenere una resa maggiore in prodotti finiti, per esempio, benzina e kerosene.
37. 1979, il secondo choc
 Il 1979 è l’anno dei clamorosi rovesciamenti di fronte nel campo delle alleanze politiche nella regione del Golfo. L’anno si aprì con la fuga dello scià Reza Palhevi, il 16 gennaio, e l’arrivo al potere dell’ayatollah Khomeini, determinando un vero e proprio rovescio strategico per gli Usa e gli arabi sunniti.
Il 1979 è l’anno dei clamorosi rovesciamenti di fronte nel campo delle alleanze politiche nella regione del Golfo. L’anno si aprì con la fuga dello scià Reza Palhevi, il 16 gennaio, e l’arrivo al potere dell’ayatollah Khomeini, determinando un vero e proprio rovescio strategico per gli Usa e gli arabi sunniti.
Il 26 marzo ci fu la firma ufficiale, apposta a Washington, del trattato di pace fra Egitto e Israele, che coronò la lunga marcia di avvicinamento del presidente egiziano Sadat agli Stati Uniti. Le tappe precedenti erano state la guerra del Kippur del 1973, la visita a Washington dell’ottobre 1975 per chiedere aiuti economici e militari, il viaggio a Gerusalemme del novembre 1977 conclusosi con il famoso discorso alla knesset, pieno di richiami alle comuni radici religiose di ebraismo e islam, e infine gli accordi di Camp David del settembre 1978, fortemente voluti dagli Usa, che prevedevano la restituzione del Sinai all’Egitto (non però della Striscia di Gaza) in cambio della pace e della libertà di navigazione per le navi israeliane nel mar Rosso. I mesi intercorsi fra i colloqui e la firma ufficiale del trattato furono teatro di furiose polemiche sia in Israele sia nei paesi arabi e fra i palestinesi. Basti dire che tutti gli Stati arabi ruppero le relazioni diplomatiche con l’Egitto, la Lega Araba trasferì la propria sede dal Cairo a Tunisi e la Conferenza Islamica, la massima autorità in campo musulmano, espulse l’Egitto.
Il 16 luglio il presidente iracheno Hassan al-Bakr si ritirò lasciando il posto al cugino Saddam Hussein.
Il turbolento 1979 si chiuse con l’invasione sovietica dell’Afghanistan iniziata alla vigilia di Natale. Il governo Usa, intervenendo attivamente nel conflitto in aiuto alla jihad afgana, getterà le basi per la nascita della futura Al-Qaeda di Bin Laden.
Nel settembre 1980 Saddam Hussein, sostenuto militarmente dagli Stati Uniti e dalla Francia, attaccò l’Iran, che pensava sprofondato nel caos, inseguendo un disegno di potenza regionale in cui entrava anche il petrolio: il greggio iracheno e quello iraniano avrebbero insieme trasformato l’Iraq nel più grande produttore mondiale. Iniziò così una tragedia destinata a durare otto anni con un bilancio terrificante in termini di vittime (un milione di morti) e di danni alle infrastrutture. A finire sotto le bombe furono, in Iraq, la grande raffineria di Bassora, il terminale di Fao, gli impianti petroliferi di Kirkuk e gli oleodotti che attraverso la Siria e la Turchia portavano il petrolio fino al Mediterraneo; in Iran, i terminali dell’isola di Kharg e di Bandar Khomeini, oltre al grande complesso di Abadan.
A causa della guerra venne a mancare sul mercato il 10% del fabbisogno mondiale di petrolio e ciò provocò naturalmente il panico generalizzato e un aumento dei prezzi. Tutti volevano accumulare scorte rivolgendosi principalmente al mercato libero di Rotterdam. Ma anche questa volta la penuria fu soltanto momentanea perché le Compagnie avevano enormi partite di greggio immagazzinate, che naturalmente aumentarono di valore e furono cedute ai migliori offerenti. E anche questa volta non mancò chi si scandalizzò per quei sovrapprofitti: negli Stati Uniti, parlamentari del calibro di un Ted Kennedy imbastirono inutili inchieste per la violazione delle leggi antitrust, mentre in Francia il tentativo di perseguire le Compagnie che si rifiutavano di mettere il petrolio sul mercato o che attuarono accordi illeciti a sfavore delle minori si arenò in cavilli legali.
Nel 1983, sempre in Francia, lo scandalo degli aerei “ricognitori”, “sniffatori” in un giornale satirico, pose di nuovo all’ordine del giorno il problema del potere delle Compagnie petrolifere: negli anni precedenti somme enormi di denaro pubblico erano state versate a Elf-Aquitaine per la sperimentazione degli aerei in grado di localizzare i giacimenti di petrolio. Naturalmente si trattava di una truffa. La destinazione delle somme versate non venne mai chiarita, anche se si ha ragione di pensare che una buona parte sia finito nei fondi neri della destra francese. Ma le Compagnie non agivano forse per il bene dello Stato?
In Italia, già in occasione del primo choc del 1973, mentre le scuole stavano al freddo, saltò fuori che il gasolio per il riscaldamento era stato accaparrato per creare una falsa penuria e far alzare i prezzi. Dietro l’operazione c’erano le mazzette versate a politici democristiani e socialisti da parte di Compagnie americane. Nel 1978 la Guardia di Finanza, che avrebbe proprio l’incarico istituzionale di vigilare sulle tasse e accise petrolifere, era stata coinvolta nell’inchiesta aperta dai giudici di Treviso contro la condotta fraudolenta di petrolieri e grossisti di Torino, Venezia e Milano. Venne a galla una frode fiscale di enormi proporzioni che coinvolgeva alti funzionari delle Fiamme gialle e, guarda caso, politici della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. L’indagine giudiziaria mise in luce per la prima volta anche i legami tra mondo della politica, mondo degli affari, servizi segreti e loggia massonica P2. Nel 1979 fu l’Eni a finire in un nuovo scandalo politico-finanziario: la società aveva concluso un accordo con l’Arabia Saudita grazie ai servigi della loggia P2 e dietro il pagamento di una tangente del 7% ad uno dei principi di casa Saud e di varie mazzette ai soliti politici italiani.
A partire dall’inverno del 1981, a causa della nuova recessione globale, i mercati furono sommersi da una enorme eccedenza di materia prima. In due anni il consumo mondiale di petrolio calò di un quarto: l’Europa consumò meno, mentre gli Stati Uniti ridussero le proprie importazioni dal 50 al 30%, incrementando la produzione interna. Paesi come l’Iran, la Nigeria, la Libia, il Messico, il Venezuela superarono le loro quote di produzione e puntarono al ribasso dei prezzi in controtendenza con le indicazioni dell’Opec. Per tutta risposta, inglesi, norvegesi e russi, questi ultimi primi produttori mondiali a caccia di divise forti, proposero un prezzo ancora più basso! Mondialmente, la capacità di raffinazione era allora di 80 milioni di barili/giorno contro un consumo stimato in 60 milioni: un terzo di troppo rispetto al fabbisogno. Il blocco della produzione iraniana e irachena in quegli anni non venne dunque per nuocere. Nel 1984, in ambito Opec, il Kuwait dichiarò riserve pari a 65 miliardi di barili, che l’anno successivo lievitarono del 50%: niente di strano se si pensa che le quote di produzione imposte dal Cartello sono proporzionali alle riserve dichiarate. Ma tutti hanno interesse a gonfiare certe stime fatte circolare sui mercati, e dichiarare l’esistenza di riserve e capacità estrattive superiori a quelle reali. I dati forniti sono per lo più arbitrari e sono volti ad attrarre investimenti, ottenere prestiti, aumentare le esportazioni. Così le esatte quantità di greggio estratte da ogni giacimento, le condizioni dei giacimenti stessi e i metodi usati restano un segreto gelosamente custodito. Tanto più che le riserve essendo una parte determinante per la formazione del prezzo, la segretezza dei dati è un ulteriore meccanismo di manipolazione del prezzo.
Altri fattori, oltre alla recessione, hanno concorso al rallentamento della domanda globale di petrolio: il progressivo ridimensionamento dell’uso del gasolio da riscaldamento, che in Francia, per esempio, è stato sostituito dall’energia nucleare, e l’utilizzo sempre più massiccio di gas naturale (oggi un quarto delle forniture di gas all’Europa è garantito dal gigante russo Gazprom attraverso il gasdotto North Stream che collega i giacimenti della Siberia occidentale alla Germania).
Ma, nonostante gli alti e bassi del mercato, il giro di affari attorno a questa materia prima strategica rimane colossale, con fatturati da capogiro: le imposte petrolifere nei paesi consumatori superano i mille miliardi di dollari e le rendite i 500 miliardi.
All’inizio degli anni Ottanta subentrò una fase nella quale il crollo dei prezzi e l’ascesa delle Compagnie nazionali nei paesi produttori impose alle Società petrolifere una ristrutturazione e diversificazione, tagliando costi e progetti di investimento, riducendo il personale per concentrarsi sulle attività strategiche, il famoso core business. La riorganizzazione industriale e finanziaria delle Compagnie è stata il risultato di una vera propria guerra a colpi di fusioni, di scalate e di acquisizioni che non risparmiò niente e nessuno. All’epoca fecero rumore l’acquisizione della Conoco – una delle grandi Compagnie indipendenti americane – da parte del gruppo chimico DuPont e della Gulf – una delle Sette Sorelle storiche – da parte della Chevron.
38. Il petrolio del Caspio
All’epoca, mentre le aree con grandi riserve di idrocarburi si facevano rare a fronte degli aumentati costi di esplorazione e di produzione, divennero assai appetibili i giacimenti vergini ricchi di petrolio e di gas situati nella zona del Caspio. Nel 1989, dopo la caduta del muro di Berlino e lo smantellamento dell’impero sovietico attanagliato da una profonda crisi economica, i paesi della regione, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, divennero oggetto di desiderio dei maggiori Stati imperialisti, sempre più assetati delle materie prime indispensabili alla vita dell’economia. La politica di sciacallaggio delle Compagnie e delle varie diplomazie, non disdegnando nessun mezzo d’azione per quanto perfido, punta ad impadronirsi dei pozzi e degli oleodotti.
La “liberalizzazione” dell’economia russa, iniziata sotto Gorbaciov già a partire dal 1987 grazie all’arrivo dei capitali esteri (Usa, Banca mondiale, Banca europea), subì un’accelerazione sotto Eltsin che diede il via a una vasta ondata di privatizzazioni nei settori dell’energia, dei metalli e delle telecomunicazioni (al 1994 oltre il 60% del Pil proveniva dal settore privato). Su questo terreno di “libera concorrenza” sono germogliati i monopoli bancari ed industriali dei famigerati “oligarchi” russi, che nel 2000 Putin ebbe buon gioco a mettere nel mirino additandoli all’opinione pubblica quali responsabili dell’aggravamento delle già disastrose condizioni di vita del proletariato russo. Il clan di Putin riuscì così sia a sbarazzarsi di qualche compagnia straniera troppo intraprendente sia ad incamerare al suo clan la rendita del petrolio e del gas russi, ricompattando il controllo politico e la gestione finanziaria delle immense risorse energetiche del paese.
Dal 1994 la città di Baku, capitale dell’Azerbaigian, è diventata la Dubai ultramoderna sul Caspio, dove tutte le grandi Compagnie hanno aperto uffici e avviato promettenti prospezioni offshore.
L’Orso russo non fa mancare il suo appoggio, contro Baku, alla vicina Armenia, da dove il petrolio del Caspio è a portata di cannone.
L’euforia delle grandi Compagnie per l’Azerbaigian presto si è rivolto anche al Kazakistan, sulla riva asiatica del Caspio, e alle sue miniere di uranio e di potassio. Nel 2000 è stato scoperto a Kashagan, nel Nord del Caspio, uno dei più grandi giacimenti petroliferi offshore esistenti al mondo ad opera di un Consorzio di otto società (tra cui le solite Shell, Exxon, Total, Eni). Non è ancora chiaro quanto di questo petrolio sarà recuperabile, date le notevoli difficoltà tecniche, di costi degli impianti e di rischi ambientali (in caso di incidenti l’emissione di gas solforato sarebbe mortale per i lavoratori e per la popolazione). I costi medi di produzione dell’area si aggirano sui 6-8 dollari/barile contro i 3 del Golfo Persico, senza contare i maggiori costi di trasporto e di diritti di transito. Intanto una cosa è certa: ci vorranno decenni per risanare i debiti che il paese ha contratto. Dal 2005, una parte del petrolio kazako scorre verso la Cina attraverso l’oleodotto che collega i giacimenti di Atasu alla provincia cinese dello Xinjiang, regione turcofona musulmana in rivolta contro Pechino. Ormai nel Caucaso, come altrove, la partita dell’energia è giocata da tre imperialismi: americano, russo e cinese.
39. In Africa
Nel 1971 il presidente Boumédiène nazionalizzò il petrolio algerino, costringendo le Compagnie francesi Total ed Elf ad interessarsi ad altre aree petrolifere, soprattutto mare del Nord e golfo di Guinea. In Gabon, la Total insediò un dittatore di comodo per meglio gestire i propri affari, mentre Elf si concentrò sulla Nigeria, che era ricca di giacimenti off-shore.
Il petrolio era stato scoperto in Nigeria nel 1956, nel delta del fiume Niger nell’estremo Sud del paese, dalla Shell-Bp, multinazionale anglo-olandese che al tempo era l’unica concessionaria dei diritti di estrazione. Da allora la storia della Nigeria è pesantemente condizionata dal petrolio. Quando nel 1967 il Biafra proclamò l’indipendenza dalla Nigeria fu subito sostenuto dalla Francia e dall’Elf: il conflitto che ne seguì, sobillato dalle potenze occidentali per saccheggiare le ricchezze del paese, fu disastroso e causò la morte di oltre due milioni di uomini, la maggior parte dei quali per fame. Dopo l’indipendenza dalla Gran Bretagna del 1960 il paese è stato quasi sempre sotto regime militare, ma il vero potere è stato esercitato di fatto dalle Compagnie del petrolio (su tutte la Shell, detentrice del 40% delle quote del Consorzio petrolifero, e poi Exxon, Chevron, Eni e Total), che hanno loro uomini a libro paga in ogni ministero e in ogni struttura.
La produzione di petrolio ammonta oggi in Nigeria, che dal 1971 è membro Opec, a 2,3 milioni di barili/giorno (dodicesimo produttore mondiale, primo in Africa). I pozzi sulla terraferma hanno una produzione decrescente fin dai primi anni Ottanta, mentre acquistano sempre più importanza i giacimenti situati in acque profonde. La Nigeria è al secondo posto in Africa dopo la Libia per riserve provate (37 miliardi di barili) ed è al primo posto per riserve di gas naturale (5.000 miliardi di metri cubi). La Nigeria riveste grande interesse per il capitale internazionale, non solo in campo petrolifero ma anche in quello delle infrastrutture. Il paese è il più popoloso dell’Africa con 173 milioni di abitanti nel 2014 e la prima economia del continente, quindi un potenziale enorme mercato. Secondo previsioni la Nigeria nei prossimi dieci anni assorbirà il 40% di tutte le spese per infrastrutture che si investiranno nell’Africa sub-sahariana.
Non è quindi strano il crescente protagonismo mostrato verso il paese dai grandi imperialismi. Nel 2003, il presidente americano venne a proporre aiuti finanziari in cambio di petrolio, seguendo il criterio della differenziazione degli approvvigionamenti per non dipendere troppo da alcune aree, vedi Medio Oriente, tanto più che a separare gli Stati Uniti dall’Africa non c’è che l’Atlantico. Bisogna dire tuttavia che se gli Stati Uniti sono sempre stati in passato il principale acquirente del petrolio nigeriano, negli ultimi anni, in seguito al massiccio piano nazionale di estrazione di petrolio da scisti argillosi, le importazioni dalla Nigeria si sono sempre più ridotte fino ad azzerarsi nel 2014.
Ma in prima fila c’è sicuramente il capitale cinese, che mostra un forte interesse strategico verso tutto il continente africano, e che ha stretto legami commerciali con la Nigeria, l’Angola, l’Etiopia, il Sudan. Da 15 anni esiste a livello istituzionale un forum per la cooperazione Cina-Africa. Nel Ciad l’imperialismo cinese non ha esitato ad appoggiare una ribellione locale, mentre in Niger già operano direttamente Compagnie petrolifere cinesi. La Cina è il primo esportatore in Nigeria, soprattutto per prodotti elettronici, macchinari e beni di consumo: in conseguenza dei forti legami commerciali fra i due paesi recentemente la Banca centrale nigeriana ha convertito parte delle sue riserve da dollari Usa a yuan cinesi. Anche il mancato introito nigeriano per la chiusura del mercato Usa è stato prontamente sostituito dall’impegno cinese ad aumentare le importazioni petrolifere dalla Nigeria, anche per attenuare da parte della Cina la dipendenza dal petrolio angolano, che da solo rappresenta la metà del suo import petrolifero. Complessivamente la domanda cinese di prodotti energetici nel giro dell’ultimo decennio è pressoché raddoppiata, ed è ormai un sesto di quella mondiale.
40. In Iraq
La storia dell’Iraq degli ultimi decenni evidenzia in modo esemplare le dinamiche geopolitiche legate al petrolio. Nel 1988, alla fine della guerra contro l’Iran, il paese era materialmente e finanziariamente a terra e pesantemente indebitato con le petro-monarchie “amiche”, Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, che vantavano crediti superiori ai 60 miliardi di dollari. L’Iraq, che sosteneva di essersi sacrificato “in nome di tutti gli arabi”, reclamò la cancellazione del debito, oltre ad un risarcimento consistente nel diritto di trivellazione nei giacimenti situati a nord del Kuwait. Inoltre, come spiegò il vice-presidente iracheno Tareq Aziz, questi paesi dal 1980 avevano estratto 2,1 milioni di barili/giorno anziché i previsti 1,5, facendo perdere all’Iraq 89 miliardi di dollari in dieci anni a causa del prezzo mantenuto basso dalla sovrapproduzione. In particolare proprio il Kuwait aveva approfittato della guerra per aumentare la sua produzione del 20% facendo precipitare il prezzo del petrolio e creando ulteriori problemi al già martoriato Iraq.
Va ricordato che il Kuwait era riserva di caccia personale dei Bush, che avevano fatto fortuna grazie alla Zapata Petroleum Company, la società di famiglia che aveva sfruttato prima il petrolio off-shore texano negli anni Cinquanta e successivamente quello kuwaitiano.
Il Kuwait, i cui investimenti all’estero nel 1986 avevano superato le entrate petrolifere, e che pertanto non era interessato ad agire sul prezzo del greggio attraverso un calo della produzione, rimase quindi sordo alle rivendicazioni irachene. Saddam vide nel rifiuto opposto dall’emiro del Kuwait una dichiarazione di guerra, e il 2 agosto 1990, in seguito al fallimento delle trattative di Gedda, diede l’ordine alle sue truppe di invadere il paese. All’arrischiata iniziativa non fu estraneo l’atteggiamento dall’ambasciatrice statunitense a Baghdad, April Glaspie, che fece intendere che gli Stati Uniti non si sarebbero immischiati in dispute tra arabi.
L’invasione allarmò la comunità internazionale perché occupando il Kuwait l’Iraq avrebbe controllato il 20% delle riserve mondiali di greggio. Su iniziativa statunitense scattò l’operazione Desert Shield (Scudo nel deserto), ufficialmente a protezione dell’Arabia Saudita, e cominciarono ad affluire nel regno 200.000 militari. Contemporaneamente venne orchestrata la commedia delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu con le quali si condannava l’invasione e si intimava all’Iraq il ritiro immediato. Il 6 agosto lo stesso Consiglio votò contro Baghdad l’embargo economico più esteso mai imposto ad un paese, impegnando tutti gli Stati membri dell’Onu a sospendere qualsiasi tipo di scambio commerciale con l’Iraq, e nominò un’apposita commissione per controllare l’applicazione delle sanzioni. L’embargo comprendeva i medicinali, i fertilizzanti e moltissimi prodotti alimentari.
In risposta, l’8 agosto, il Consiglio della Rivoluzione iracheno approvò l’annessione del Kuwait all’Iraq come diciannovesima provincia: storicamente l’emirato, prima di divenire un protettorato britannico nel 1899, aveva fatto parte della provincia irachena di Bassora all’interno dell’Impero Ottomano.
Il 10 agosto, nel corso della Conferenza al vertice svoltasi al Cairo, dodici paesi arabi aderirono all’alleanza anti-irachena capeggiata dalla casa Saud, tutti gli altri, ad eccezione della Libia, si astennero.
L’amministrazione Bush senior coinvolse nell’operazione la Gran Bretagna, la Francia, l’Italia, l’Olanda, il Canada e l’Urss. Dalla propaganda orchestrata per mesi dagli Usa sullo stile del marketing commerciale, che tendeva a presentare Saddam Hussein come un dittatore spietato e sanguinario e gli Usa con il nobile obiettivo di riportare la pace e la libertà nel Medio Oriente, si passò nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1991 ai bombardamenti aerei di Baghdad da parte della coalizione, dando inizio alla guerra che passerà alla storia col nome di Desert Storm (Tempesta nel deserto). Dopo sei settimane di bombardamenti e pochi giorni di operazioni di terra, che portarono gli alleati a 240 chilometri da Baghdad, terminò quella che venne chiamata la Prima Guerra del Golfo.
Il Kuwait fu “liberato”, ma il regime di Saddam rimase in piedi in un paese pressoché distrutto: far cadere allora il Baath avrebbe rischiato di destabilizzare tutto il Medio Oriente, con pesanti ripercussioni sul fronte del petrolio. La guerra fu il primo tentativo da parte degli Stati Uniti di imporre il Nuovo Ordine Mondiale sull’area del Golfo dopo la fine della Guerra fredda.
L’Iraq diventò un boccone da azzannare da tutte le parti: le rivolte tribali, ribattezzate intifada, sciita a sud e curda a nord, fomentate dagli americani, le sanzioni mantenute integralmente anche dopo la liberazione del Kuwait, le condizioni capestro imposte dall’Onu, fra cui l’istituzione di una no-fly zone, cioè di un’area interdetta all’aviazione irachena nel Kurdistan iracheno e nel sud sciita, che di fatto sottrasse quei territori al controllo del governo centrale, il risarcimento dei danni di guerra, l’imposizione delle ispezioni Onu sugli arsenali iracheni. Queste misure finirono per affossare definitivamente l’idealità e la possibilità di Nazioni indipendenti faticosamente propagandate nel Ventesimo secolo.
Gli Usa impressero una nuova accelerazione dopo l’elezione a presidente di George Bush junior, i cui legami col mondo dei petrolieri erano ben noti. Il 28 gennaio 2000, appena eletto, Bush fece mettere in agenda dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il problema mediorientale, in previsione di una deregolamentazione dell’energia. Una Commissione creata ad hoc sotto la direzione del fedele Dick Cheney (anch’egli legato all’ambiente del petrolio) e formata da membri del gruppo Enron, allora uno dei grandi mondiali dell’energia, fu incaricata della fattibilità del progetto. Quando nel 2003 la Corte Suprema metterà le mani sui documenti prodotti dalla Commissione (nel frattempo la Enron era stata al centro di un clamoroso fallimento), scoprirà una cartina dell’Iraq risalente al marzo 2001 in cui si evidenziava una zona alla frontiera con l’Arabia Saudita, estesa per circa un terzo dell’intero paese, frazionata in otto lotti ai fini dello sfruttamento petrolifero. Niente di strano che l’Iraq fosse visto come una fonte petrolifera ausiliaria alle riserve dell’alleato saudita, oltre che come una fonte di facili sovrapprofitti per le Compagnie americane.
Ma non erano solo gli americani a puntare sull’Iraq. Il 19 aprile 2011, il giornale britannico The Indipendent rivelerà i disegni “segreti” alla base dell’intervento militare del governo Blair in Iraq nel 2003: la Shell e la Bp incontrarono a più riprese i responsabili del governo inglese per accaparrarsi in anticipo la partecipazione alla spartizione del petrolio iracheno. Il ministero degli Affari Esteri aveva redatto un memorandum di questo tenore: «L’Iraq è un grosso fornitore potenziale di petrolio. Bp vuole assolutamente essere della partita e teme che accordi politici sfavorevoli le facciano perdere questa enorme opportunità».
Così, il 20 marzo 2003, fu sferrata una nuova guerra contro lo sventurato Iraq, questa volta con il pretesto delle “armi di distruzione di massa” possedute da Saddam Hussein, che non saranno mai trovate. I tempi erano maturi per gli anglo-americani di sbarazzarsi del “dittatore”. Come prima cosa allungarono le mani sul Ministero del Petrolio e sui giacimenti. Il paese fu consegnato al caos, teatro di una serie interminabile di attentati, di guerre civili, di scontri religiosi, di lotte fra clan, mentre la vita per la popolazione diventava un inferno, spesso priva anche dei conforti primari come acqua ed elettricità.
I campi petroliferi furono messi progressivamente all’incanto da parte di un governo iracheno più o meno legittimo: i pretendenti erano molti e di tutte le nazionalità, ma i contratti più consistenti furono assegnati a Exxon, Shell e Mobil. I contratti siglati a seguito dell’invasione avevano una durata ventennale e interessavano la metà delle riserve irachene.
Nel marzo 2006 fu istituita su iniziativa del Congresso americano e del presidente Bush una commissione denominata Gruppo di Studio sull’Iraq, composta da dieci membri, democratici e repubblicani, e presieduta dall’avvocato ed ex-Segretario di Stato James Baker, il cui scopo era quello di ridefinire la politica statunitense in Iraq. Baker era tutt’altro che estraneo all’ambiente dell’industria petrolifera, anzi il suo studio legale era tra i maggiori consulenti delle Compagnie americane. Il rapporto partorito da Baker prevedeva la privatizzazione totale della Compagnia Petrolifera Irachena a favore – naturalmente sotto protezione delle forze armate statunitensi – delle Compagnie private americane, le quali ottenevano così quello che era stato loro rifiutato prima della guerra: mettere le mani sul petrolio iracheno ancora nel sottosuolo. Molto democraticamente, il rapporto raccomandava di sospendere ogni aiuto militare, economico e politico al governo iracheno nel caso che le proposte avanzate non avessero avuto seguito.
41. Il prezzo del greggio
Non bisogna dimenticare che le fluttuazioni dei prezzi della materia prima vanno ad agire sulla composizione organica del capitale ed hanno sempre un’incidenza diretta sul saggio di profitto, anche quando non esercitano alcuna azione sul salario, quindi neanche sul saggio e sulla massa del plusvalore. Come scriveva Marx, la materia prima costituisce un elemento essenziale del capitale costante, e supposto che le altre circostanze (macchinario, numero degli operai, saggio del plusvalore, ecc.) rimangano invariate, il saggio del profitto decresce o aumenta in ragione inversa del prezzo della materia prima. Infatti, «se il prezzo della materia prima decresce di un importo d, il saggio del profitto che è uguale a pv/C, ossia a pv/c+v, si trasforma in pv/C-d oppure, che è lo stesso, pv/(c-d)+v. Di conseguenza il saggio di profitto aumenta. Viceversa, se il prezzo della materia prima sale, pv/C diviene pv/C+d ovvero pv/(c+d)+v; di conseguenza il saggio di profitto diminuisce» (Il Capitale, III). Ne risulta l’importanza fondamentale della materia prima petrolio per i suoi molteplici impieghi industriali nell’economia capitalistica, e di conseguenza il peso politico da esso esercitato all’interno dei rapporti imperialistici fra le grandi potenze.
Le variazioni del prezzo del petrolio dipendono, prima che dalla speculazione, dalla rendita, a sua volta dipendente dall’andamento della crisi di sovrapproduzione industriale.
Tuttavia la media annuale del periodo non è mai scesa al di sotto dei 14/15 dollari correnti al barile (18/20 dollari del 2010). L’oscillazione si mantiene sempre al di sopra di un prezzo minimo. Per un valido motivo: considerato che nel 1978 il costo di un barile di petrolio estratto negli Usa era 69 volte più elevato di quello estratto in Arabia Saudita (8,06 dollari/barile contro 0,13), e sapendo che un petrolio a basso costo sarebbe destinato ad espellere dal mercato il petrolio di costo più elevato, si capisce che il prezzo minimo è necessario per scongiurare il blocco della produzione statunitense. Ovviamente, gli Usa non escludono il ricorso alla forza militare per proteggere la sicurezza dei loro rifornimenti petroliferi “ad un prezzo ragionevole”. Nel 1986, la guerra dei prezzi sfondò il prezzo minimo, costringendo l’allora vice-presidente americano Bush senior a precipitarsi in Arabia Saudita per mettere le cose a posto.Seguendo la curva dei prezzi del petrolio in dollari correnti e in dollari costanti (cioè depurati delle variazioni dovute all’inflazione), si nota che il prezzo medio del greggio dal 1900 al 1970 è rimasto stabile. Dopo il 1973 aumenta l’ampiezza delle oscillazioni e il prezzo sembra più difficile da controllare: abbiamo due impennate nel 1973-1974 e nel 1979-1980, un crollo nel 1986, una stagnazione nel periodo 1975-1978, un’erosione tra il 1982 e il 1985, una volatilità a partire dal 1987, ma un aumento regolare dopo il 1999 ad eccezione del picco vertiginoso ma effimero nel 2008.
Mentre i paesi Opec con meno riserve o con fabbisogni finanziari elevati (come l’Iran e l’Iraq dopo la guerra del 1980) puntano a massimizzare i prezzi, l’Arabia Saudita, con il suo 40% di riserve provate, ha sempre giocato un ruolo importante di stabilizzazione a vantaggio degli Stati Uniti, in cambio di protezione e aiuti militari.
42. Produttori, produzioni, consumi
Il petrolio è un olio, originato da processi biologici o abiotici, imprigionato in giacimenti sotterranei (Stati Uniti, Canada, Russia, Medio Oriente, Venezuela, ecc.) o in fondo al mare (Caspio, Golfo del Messico, Mare del Nord, Golfo di Guinea, coste del Brasile). Nonostante le misure di risparmio energetico e il crescente utilizzo del gas naturale e del nucleare, ma soprattutto nonostante la cronica crisi generale di sovrapproduzione, il mondo consuma annualmente circa tre miliardi di tonnellate di prodotti petroliferi.
Secondo i dati forniti dall’Agenzia Internazionale per l’Energia nel 2007 il consumo energetico mondiale è stato di 8,2 miliardi di Tep, contro i 4,7 del 1973. Il Tep, tonnellata di petrolio equivalente, è l’unità di misura del potere calorico ed equivale a 1,43 tonnellate di carbone di alta qualità. La produzione di energia primaria fu di 12 miliardi di Tep, provenienti per l’80,4% dalla combustione di energia fossile (petrolio, carbone, gas) e per il resto dal nucleare.
La maggior parte del petrolio è fornita da solo otto Compagnie. Quella del petrolio (carburanti, plastiche, tessuti sintetici, ecc.) è la maggiore industria mondiale. Tra le prime dieci società industriali ben otto sono petrolifere, e di queste quattro sono americane. Nel 2011, a conclusione di un incessante processo di ristrutturazione e di concentrazione, a svettare nel mondo del petrolio sono rimaste cinque grandi multinazionali con attività in tutti i settori (banche, servizi, trasporti, ecc.): al primo posto, con base a Dallas, troviamo la Exxon Mobil Corporation, diretta discendente della Standard Oil di Rockefeller, con le sue 45 raffinerie in 25 paesi diversi e 42.000 stazioni di servizio; in California c’è la Chevron, che nel 2005 si è fusa con la Texaco ed l’Unocal; poi c’è la francese Total (sorta dalla fusione di Total, Fina ed Elf), che nel 2011 ha acquisito il gigante del gas Gdf Suez con partecipazioni nei giacimenti del Mare del Nord; ci sono poi l’anglo-olandese Shell e la Bp (la ex Anglo-Persian Oil Company), che nel 2004 ha acquisito il 50% della compagnia petrolifera russa Tnk, ora Tnk-Bp, titolare di concessioni nell’Artico.
Secondo Wikipedia Fortune Global 500, queste multinazionali sono nel novero delle società industriali più ricche del globo quanto a fatturato: la Shell è in seconda posizione dietro Wal-Mart, leader americana della grande distribuzione; subito dopo seguono Exxon al terzo posto e la Bp al quarto; al quinto e al sesto posto ci sono le Compagnie cinesi Sinopec e China National Petroleum; in decima posizione troviamo la Chevron e in undicesima la Total. Se invece guardiamo ai profitti realizzati, cambia l’ordine: 1° Exxon, 2° Shell, 3° Chevron, 4° Wal-Mart, 5° China Petroleum Corporation, 6° Total.
Nel periodo 2003-2007, i principali paesi importatori di petrolio sono stati gli Usa con il 23,5% della percentuale mondiale, l’Europa occidentale con il 26,8%, il Giappone per il 9,6%. La maggior parte degli scambi origina dal Medio Oriente con destinazione Europa, America settentrionale e Giappone. L’Africa esporta soprattutto verso gli Usa e l’Europa occidentale, mentre la Russia soprattutto verso l’Europa dell’Est. La produzione del Mare del Nord è destinata all’Europa. Il consumo di petrolio è quasi sestuplicato nel periodo dal 1950 al 1973, mentre tra il 1973 e il 2002 è aumentato soltanto di 1,25 volte.
Si è anche assistito a un radicale mutamento delle gerarchie nell’ambito delle diverse fonti energetiche: se nel 1950, il petrolio rappresentava il 27% del totale dei consumi energetici, contro il 62% del carbone e il 10% del gas naturale, già nel 1970 esso copriva il 48% della domanda di energia mondiale, contro il 31% del carbone e il 18% del gas. La produzione energetica mondiale commercializzata nel 2008 è derivata per il 34% dal petrolio, per il 24% dal gas naturale, per il 29% dal carbone, per il 6% dall’idroelettrico, per il 5% dal nucleare, per l’1% dall’eolico e per lo 0,04% dal fotovoltaico (Bp Statistical Review of World Energy, 2009). Si prevede che nel 2020, il petrolio sarà sempre la prima fonte di energia (40%), contro il 24% del carbone, sempre più rimpiazzato dal gas naturale (24%).
Secondo uno studio del gennaio 2011 pubblicato dalla Documentation Française e riferito all’anno 2010, i principali paesi produttori di petrolio, sugli oltre 90 esistenti, sono: Russia (12,9% della produzione mondiale), Arabia Saudita (12%), Usa (8,5%), Iran (5,3%), e Venezuela, Cina, Messico, Norvegia, Iraq, Nigeria, Brasile, Regno Unito (dal 3 al 5% ciascuno). L’offerta è praticamente stabile da diversi anni e si aggira attorno agli 85-87 milioni di barili/giorno.
Nel 2009, i principali consumatori in ordine decrescente sono stati: Usa (21,7%), Cina (10,4%), Giappone (5,1%), India (3,8%), Russia (3,2%), Arabia Saudita (3,1%), Germania (2,9%), Brasile (2,7%). La percentuale della Cina potrebbe arrivare nel 2030 al 20% del totale mondiale (contro il 5% del 2002). Nel gruppo del G20, che rappresentano l’85% del commercio mondiale e i 2/3 della popolazione, queste le quote dei consumi energetici: Cina 25%, Usa 22%, Unione Europea 16%, Russia 7%, India 7%, Giappone 5%, Brasile 3%. In alcuni paesi come Francia e Giappone, il gas e l’energia nucleare hanno sostituito il petrolio, soprattutto per la produzione di elettricità. Nei paesi industrializzati, il 54% del petrolio è consumato nei trasporti.
Nel 2010, il consumo mondiale di petrolio ha toccato il record di 87,4 milioni di barili/giorno (52,7% nei paesi OCSE, 47,4% nei paesi non-OCSE). Rispetto agli anni precedenti, l’aumento più consistente ha riguardato Usa, Brasile, Russia, Medio Oriente e Cina.
Nel 2010, il consumo di energia (non solo petrolifera) a livello mondiale è aumentato del 5,5%, dopo il declino dell’1% dell’anno precedente. I paesi emergenti hanno contribuito per i 2/3 di questo aumento (la Cina da sola ha coperto un quarto della crescita energetica totale).
L’estrazione del petrolio mediante frantumazione idraulica si è sviluppata soprattutto in Nord America, dove ha provocato l’inquinamento delle falde freatiche.
Quanto all’energia prodotta dal vento e dal sole, bisognerà forse aspettare il comunismo, che sarà incurante di alti costi di produzione, perché possa svilupparsi.
Secondo i dati dell’Aie, nel 2006 l’energia è stata utilizzata per il 28% dall’industria, per il 27% dai trasporti, per il 24% dalle utenze domestiche e soltanto per il 2% dall’agricoltura.
43. Le riserve
Nel 2009 le riserve accertate mondiali, cioè le quantità estraibili in un momento dato, superiori ai mille miliardi di barili, sono concentrate in limitate aree geografiche: il Medio Oriente ne possiede il 60% (il 19,8% l’Arabia Saudita, l’8,6% l’Iraq, il 7,3% gli Emirati Arabi Uniti, il 7,6% il Kuwait, il 10,3% l’Iran), il Venezuela il 12,9%, la Russia il 5,6%, la Libia il 3,3%, il Kazakistan il 3%, la Nigeria il 2,8%, il Canada il 2,5%, gli Usa il 2,1%, e meno del 2% tutti gli altri.
Conoscere lo stato reale delle riserve è faccenda assai complicata, non solo perché le informazioni provengono sostanzialmente da chi è interessato a non scoprire le carte, cioè le Compagnie e i paesi produttori, che gonfiano la consistenza delle loro riserve. Le condizioni geologiche del sottosuolo, la posizione geografica, la tipologia del greggio, lo sviluppo delle tecniche, l’andamento dei prezzi sono tutti elementi che concorrono a rendere rilevante o meno un giacimento in termini economico-industriali. Nonostante che dagli anni Sessanta non siano stati più scoperti giacimenti di grandi dimensioni, pure è cresciuta la consistenza delle riserve grazie alle nuove tecniche di estrazione che hanno reso appetibili campi prima antieconomici.
Le previsioni delle cassandre che vedono dietro l’angolo la “fine del petrolio” sono da valutare in queste dinamiche. Così, secondo alcuni geologi americani, che hanno rivisto al ribasso le cifre fornite dall’Opec, le riserve residue dell’Arabia Saudita, il maggiore esportatore mondiale di petrolio, ammonterebbero soltanto a 50-60 miliardi di barili, una quantità equivalente a soli due anni di consumo mondiale!
Il vero problema è semmai che l’80% degli 85 milioni di barili consumati giornalmente provengono da un nucleo ristretto di paesi, che così acquisiscono un’importanza enorme. L’Agenzia Internazionale per l’Energia, che raggruppa i principali paesi consumatori ma è sotto influenza americana, a questo proposito è decisamente catastrofista: in un rapporto del 2009 sosteneva che bisognerebbe moltiplicare per quattro le riserve dell’Arabia Saudita per poter soddisfare il fabbisogno mondiale.
Infatti la domanda globale di energia tende a salire per l’entrata sul mercato di nuovi grandi consumatori come Cina e India. Inoltre il petrolio resta la materia prima fondamentale per la fabbricazione di una infinità di prodotti, dai tessuti sintetici alle materie plastiche. Per altro l’impiego di tecniche sofisticate di perforazione del suolo (anche fino a 12 chilometri di profondità) fanno aumentare enormemente i costi di produzione rendendo gli investimenti sempre meno redditizi.
44. Una sola alternativa: la rivoluzione
L’Opec è ormai un cartello dilaniato tra i paesi incatenati agli interessi dell’imperialismo americano, come Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi (che per mantenere bassi i prezzi, soprattutto in funzione antirussa, hanno aumentato la produzione durante il conflitto libico del 2011 e in occasione della crisi ucraina del 2014), e i “falchi” come Iran e Venezuela, legati piuttosto agli imperi russo e cinese. Il timore di una recessione mondiale, e quindi di una diminuzione drastica del consumo di petrolio, addensa nubi all’orizzonte.
L’unica soluzione sensata, ossia fermare la corsa al profitto, e quindi ridurre sia la produzione sia il consumo di energia, implica la distruzione del potere politico delle borghesie mondiali.
Scriveva Henri Kissinger nel giugno 2005: «La domanda e la competizione per l’accesso all’energia potrebbero diventare ragione di vita e di morte per molte nazioni». La Russia e gli Stati Uniti, che possiedono sul proprio territorio notevoli riserve energetiche, controllano militarmente sia le zone di produzione sia le rotte di rifornimento verso l’Occidente. I russi presidiano l’area del Caspio, ma con il loro enorme potenziale di risorse puntano apertamente al mercato europeo: Gazprom è ormai una multinazionale a tutti gli effetti, che è entrata nella corte dei Grandi.
Notiamo che è oggi un lontano ricordo lo scudo americano costruito nel 1955 per contenere l’espansionismo dell’Urss nella regione del Golfo, il Patto di Baghdad che univa Turchia, Iraq, Iran e Pakistan in un trattato di mutua difesa antisovietica. La questione siriana rende l’area ancora più esplosiva: un intervento internazionale occidentale in Siria dovrebbe fare i conti con l’opposizione della Russia, che ha firmato con Assad un accordo per la costruzione di una base di sottomarini nucleari sul Mediterraneo, e anche della Cina, del Brasile e dell’India.
Gli Usa, approfittando dei ricorrenti conflitti che attraversano il Medio Oriente, hanno impiantato nell’area dove sono ubicate oltre il 60% delle riserve mondiali di greggio un numero impressionante di basi militari, sulla terraferma e sul mare. Dopo aver fornito appoggio ai peggiori regimi della regione e contribuito al sorgere del terrorismo islamico, oggi gli Stati Uniti vogliono far credere di voler cambiare strategia e di voler aprire alla democrazia nell’area del Medio Oriente e del Maghreb lacerata da profonde trasformazioni sociali e politiche. In realtà si tratta dell’ennesima giravolta che dietro la finzione democratica nasconde il cinico obiettivo di realizzare, attraverso le guerre, un grande supermercato per i bisogni strategici ed energetici americani.
Intanto il dragone cinese, sempre più energivoro, stringe alleanze con tutti i paesi ricchi di risorse (Russia, Venezuela, paesi africani), le sue Compagnie petrolifere cercano di strappare le condizioni migliori, attraverso le sue potenti banche che erogano finanziamenti a mezzo mondo, e con la partecipazione diretta e indiretta ai conflitti locali. Lo scontro con gli altri imperialismi è alla lunga inevitabile, dal momento che quello cinese è un capitalismo in piena espansione e protende i suoi tentacoli verso i quattro angoli del mondo, dall’Indonesia al Medio Oriente all’Africa nera.
In Niger per esempio, che è già una delle sue roccheforti petrolifere, la Cina punta a mettere le mani sull’uranio di cui il paese è ricchissimo, che però è indispensabile anche per l’industria nucleare francese. Forse si capisce il fervore dei francesi nel voler liberare a tutti i costi la Libia dal “dittatore” Gheddafi, vista l’importanza strategica del paese nord-africano per il controllo dell’Africa centrale.
Dietro i monopoli economici ci sono dunque le grandi potenze vecchie e nuove che puntano a spartirsi il pianeta. Scrive Lenin ne “L’Imperialismo”:
«Più il capitalismo è sviluppato, più la mancanza di materie prime si fa sentire, più la concorrenza e la ricerca delle fonti di materie prime in tutto il mondo è accanita, e più è brutale la lotta per il possesso delle colonie».
Se si sostituisce il termine colonie con semi-colonie – lasciando agli sprovveduti l’illusione che esistano paesi “indipendenti” – il passo di Lenin illumina anche la situazione di oggi.
«Non potendosi fermare il ritmo di inferno della accumulazione, questa umanità, parassita di se stessa, brucia e distrugge sopraprofitti e sopravalori in un girone di follia, e rende sempre più disagiate e insensate le sue condizioni di esistenza. L’accumulazione che la fece sapiente e potente la rende ora straziata e istupidita, fino a che non sarà dialetticamente capovolto il rapporto, la funzione storica che essa ha avuto» (“Vulcano della produzione o palude del mercato?”).
Da questa lotta infernale, da questo consumo ad oltranza di energia che distrugge il mondo dei viventi, da questa spirale incontrollabile di disperazione nella quale è precipitato il sistema capitalista con tutti i suoi mercenari, il proletariato non ha nulla da sperare se non massacri fratricidi, distruzioni, miseria, sofferenze e guerre interimperialiste senza fine.
Il capitalismo ha ormai compiuto il giro del mondo: la contrapposizione Est-Ovest, la questione coloniale e la questione nazionale non sono più un motore di rivoluzioni e motivo di mobilitazione per i lavoratori e per le masse diseredate. All’ordine del giorno c’è soltanto la lotta radicale del proletariato internazionale contro la borghesia internazionale. Rinascano in tutti i paesi le organizzazioni di classe strette al loro unico partito comunista per affrontare e finalmente abbattere il vampiro capitalista e tutti i suoi traffici mercantili.
È necessario uccidere il capitalismo affinché l’umanità possa vivere.
tratto da http://international-communist-party.org/
Leggi anche: