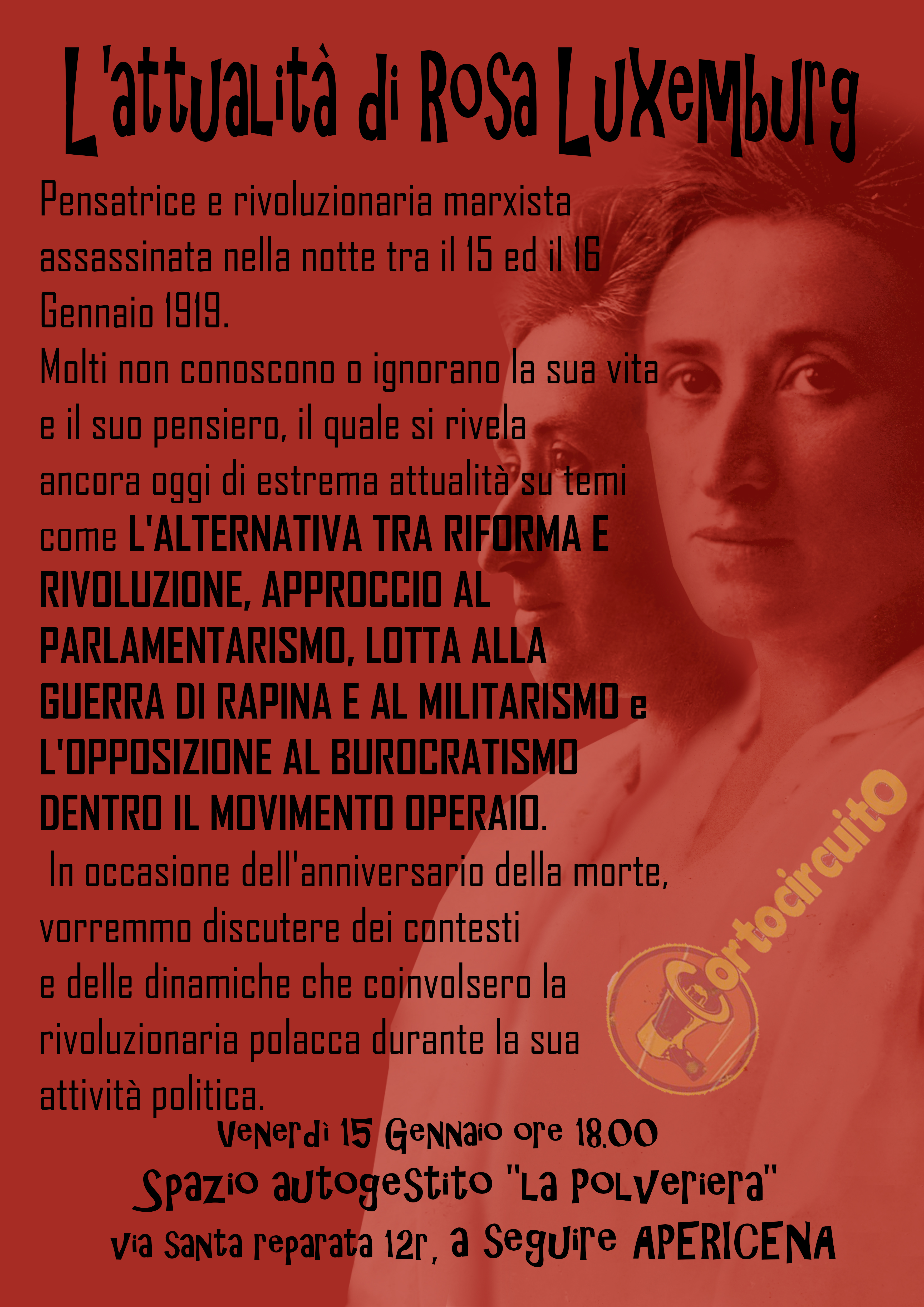Siria – La macchina di morte di Bashar al-Assad
di Benjamin Barthe, da A l’encontre
Il 15 dicembre 2015, il segretario di Stato americano, John Kerry,incontrava a Mosca, per la seconda volta in quest’anno, Vladimir Putin e il Ministro degli esteri, Sergei Lavrov.Formalmente si trattava di preparare la riunione del 18 dicembre 2015 a New York, del Gruppo di lavoro internazionale sulla Siria. Il Cremlino sostiene, appoggiandosi sul suo intervento militare in Siria da settembre a sostegno di Bashar al-Assad, la formazione di una grande coalizione, formalmente sotto mandato ONU, con un invito rivolto al governo siriano.
È in atto una vasta operazione di riposizionamento delle influenze delle potenze imperialiste, internazionali e regionali. Si esprime una convergenza: «Noi tutti combattiamo i criminali di Daesh», che sono effettivamente tali. La coalizione militare contro Daesh, che dovrebbe riunirepiù strettamente la Russia, l’Iran, gli Stati Uniti, la Francia e il regime di Assad risponde, se si può usare il termine, a un voto di Daesh. In altre parole, Daesh potrebbe sostenere che è«lasola a battersi contro tutte queste forze per proteggere la comunità sunnita ».
In questo contesto, all’Arabia Saudita impantanata in una guerra criminale allo Yemen, chefavorisce e nutre la presenza dei gruppi Al Qaida e Stato islamico a Aden e nell’est del paese è stato chiesto dagli Stati Uniti di mettere assieme una pretesa coalizione di 34 Stati, che diconotutti di appartenere al sunnismo.
Sull’altro versante, la mullah – crazia dell’Iran, che apporta il suo appoggio militare sul terreno a quel che resta dell’esercito di Bashar al- Assad,gioca la stessa carta, ossia cerca di rivestire la difesa dei propri interessi con un manto religioso settario sciita. E questo è un calco del marketing politico-militare e wahabita del Regno dei Saud.
Ora, per porre fine alle sofferenze terrificanti della larghissima maggioranza della popolazione siriana, bisogna evidentemente che la guerra in Siria si fermi. Questo non è possibile fino a che non viene messo da parte Bashar al-Assad, che è all’origine di tutti i mali che colpiscono la popolazione – compreso nelle regioni cosiddette sotto il suo controllo e anche a Damasco – e della continuazione della guerra in Siria.
Per la Russia putiniana, Bashar al-Assad è un regime cliente. Anche il dittatore egiziano Abdel Fattah al-Sissi riceve un aiuto militare da Putin. Il Cremlino, per consolidare la propria posizione in Siria e avanzare le sue pedine nella regione, fa passare un messaggio politico e militare: i regimi dittatoriali, vecchi o prodotti dalla controrivoluzione post-primavere arabe, possono contare su Mosca.
In tale contesto, era prioritario (dalla fine del 2011) e rimane tale, fornire un armamento difensivo (anticarri, antiaerei) alle forze certamente disperse, che affrontano l’esercito di Assad, e insieme le sue bande mafiose (gli Shabiha), i «legionari» di Hezbollah e i Guardiani della Rivoluzione iraniani, mentre combattono i criminali di Daesh.
Quindi, costringere alcune componenti dell’opposizione siriana al regime degli Assad ad accettare pubblicamente di negoziare con la dittatura, come illustrano i negoziati che sembrano essersi conclusi a Riyad l’11 dicembre – sotto l’egida degli Stati Uniti – non fa che ripetere il rifiuto, tra gli altri nell’agosto 2013 (utilizzo di armi chimiche), di portare un aiuto militare difensivo alle forze che lottano sul terreno.
Le manovre diplomatiche che mirano ad allargare e riorganizzare delle coalizioni militari in nome della lotta contro Daesh, produrranno quasi certamente un prolungamento della guerra civile e della spietata repressione del regime contro qualsiasi oppositore, o più esattamente qualsiasi persona considerata dal dittatore come un oppositore. E i barili di TNT, come i bombardamenti, non fanno distinzione tra i civili e i cosiddetti terroristi. Non si tratta nemmeno di danni collaterali, formula eufemistica utilizzata dai militari, ma dell’instaurazione di un terrore di massa, per ripulire un quartiere, una città, una regione.
Inoltre, nella politica di una lotta cosiddetta prioritaria e unilaterale contro Daesh, tutto porta a propagare una forma di negazionismo sui crimini contro l’umanità, riconosciuti in diverse procedure, di Bashar al-Assad e dei suoi complici. E, in ultima istanza, di farlo rinascere come cardine di una possibile pace in Siria.
Abbiamo qui una riprova del «realismo politico e diplomatico» imperialista – degli Stati Uniti, della Russia o sotto altre modalità, delle potenze regionali loro partner minori – che ha portato ai disastri che i paesi e le popolazioni di questa regione hanno conosciuto nel corso degli ultimi due secoli. Il rapporto di Human Rights Watch presentato qui da Benjamin Barthes, basta a qualificare il regime di Assad e anche a designa re quanti lo sostengono.
*****
La macchina di morte di Bashar al-Assad
di Benjamin Barthe
 Si sapeva di «Cesare», il fotografo della polizia militare siriana, che ha defezionato nel 2013, portando con sé i negativi di migliaia di cadaveri, quelli dei siriani morti nelle carceri del regime di Assad. La sua storia è stata ricostruita dalla giornalista Garrance Le Caisne in un libro-intervista (Opération César, Stock, 240 pgg., 18 euro). Ora si conoscono i nomi e le storie di alcuni di questi prigionieri, che lui e i suoi colleghi erano incaricati di fotografare dopo la loro morte.
Si sapeva di «Cesare», il fotografo della polizia militare siriana, che ha defezionato nel 2013, portando con sé i negativi di migliaia di cadaveri, quelli dei siriani morti nelle carceri del regime di Assad. La sua storia è stata ricostruita dalla giornalista Garrance Le Caisne in un libro-intervista (Opération César, Stock, 240 pgg., 18 euro). Ora si conoscono i nomi e le storie di alcuni di questi prigionieri, che lui e i suoi colleghi erano incaricati di fotografare dopo la loro morte.
In un rapporto di 90 pagine che Le Monde si è procurato in esclusiva prima della sua presentazione a Mosca, mercoledì 16 dicembre, l’organizzazione di difesa dei diritti dell’uomo, Human Rights Watch (HRW) fornisce l’identità di otto di queste vittime, ricostruisce il loro arresto e il loro percorso carcerario e indica le cause della loro morte: la fame, la malattia o la tortura.
In un’intervista concessa il 20 gennaio 2015 alla rivista americana Foreign Affairs, il presidente siriano, Bashar al-Assad, aveva espresso dei dubbi sull’autenticità del dossier César. «Chiunque può portare delle fotografie e dire che si tratta di tortura, aveva dichiarato. Sono accuse senza prova». Undici mesi dopo, il rapporto di HRW fornisce le prove e getta un cruda luce sui meccanismi della macchina di morte siriana.
«Crimini contro l’umanità»
«Non abbiamo alcun dubbio che gli individui che appaiono nelle foto di César sono stati affamati, percossi, e torturati in modo sistematico e su scala di massa, afferma Nadim Houry vice direttore di HRW per il Medio Oriente. Rappresentano solo una frazione delle persone che sono morte mentre erano in custodia del governo siriano. Altre migliaia hanno subito la stessa sorte», aggiunge il sig. Houry che parla di «crimini contro l’umanità».
Il caso César scoppia all’inizio dell’anno 2014. A Montreux, in Svizzera, all’apertura della conferenza di pace battezzata Ginevra 2, oppositori siriani brandiscono fotografie di corpi scarniti, lacerati, con il viso bloccato in un ultima contorsione. Fanno parte di uno stock di 53.000 negativi che un fotografo legale è riuscito a fare uscire dalla Siria, prima di fuggire, nell’agosto 2013, con la complicità di membri del Movimento nazionale siriano (MNS), una formazione islamista moderata.
Per proteggere il suo anonimato, al disertore viene dato il nome di César. Una squadra di medici legali e di ex procuratori internazionali, riunitada uno studio legale londinese, si è immersa nella massa di immagini e ha raggiunto la convinzione che è «molto poco probabile » che possano essere state falsificate. Ma poiché il loro rapporto [http://fr.scribd.com/doc/200984823/Syria-Report-Execution-Tort] è finanziato dal Qatar, un avversario feroce del potere siriano, la sua imparzialità è messa in discussione da alcune fonti.
«Io stesso ho portato i corpi»
Molto presto, però, le foto di César cominciano a «parlare». Famiglie siriane riconoscono il volto di uno dei loro nelle prime foto diffuse da alcuni siti dell’opposizione. L’MNS, al quale il fotografo ha affidato il suo bottino, carica una grande parte delle foto su internet, poi trasferisce la totalità degli archivi al MNS. In tre mesi, più di 700 siriani contattano l’associazione, affermando di avere identificato un padre, un fratello o un marito.
Una parte delle 53.000 foto rappresenta soldati morti in combattimento e un’altra fissa delle scene di attacco dei ribelli. La parte più grande dello stock, 28.000 foto, corrisponde a persone morte nei centri di detenzione dei servizi di sicurezza, i mukhabarat. Questi cadaveri si distinguono per tre cifre tracciate sulla clavicola o su un pezzo di cartone attaccato al corpo. Queste indicano la branca dei servizi di sicurezza che li ha arrestati, il loro numero da detenuti e il loro numero di decesso. Da informazioni fornite a HRW da quattro disertori, familiari con queste procedure.
Le loro testimonianze, i documenti ufficiali che accompagnano le foto, e una verifica per geolocalizzazione, permettono di certificare, secondo il rapporto, che le foto sono state prese negli ospedali militari di Tichrin, a nord di Damasco, e di Mezzeh, a sudest, due siti nei quali i mukhabarat vengono a scaricare i loro morti a intervalli regolari. «Riconosco il luogo a partire dalle foto, ogni pietra ogni mattone. Ho vissuto là per ventiquattrore al giorno. Io stesso ho portato i corpi», racconta un ex coscritto assegnato all’ospedale Mezzeh, non lontano dal palazzo presidenziale e dal liceo francese di Damasco.
Dato che ogni corpo è stato fotografato a più riprese, i membri dell’MSN hanno calcolato che i 28.000 negativi di morti in detenzione corrispondono a 6.700 individui diversi, tra i quali 100 bambini.
L’HRW ha condotto un’indagine approfondita su 27 casi. La misura limitata del campione è dovuta a questioni di tempo, di risorse e di localizzazione di testimoni. Per mettere un nome sui visi tumefatti ed emaciati a un punto tale da diventare spesso irriconoscibili, l’ONG ha sollecitato non solo le famiglie, ma anche ex detenuti che hanno visto la vittima in prigione, assistito alla sua morte o visto il suo cadavere.
Estrema magrezza
Il lavoro di identificazione si è appoggiato anche sul confronto tra la data dell’arresto, riferita dalle famiglie, e la data della fotografia, consegnata dalla polizia militare. La localizzazione dei segni distintivi sui corpi ha aiutato a volte, come nel caso di Hussein Al-Dammuni, un giovane contabile dell’Università di Damasco, arrestato nel febbraio 2013, e il cui cadavere è stato identificato grazie a due tatuaggi sul suo braccio sinistro. Nel caso di Rehab Al.-Allawi, una studentessa di Damasco, sottoposta a interrogatorio nel gennaio 2013, è un pezzo di pigiama, riconosciuto su una foto da un’ex codetenuta, che ha permesso di chiudere il caso. Gli autori del rapporto sono stati autorizzati a pubblicare solo otto nomi sui ventisette confermati, a causa della paura di rappresaglie che paralizza molte famiglie.
Le cause dei decessi sono molteplici. Gli esperti medico-legali sollecitati da HRW hanno evidentemente rilevato sulle foto tracce di tortura, una pratica della quale il regime siriano è ghiotto. Anche la fame ha decimato le fila, come dimostra l’estrema magrezza di numerosi corpi. Ma a causa della sovrappopolazione delle celle, della mancanza d’aria, di condizioni di igiene disastrose, dell’assenza quasi totale di assistenza medica, e di un’alimentazione avariata, molti prigionieri sono morti a causa di malattie in apparenza benigne, come la scabbia o infezioni gastrointestinali.
Un ex detenuto citato da HRW, Haytham, evoca quella che lui e i suoi compagni chiamavano «la diarrea nera», una forma iperacuta di disturbo intestinale che portava alla morte in dieci-quindici giorni. « Ho visto le forze di sicurezza porre sotto un lavabo dei detenuti con delle piaghe purulente, racconta un disertore. (…) Esporre le loro ferite all’acqua e all’umidità le faceva peggiorare. Ho visto almeno trenta casi ... È come se la pelle fosse corrosa, come un buco nel corpo».
Questo rapporto è pubblicato due giorni prima di un vertice internazionale a New York, che potrebbe aprire la strada a una ripresa dei negoziati tra il regime e l’opposizione. Una coincidenza che ispira a HRW un avvertimento: «Quanti spingono per la pace in Siria devono assicurarsi che tali crimini cessino e che le persone che hanno diretto questo sistema finiscano per rendere dei conti» (Articolo pubblicato su Le Monde in data 17 dicembre 2015)
Estratto del rapporto di Human Rights Watch
«Le forme più gravi di tortura erano praticate durante gli interrogatori. (…) Durante quelle sedute, gli interroganti e gli ufficiali per lo più volevano ottenere dai detenuti che confessassero di aver partecipato a manifestazioni, che dessero i nomi di altri manifestanti e organizzatori, che riconoscessero di possedere e di avere utilizzato armi, e in certi casi che fornissero informazioni su presunti finanziamenti stranieri delle manifestazioni. Ma numerosi ex detenuti intervistati credono anche che lo scopo principale della tortura non era solo di ottenere informazioni, ma di punire e intimidire i detenuti. Gli interroganti, gli ufficiali e le guardie utilizzavano una vasta gamma di metodi di tortura, tra i quali lunghe sedute di colpi, spesso con oggetti come bastoni e cavi, la sospensione dei detenuti in posizioni stressanti per lunghi periodi, il ricorso all’elettricità e agli elettrochoc (…).
Physicians for Human Rigts [Medici per i Diritti Umani] ha constatato che in un blocco di 72 fotografie che rappresentano 19 vittime, (…) alcuni mostravano segni che corrispondono a più di una forma di tortura. Hanno trovato «la prova che numerosi detenuti avevano subito multiple ferite contundenti. Tali ferite sono spesso mortali, soprattutto per detenuti affamati e privati di sonno (…)». Testimoni hanno segnalato che alcuni detenuti tornavano dalle sedute di tortura con ferite tali che morivano poco dopo.
Haytham descrive la morte di uno dei suoi compagni di cella nel braccio Palestina: « Era una persona di Damasco, Abu Hassan, aveva 39 anni, una corporatura atletica. Lo chiamavano due volte al giorno per l’interrogatorio. Dopo una settimana è tornato in cella coperto di sangue. Tre giorni dopo era in uno stato grave. Sono rimasto con lui negli ultimi quindici minuti [prima della sua morte]. Gli ripetevo di avere pazienza che sarebbe migliorato».
In certi casi, dicono dei testimoni, i detenuti morivano nelle sedute di colpi o di tortura. Il DrMamun ha raccontato a Human Rights Watch che un altro detenuto, arrestato nello stesso suocaso, era stato ucciso durante una seduta di tortura: «Hanno chiamato (…) tre [uomini] [delnostro gruppo. Li hanno sospesi per i polsi. (…) [Due di loro ] sono tornati vivi. Ahmed è tornatomorto. [Un altro detenuto del nostro gruppo] ha detto che lo avevano appeso [ripetutamente] …e che era morto. È stato ucciso, soffocato».
Traduzione di Gigi Viglino, tratto da http://antoniomoscato.altervista.org/index.php