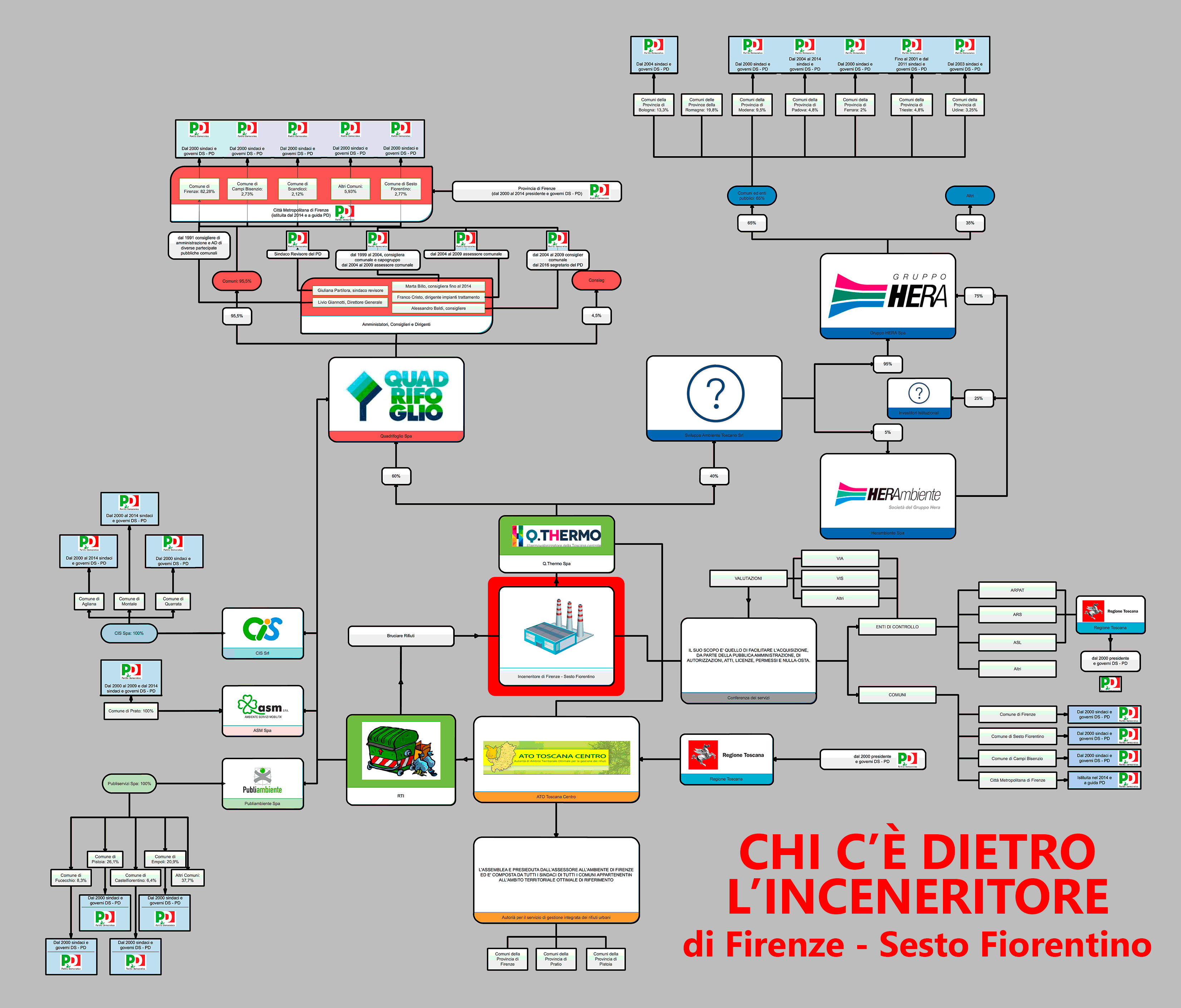Trump presidente? Una sceneggiata americana con anteprima italiana
 Riceviamo da Dino Erba e pubblichiamo:
Riceviamo da Dino Erba e pubblichiamo:
L’articolo di Loren Goldner (di Insurgentes Notes) ci propone per gli Stati Uniti un interessante scenario politico. Uno scenario che, in Italia, abbiamo già visto 25 anni fa, con la Lega di Bossi e con Forza Italia di Berlusconi. La crisi economica non mordeva ancora, tuttavia erano in corso alcuni significativi mutamenti socio-economici. Ciò nonostante, la sinistra cialtrona italiana, come oggi quella yankee, prese sotto gamba quelle forze politiche emergenti, pensando di cavarsela con qualche battutina. Il risultato è che Bossi e il Berlusca, seppure acciaccati, sono ancora sulla scena politica, mentre la sinistra cialtrona è sparita, anzi, ha subito una mutazione genetica, ed è nato il renzismo. Ma questo, forse, è un frutto esclusivamente italiano. O no?
Potrebbe proprio accadere. Quello che un anno fa sembrava un candidato da spettacolo, è ora un vincitore plausibile nell’anno politico più selvaggio dal 1968 (e c’è ancora la prossima «sorpresa di ottobre»).
Qualunque cosa accada, il vecchio sistema dei partiti degli Stati Uniti è rotto. Donald Trump non è assimilabile ad alcun candidato presidenziale a memoria d’uomo. Si deve infatti risalire fino a Eugene Debs, per trovare un candidato apparentemente radicale come Bernie Sanders, mentre per trovare un vero precursore di Trump è ancora più difficile. La garbata eclissi di Sanders in agosto ha fatto sì che milioni di suoi ex-tifosi rimarranno a casa o voteranno per il partito dei verdi. La rispettabile società civile, compresa una buona fetta dell’establishment repubblicano e persino i militari normalmente «apolitici», sono in ritirata o sostengono apertamente la Clinton. Generali, diplomatici, esperti di politica estera e il «New York Times» sono tutti d’accordo sul fatto che una presidenza di Trump sarebbe un disastro. Il «Financial Times» versa lacrime sull’eventuale scomparsa dell’ordine mondiale «internazionalista» (leggi: dominato dagli Usa) in atto dal 1945. Dichiarazioni di questo genere lasciano il tempo che trovano, anzi, aggiungono solo credito e verve «anti-establishment» alla campagna di Trump .
La situazione presenta importanti parallelismi con il referendum del giugno scorso sulla Brexit in Gran Bretagna, quando l’intero establishment politico e accademico, di «sinistra» o di «destra», fece propria l’ipotesi di «rimanere» nell’Unione europea e ne rimediò qualcosa simile a un voto di classe (anche se misto con altri elementi meno significativi) e se la presero nel culo (with a big middle finger).Ecco cosa bolle in pentola negli Stati Uniti.
In poche parole, si sta verificando un referendum (molto) distorto sugli ultimi quarantacinque anni della politica e della società americana, e coloro che hanno la percezione di essere arrivati all’imminente fine del «libero commercio» e della «globalizzazione» pensano di aver trovato finalmente una voce, mentre sulla base del programma economico di Trump, così com’è, resta una chimera. Proprio come in Francia o in Gran Bretagna, il nuovo populismo di destra non fa le sue incursioni via web nei centri yuppie metropolitani di Parigi o Londra, ma piuttosto batte medie e piccole cittadine, compresi centri periferici dove la gentrificazione ha costretto l’ex classe operaia urbana a trasferirsi. Altrettanto avviene negli Stati Uniti, dove Trump non gioca le sue carte nell’Area della Baia di San Francisco o a New York City, ma le gioca nelle medie-piccole cittadine, e nei ghetti dell’unnecessariat(destinati agli esclusi) [1].
Potremmo anche considerare l’ascesa del populismo autoritario in stile Trump in un inquietante contesto globale, che comprende gli attuali successi dell’estrema destra in Europa occidentale (Francia, Scandinavia, Austria e ora in Germania), in Europa orientale, con in testa Ungheria e Polonia, insieme alla Russia di Putin, la Turchia di Erdogan e, più recentemente, Duterte nelle Filippine. Un’ondata di destra ha anche spazzato via o ha indebolito la maggior parte dei governi «progressisti», con in testa Argentina e Brasile, che ha dominato l’America Latina negli ultimi decenni.
Forse si noterà che negli strati sociali della cosiddetta «classe media» degli Stati Uniti, la classe operaia bianca viene trattata e coccolata come l’arbitro finale di questa elezione. La politica del 2016 è talmente senza precedenti che l’ideologia mainstream sente improvvisamente il bisogno di parlare apertamente a quella classe operaia che, in precedenza, aveva ignorato o considerato una base garantita. I burocrati sindacali della Uaw (United Automobile Workers) e della Afl-Cio puntano decisamente su Richard Trumka presidente, dandosi da fare come matti per convincere la base sindacale a non votare Trump.
Trump, da parte sua, quando è stato in grado di affrontare l’«argomento», ha fatto discorsi di una lucidità disarmante[2] su quello che è successo ai lavoratori nello zoccolo duro della grande industria, il voto di questi lavoratori è decisivo nei cosiddetti swing states (stati in bilico, quelli in cui nessun candidato o partito ha un sostegno predominante) del Midwest. La classe operaia bianca scarsamente concorrenziale di quella che era l’industria manifatturiera in Virginia e Nord Carolina è anch’essa una facile preda per Trump[3], per non parlare dei minatori o meglio ex-minatori del West Virginia, restati senza lavoro a causa dell’agenda «verde» di Clinton (ovvero l’eliminazione dei combustibili fossili, ndr).
E perché dovremmo essere sorpresi, quando il fatto più sorprendente è che per la prima volta un candidato di un partito importante si è preoccupato di parlare direttamente con quei lavoratori su ciò che è successo a loro negli ultimi decenni, in contrasto con la retorica del benessere di Walter Mondale e Bill Clinton e ora di Hillary Clinton? Dire che «l’America non ha smesso mai di essere grande», come fanno Hillary Clinton e i democratici, questa è proprio una ideology run amok (ideologia omicida), ed è anche una ben magra consolazione per i lavoratori dell’ex roccaforte industriale, per un largo strato della popolazione nera del Nord e del Sud, o per i bianchi poveri della regione degli Appalachi e di altre zone, attualmente soggetti ai più alti tassi di mortalità del Paese, a causa di suicidi, droga e alcol.
Quando si considerano le divisioni in seno alla classe lavoratrice, non dovremmo trascurare il ruolo che svolge la identity politics (identitarismo/corporativismo sociale, ndr) – molto diffusa nei centri metropolitani – nell’alimentare l’ascesa di Trump. La identity politics ha sempre suscitato è suscita, esplicitamente o implicitamente, la «diffidenza» dai lavoratori in quanto tali, proprio perché quel ceto politico è stato estremamente indifferente allo smantellamento delle vecchie roccaforti industriali, che devastò le comunità di lavoratori bianchi, neri e colorati. L’ascesa di Trump è in parte una vendetta dopo decenni di condiscendenza e mal celato disprezzo, o nel migliore dei casi indifferenza per il destino del lavoratore comune, sentimento assai diffuso nelle élite del mondo accademico, nei media e nel mondo della grande editoria del «New York Times» e delle raffinate riviste delle classi chiacchierone.
Trump è un razzista, tu dici? Un misogino? Un detrattore violento della Cina e degli immigrati? Sì, egli è tutte queste cose, ma queste accuse provenienti dai luoghi comuni della sinistra e dei liberals non scalfiscono la sua attrattiva in quanto figura «anti-establishment». La sua base sociale reale ha anche il più alto reddito pro capite dei candidati ed ex-candidati presidenziali (Clinton e Sanders), e ciò indica che egli ha forgiato una coalizione sociale che si sente minacciata, composta da bianchi della classe media e superiore, con alcuni operai bianchi e bianchi poveri, un fatto che è di per sé senza precedenti. Tutti questi gruppi hanno in comune la sensazione che la vecchia America che essi avevano conosciuto sta per essere sostituita da un’America con una classe operaia più nera e colorata, e da molteplici gruppi di immigrati dall’Oriente, dall’Asia del Sud e dall’America Latina.
Last but not least, Trump ha portato allo scoperto molte forze dell’estrema destra, da David Dukes alla folla che ostenta le armi, in pieno giorno, autorizzandole a uscire dagli angoli oscuri in cui erano relegatedall’alt alla destra, e ha «liberato le loro lingue» (come qualcuno di loro ha detto) dalla dominante atmosfera «politicamente corretta». Se Trump vince o perde, tali forze non ritorneranno tranquillamente nella loro precedente relativa oscurità.
Per concludere, questi progressi dell’estrema destra e del populismo autoritario che proliferano a livello mondiale sono lo specchio del fallimento della «sinistra» moderata, collassata nel consenso dellahappy family di centro-destra centro-sinistra degli ultimi 45 anni, sceneggiata dai Tony Blair, François Mitterrand e Gerhard Schröder in Europa e dai Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama negli Stati Uniti, ora raggiunti da Hillary Clinton. Tali forze non frenano la destra in ascesa, come molti teorici del «male minore» vorrebbero farci credere, anzi, facendo ciò la alimentano; non rappresentano una sinistra seria, tipo quella che Insurgent Notes vuole contribuire a creare, come chiara alternativa «anti-establishment» allo status quo.
Loren Goldner, Insurgent Notes, ottobre 2016.
[1] I ghetti destinati alla popolazione «senza speranze», uno strato sociale che presenta affinità con i Neet: Not (engaged) in Education, Employment or Training, ovvero coloro che non studiano e non lavorano (ndr).
Vedi: https://morecrows.wordpress.com/2016/05/10/unnecessariat/).
[3] http://insurgentnotes.com/…/review-beth-macy-factory-man-ho…
Leggi anche: