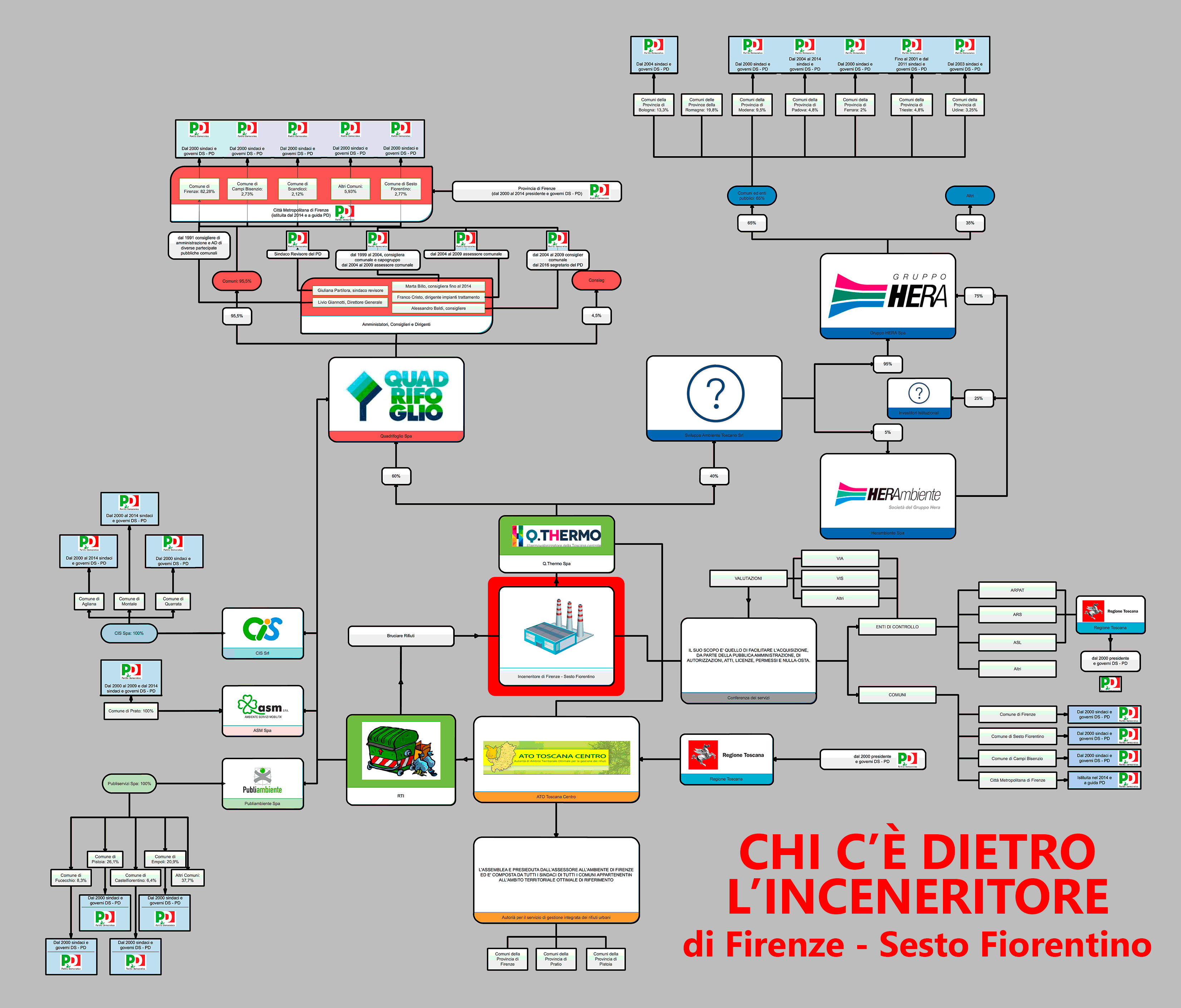I Cie stanno crollando uno dopo l’altro

Ponte Galeria, 2009. Foto via Flickr.
È il 26 gennaio 2014 quando 13 migranti, tutti di origine marocchina e reclusi al Centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Ponte Galeria a Roma, decidono di cucirsi la bocca. Lo stesso era avvenuto il 21 dicembre 2013, giorno in cui il ministro dell’Interno Angelino Alfano rispondeva in aula sul caso del Centro di primo soccorso e accoglienza (Cpsa) di Lampedusa, finito su tutti i media per il video della disinfestazione anti-scabbia girato da un giovane migrante siriano.
Nei giorni successivi la protesta all’interno del Cie di Roma—che ospita 100 persone, di cui 71 uomini e 29 donne—si allarga: altri 26 immigrati iniziano uno sciopero della fame. Matteo Salvini, il nuovo segretario della Lega Nord, dimostra la solita, squisita sensibilità:
Eppure, stando alle parole di Enrico Letta pronunciate durante la conferenza stampa di fine anno, qualcosa doveva cambiare. Il premier aveva assicurato che la “discussione su alcuni aspetti della Bossi-Fini sarà uno dei temi di gennaio,” così come “la revisione degli standard dei Cie e del sistema dell’accoglienza in genere.” Peccato che gennaio sia passato e, chi l’avrebbe mai detto?, la politica è rimasta impantanata nei soliti dibattiti lontani anni luce dalle realtà.
I Cie (che prima si chiamavano Cpt, Centri di permanenza temporanea) sono stati istituiti nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano, successivamente modificata dalla Bossi-Fini e da altre norme approvate dai governi di centrodestra. La funzione delle strutture, create per cercare di regolare il flusso migratorio, è quella “accogliere” gli stranieri immigrati senza titolo di soggiorno e in attesa di espulsione, nei casi in cui non sia possibile l’esecuzione immediata della misura.
Questa privazione della libertà personale per soggetti che non hanno commesso reati ha sempre fatto sollevare molti dubbi sulla compatibilità dei Cie e delle altre strutture di accoglienza con la Costituzione. Secondo il professore Luca Masera, la legislazione sull’immigrazione è sempre stata improntata a “finalità demagogiche”, ossia quella di “trasmettere l’immagine di uno Stato severo nei confronti dei clandestini.” Il problema è che questa “ispirazione repressiva” non solo si è “dimostrata irrazionale rispetto agli obiettivi di contenimento,” ma si è anche rivelata un fallimento a tutto tondo.
Solo negli ultimi mesi, infatti, una lunga serie di proteste, rivolte, evasioni e inefficienze si è abbattuta sull’intero sistema di accoglienza e reclusione amministrativa. Per rendersene conto basta un semplice dato: ora come ora sono operativi solo cinque Cie (Torino, Roma, Caltanissetta, Trapani, Bari) sui 13 originariamente previsti. Le altre strutture o sono chiuse per “ristrutturazione”, oppure sono state fatte a pezzi dai migranti.

Mappa aggiornata al settembre 2013. Ora sono chiusi anche il Cie di Gradisca d’Isonzo, quello di via Corelli a Milano e quello di Trapani Milo.
La scorsa estate le proteste hanno colpito ininterrottamente i vari centri della penisola. Il 14 giugno la sommossa arriva al Cara di Mineo (Sicilia), una gigantesca struttura inizialmente concepita come residence per i militari di Sigonella e riconvertita nel marzo 2011 a centro per richiedenti asilo—attualmente il più grande d’Europa. Il Cara era già noto per i tentati suicidi dei rifugiati, il sovraffollamento cronico che affligge la struttura e le questioni burocratiche che allungano il “soggiorno” degli “ospiti” in maniera quasi indefinita, trasformandolo di fatto in un centro di reclusione.
L’alterco tra un uomo del Mali e uno dei dipendenti del Cara e il conseguente trasporto in caserma del primo scatenano l’ira di un centinaio di rifugiati, che “con bastoni e pietre” si scontrano con la polizia in assetto antisommossa. Vengono lanciati lacrimogeni, e una parte dell’area verde del Cara è data alle fiamme.
Nella rivolta successiva, la nona in appena due anni, circa mille richiedenti asilo si riversano in strada, bloccano per ore la statale Catania-Gela, assediano una stazione di servizio e si scontrano ripetutamente con la polizia.
Gli scontri del 22 ottobre 2013 sulla statale 147.
Poi il 14 dicembre l’eritreo di 21 anni Mulue Ghirmay si impicca nel Cara. Il ragazzo era sbarcato in Sicilia il 5 maggio, e da sette mesi aspettava di vedersi riconosciuto lo stato di rifugiato politico. La protesta riesplode qualche giorno dopo, quando una settantina di richiedenti interrompono le attività del consorzio Sisifo (che si occupa della gestione) e manifestano nuovamente sulle statali. La situazione al Cara di Mineo è talmente esasperante che lo scorso luglio persino il sindacato di polizia Siulp aveva parlato di un centro “sovraffollato, pericoloso ed utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato creato.”
Al Cie di Modena, attivo dal 2002, le proteste iniziano il 18 luglio. Pochi giorni prima la Guardia di Finanza aveva perquisito gli uffici del consorzio l’Oasi di Siracusa (che gestiva il Cie), sequestrando documenti e registri. Già nel 2012 il procuratore capo Zincani aveva parlato di “indagini in corso per verificare la regolarità della gara d’appalto” per l’assegnazione della gestione con un ribasso spaventoso di 28,5 euro a migrante contro i 74,5 del precedente appalto. Da mesi, inoltre, i lavoratori del Cie di Modena indicevano scioperi per il mancato pagamento degli stipendi, e le condizioni di vita all’interno di un Centro sempre più fatiscente erano a dir poco disastrose.
Non sorprende, dunque, che il primo cenno di rivolta sia proprio contro la “scarsità d’igiene”. Nel pomeriggio del 18 una parte dei migranti brucia diversi materassi e danneggia due blocchi del Cie, e in serata alcuni salgono sui tetti e lanciano tegole contro polizia ed esercito. All’inizio di agosto il centro viene chiuso temporaneamente per “lavori di ristrutturazione”; a dicembre, la prefettura di Modena annuncia che il Ministero dell’Interno ha definitivamente soppresso il Centro.
Ad agosto le rivolte esplodono al Cie di Gradisca d’Isonzo (Trieste), aperto nel 2006 e considerato uno dei peggiori centri d’Italia. Nel settembre del 2009, stando al racconto di un immigrato, un tentativo di fuga di alcuni reclusi era degenerato in cariche e pestaggi da parte della polizia.
Il video del 2009 girato all’interno del Cie di Gradisca d’Isonzo.
Nel febbraio del 2011 due giorni consecutivi di rivolta avevano letteralmente fatto a pezzi il Cie. La reazione delle autorità e dei gestori era stata quella di introdurre una sfilza di divieti per evitare il rischio di sommosse. Il clima di fortissima tensione all’interno del centro era stato registrato anche nel resoconto Arcipelago CIE dell’associazione Medici per i diritti umani (MEDU), che aveva parlato di un rapporto tra reclusi e operatori “dominato da un costante e quasi ossessivo clima di sospetto” e di norme di sicurezza che “appaiono particolarmente restrittive e trovano riscontro nel profondo malessere dei detenuti.”
È in questo contesto, dunque, che matura l’ondata di rivolte a Gradisca. L’8 agosto 2013 alcuni reclusi si rifiutano di tornare nelle proprie stanze, volendo “festeggiare la fine del Ramadan e godere della frescura notturna.” Gli agenti in assetto antisommossa sparano lacrimogeni e usano i manganelli per far rientrare i migranti.
La scena si ripete l’11 agosto, quando la polizia reprime l’agitazione dopo che una trentina circa di persone (su 67 reclusi) si era unita alla protesta iniziata la mattina da quattro migranti saliti sul tetto.
I disordini continuano fino alla fine di ottobre. Nella notte tra il 30 e il 31 tre ragazzi provano a evadere ma vengono bloccati dalle forze dell’ordine. Appena gli altri reclusi si accorgono di quello che sta succedendo scatta l’ennesima rivolta: nel giro di due giorni gli immigrati divelgono le reti, rompono le vetrate, bruciano materassi e lenzuola e danno alle fiamme le stanze. Il 6 novembre arriva l’annuncio del trasferimento dei reclusi e della chiusura provvisoria del Cie per “lavori di ristrutturazione e ripristino della sicurezza.”
Un altro centro chiuso dalle rivolte di questa estate è quello di Isola Capo Rizzuto. Il Cie in provincia di Crotone aveva fatto parlare di sé all’inizio del 2013, quando il Tribunale locale aveva assolto tre cittadini stranieri accusati di aver capeggiato la rivolta dell’ottobre 2012. Nelle motivazioni il giudice aveva annotato che la rivolta era una “difesa proporzionata all’offesa,” e aveva descritto con parole durissime le pietose condizioni di vita del centro, definendolo non adatto “ad accogliere esseri umani.”
Nonostante la sentenza, nel centro le cose erano continuate a peggiorare – anche perché il Cie era gestito con soli 21,4 euro a persona, il budget più basso d’Italia. Stavolta a far partire la rivolta è la morte di un marocchino di 31 anni, Moustapha Anaki, avvenuta il 10 agosto all’interno del Cie in circostanze poco chiare (“per un malore” è la spiegazione ufficiale). Per due giorni i migranti devastano e incendiano il centro, tanto da costringere le autorità a chiuderlo.

Milano, aprile 2012: manifestazione per richiedere accesso al Cie di via Corelli. Via Flickr.
Lo stesso è accaduto nel Cie di via Corelli a Milano, aperto nel 1999 e gestito dalla Croce Rossa italiana. Il 7 e l’8 settembre 2013 alcuni immigrati bruciano materassi e mobili danneggiando diversi settori. Alla fine del mese, dopo che i lavori di ristrutturazione avevano rimesso a posto i settori già bruciati, i reclusi tornano a incendiare il centro.
Il 10 novembre scoppia un’altra rivolta che danneggia tre settori su quattro, rendendo la struttura completamente inagibile. Sessanta reclusi vengono trasferiti in altri Cie, mentre dieci sono arrestati. Subito dopo gli incendi, la Croce Rossa manifestata la volontà di abbandonare la gestione del centro: “Evidentemente ci sono delle dinamiche che non riusciamo a controllare,” dichiara il presidente provinciale Antonio Arosio. “Sicuramente, quando c’è una rivolta, il malessere ne è alla base.”
I pochi Cie che rimangono (più o meno) aperti non se la passano troppo bene.
Nel Cie di Bari-Palese, ad esempio, la scorsa notte di Natale una trentina di migranti assalta un reparto. La rivolta, che lascia dieci persone contuse, è sedata dalle forze dell’ordine. Nel 2012 la procura di Bari aveva avviato un’inchiesta sulla struttura poco dopo la pubblicazione della perizia eseguita dal Comune. Nel documento il Cie veniva definito come una “struttura fatiscente”, che versava in condizioni igieniche “raccapriccianti” e non assicurava “agli immigrati una necessaria assistenza e il pieno rispetto della loro dignità.”
Nel Cie di Trapani-Milo, soprannominato il “Cie delle fughe”, la situazione, come afferma un’equipe di medici di MEDU, è “al limite del collasso.” L’ente che gestisce il Centro, il Consorzio Oasi, “non è più in grado di garantire gli stipendi dei dipendenti […] né servizi e beni di prima necessità.” Mancano “detersivi, penne e carte per gli operatori,” c’è “una grave carenza di farmaci e strumentazione sanitaria” e i kit contenenti biancheria e beni di prima necessità “sono assenti o drasticamente ridotti.”
Un dipendente del Centro ammette che l’unica “attività ricreativa” per i migranti “è pensare a come fuggire”: dall’inizio del 2013 “sono state trattenute nel Centro 1358 persone e si sono verificate ben 800 fughe (quasi il 60 percento), a fronte di 162 migranti rimpatriati (il 12 percento), di cui 25 cittadini comunitari.” Ad ogni modo, il 20 gennaio 2014 il prefetto Leopoldo Falco annuncia che a fine febbraio il Cie sarà chiuso per otto mesi per i soliti “lavori di messa in sicurezza della struttura.”
Il Cie di Torino, aperto nel 1999 e gestito dalla Croce Rossa, è (per usare un eufemismo) in grandissimo affanno. Nel rapporto Arcipelago CIE, il MEDU descrive uno scenario in cui i migranti fanno regolare uso di farmaci e ricorrono spesso agli atti di autolesionismo (ben 156 nel solo 2011).
Il 23 dicembre 2013 la sezione femminile della struttura entra in subbuglio. Le donne, “esasperate dall’idea di passare il Natale recluse nella struttura,” protestano dando fuoco a una coperta e rompendo un televisore. La polizia reagisce duramente.
A gennaio l’area maschile viene distrutta per tre quarti, e nel Centro rimangono solo una sessantina di reclusi, meno di un terzo di quelli che potrebbe ospitare a pieno regime (210 persone). Pare che i locali devastati non saranno riparati per due motivi: il primo è che i soldi sono finiti; il secondo, che gestori e polizia non sono più in grado di mantenere l’ordine.
Un video girato da un recluso mostra le condizioni del Cie di Torino dopo le rivolte del 16 e 19 gennaio.
Insomma, mai come ora—mentre il rapporto Caritas-Migrantes uscito il 20 gennaio fa notare come l’unica utilità dei Cie sia quella di fare da “sedativo delle ansie di chi percepisce la presenza dello straniero [...] come un pericolo per la sicurezza”—appare evidente la completa inadeguatezza della “struttura di accoglienza” italiana. E dire che già nel 2007 la Commissione De Mistura, voluta dall’allora Ministro dell’Interno Amato per le “verifiche e strategie dei Centri,” aveva caldeggiato il superamento del sistema della detenzione amministrativa, poiché “non risponde alle complesse problematiche del fenomeno migratorio” e comporta disagi e costi elevatissimi.
Il governo Berlusconi ha scelto di andare nella direzione opposta a quella indicata dalla Commissione. Nell’agosto del 2008 il centrodestra proroga il termine massimo di permanenza nei Cie da 60 a 180 giorni, e nel 2011 la durata massima del trattenimento arriva fino agli attuali 18 mesi. Secondo il professore Fulvio Vassallo Paleologo, è proprio questo prolungamento ad aver “fatto esplodere i Cie” e “ridotto la ‘capacità espulsiva’ dei centri,” che dal 1998 al 2012 è al di sotto del 50 percento.
Per capire l’effetto del prolungamento sulla psiche e le prospettive di chi vive nei Cie, è utile riportare la testimonianza di un migrante tunisino. Il ragazzo, rinchiuso a Gradisca d’Isonzo da mesi, aveva cominciato a tagliarsi le braccia: “Sto andando fuori di testa, non mi sono mai tagliato così e me ne vergogno. Voglio solo andarmene da qui, ho chiesto di essere rimpatriato, ho consegnato tutte le carte, ma il passaporto non ce l’ho e il consolato tunisino non mi riconosce come cittadino. Io 18 mesi qui non me li faccio, piuttosto mi ammazzo.”
Lo scorso novembre il segretario del sindacato di Polizia Sap aveva dichiarato: “La mancata chiarezza sulle regole di ingaggio e i tagli alle risorse sono alla base del fallimento delle attuali politiche migratorie in Italia e della chiusura dei Cie, senza contare che fu un errore cinque anni fa introdurre il reato di clandestinità e aumentare i tempi di permanenza in queste strutture.” Il 25 gennaio Pierfrancesco Majorino (assessore al Welfare di Milano) è arrivato a chiedere al Governo di “non provvedere mai più alla riapertura del Cie di via Corelli,” poiché “non si possono piangere i morti di Lampedusa e ignorare la necessità di rivoluzionare il sistema di accoglienza dei vivi.”
Nell’aprile del 2013 il Ministero dell’Interno aveva presentato un “Documento programmatico sui Cie”, scritto dalla task force guidata dal sottosegretario Saverio Ruperto. Il piano da un lato prevede la riduzione del periodo di trattenimento (da 18 mesi a un anno, comunque tantissimo) e una maggiore assistenza sanitaria; dall’altro contempla parecchie misure repressive.
Nel punto dedicato alla “tutela della pacifica convivenza all’interno dei Centri”, ad esempio, si dice che i gruppi di “ospiti” che manifestano “condotte violente e antisociali” andrebbero divisi tra loro attraverso “trasferimenti in altre strutture” e la creazione di celle d’isolamento (definite “moduli idonei ad ospitare persone dall’indole non pacifica”). Si propongono inoltre: l’introduzione di “un’aggravante per i reati commessi all’interno dei Cie, caratterizzati da condotta violenta”; il divieto di usare i cellulari con fotocamera; il rafforzamento della presenza delle forze di polizia all’interno dei Centri; e infine la formazione di un “un corpo di operatori professionali, cui affidare la gestione delle attività che prevedono un contatto diretto con gli ospiti dei Centri” (qualcuno ha definito questo “corpo di operatori” come “squadre di para-secondini privati”).

Uno stencil su un muro a Torino. Foto via Flickr.