Estetica dispotica o l’insostenibile leggerezza dell’apparire
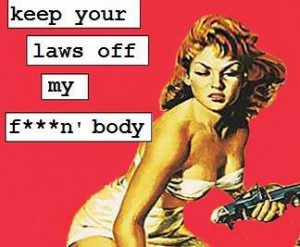 Pubblichiamo questo documento redatto dalle compagne del Collettivo Degenerate
Pubblichiamo questo documento redatto dalle compagne del Collettivo Degenerate
“Istruite fin dall’infanzia che la bellezza è lo scettro della donna, il loro spirito prende la forma del loro corpo e viene chiuso in questo scrigno dorato, ed essa non fa che decorare la sua prigione”
(Mary Wollstonecraft, Rivendicazione dei diritti della donna)
Nel corso della storia le donne hanno sempre dovuto adeguarsi a modelli estetici di riferimento che non corrispondevano affatto alla realtà dei loro corpi. Questi canoni, pur variando nel tempo, sono sempre stati accettati come oggettivi; in realtà il concetto di bellezza è stabilito a priori dalla società e acquisito dalla mente degli individui che lo fanno proprio durante la crescita. Al momento di riconoscere la bellezza si crede quindi di agire con gusto personale e soggettivo ma inevitabilmente stiamo aderendo a schemi prestabiliti che difficilmente riusciamo a decostruire. È quindi ancora più grave che l’estetica occupi un ruolo di primo piano nella nostra scala dei valori e influenzi così profondamente il nostro modo di essere e di percepire noi stessi e gli altri. Una qualità che non ha una reale utilità o funzione sociale diviene così un valore determinante; tutta l’importanza data all’apparenza estetica arriva al punto di influenzare fortemente il percorso di vita di una persona, discriminando chi non rispecchia i canoni prestabiliti; persino chi corrisponde a questo modello estetico non è libero dalla pressione continua di aderire al bello irraggiungibile. La bellezza assume quindi il valore di “merito” e innesca un meccanismo perverso di autogratificazione di se stessi attraverso il riconoscimento altrui. L’estetica è ormai un valore assoluto a cui dobbiamo adeguarci, continuamente riproposto dalla società, che ci impone di sfruttare il nostro corpo per valorizzarlo. Tutto questo, più o meno inconsciamente, assume una connotazione prioritaria nel nostro modo di essere e ci condiziona fortemente. Il problema nasce proprio dal peso che diamo ad un certo modello a prescindere da quale esso sia, e dall’incapacità di mettere realmente in discussione il bisogno di aderivi. La nostra epoca è forse quella in cui questo desiderio raggiunge il suo apice, grazie anche alla capillarità con cui i media invadono e orientano l’immaginario collettivo. La questione dell’apparenza e del suo valore, seppur a prima vista un problema superficiale, tocca in realtà moltissimi nodi e influenza la formazione degli individui e il loro esistere in società. Proprio su questo abbiamo incentrato il nostro percorso, osservando l’estetica come un dispositivo di controllo, e studiando come questo si sia radicato e come sia andato via via diffondendosi.
L’estetica come dispositivo sociale
“Generalizzando ulteriormente la già amplissima classe dei dispositivi foucaultiani, chiamerò dispositivo letteralmente qualunque cosa abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi. Non soltanto, quindi, le prigioni, i manicomi, il Panapticon, le scuole, le confessioni, le fabbriche, le discipline, le misure giuridiche ecc., la cui connessione col potere è diventata in un certo senso evidente, ma anche […] l’autostrada, la metropolitana, l’ufficio, la sigaretta, la televisione, i telefoni cellulari, i computers, la navigazione in internet” (Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo)
Il termine dispositivo designa, dunque, una tecnologia di governo e potere il cui scopo è di gestire, controllare e orientare, in un senso che si pretende utile, i comportamenti, i pensieri e i desideri degli uomini. Si direbbe che oggi la nostra vita sia presieduta sin nei minimi dettagli da un qualche dispositivo. Tuttavia, ciò che non deve assolutamente passare inosservato è che le nuove classi di dispositivi non vengono imposti agli individui attraverso una costrizione da parte di un potere esterno, ma vengono, per così dire, assunti e interiorizzati liberamente. In fondo, non sarebbe probabilmente errato affermare che “«i dispositivi mirano attraverso una serie di pratiche e di discorsi, di saperi e di esercizi alla creazione di corpi [e anime] docili, ma libere, che assumono la loro identità e la loro libertà di soggetti nel processo stesso del loro assoggettamento». Insomma, se il dispositivo non implicasse un processo di soggettivazione non potrebbe funzionare come dispositivo di governo, ma si ridurrebbe a un mero esercizio di violenza. «Il dispositivo è innanzitutto una macchina che produce soggettivazioni, e solo in quanto tale è anche una macchina di governo»” (La metropoli come dispositivo, autoproduzione di Roma Disambientata, marzo 2012). I modelli estetici e il desiderio di adeguarvisi sono anch’essi dispositivi di controllo sociale: una società schiava di questo bisogno indotto risulta infatti più facilemente gestibile (e controllabile). Il “dispositivo estetica” serve principalmente due scopi: continuare a far considerare estetica e bellezza dei valori e delle qualità imprescindibili, che occupano perciò la mente ed il tempo degli uomini e (soprattutto) delle donne, e creare un’industria e una vasta gamma di prodotti e servizi di cui si pensa non poter assolutamente fare a meno. Il controllo ed il guadagno sono, se ci pensate un momento, enormi. Vanno dai semplici trucchi ai vestiti, dai prodotti per capelli agli estetisti, dalle diete piene di prodotti chimici alla chirurgia plastica. Anche per l’estetica vale poi il processo di soggettivazione. Non vengono quindi dettate delle regole o degli obblighi con violenza: si creano piuttosto dei modelli da seguire che piano piano, a forza di immagini e di messaggi ripetutamente trasmessi, vengono interiorizzati dal soggetto e riprodotti. I principali strumenti di questo dispositivo sono dunque l’educazione e i media.
Strumenti e diffusione del dispositivo.
L’educazione
Nella nostra società le vite di bambine e bambini prendono due strade diverse fin dal momento della nascita, con la fatidica affermazione “è una femmina/un maschio!” e il conseguente fiocco, rigorosamente rosa o azzurro. Da questo momento, per le une e per gli altri si proporranno abiti diversi, atteggiamenti diversi, intrattenimenti diversi, insomma due percorsi educativi non interscambiabili con lo scopo di formare donne e uomini considerati equilibrati. Per le une e per gli altri sono previsti sistemi di valori e di attitudini differenti, che variano da cultura a cultura, attraverso il tempo e lo spazio. Questi sistemi costituiscono quello che chiamiamo genere, o gender: l’insieme di aspettative, simboli, qualità che ogni società prevede compongano l’identità femminile e quella maschile. Fin dai primi anni di età ci guardiamo intorno per osservare cosa fanno i nostri simili, come si esprimono, e una volta che ci riconosciamo in un determinato gruppo tendiamo il più possibile ad aderire a quello che immaginiamo essere il comportamento adatto. Col passare degli anni impariamo e assimiliamo i costumi del sesso a cui sentiamo di appartenere, tanto che letteralmente li incorporiamo, li mettiamo in pratica sul nostro corpo. Marcel Mauss, sociologo e antropologo francese, parla in questo caso di “tecniche del corpo”1, ovvero tutti i modi in cui ci serviamo del nostro corpo, in maniera inconsapevole, secondo quanto appreso dalla società. Un esempio efficace per spiegare questo concetto è pensare alla guida dell’auto: dopo un periodo di apprendimento in cui dobbiamo fare estrema attenzione ad ogni gesto che compiamo, e pensarci prima di compierlo, le stesse azioni diventano spontanee, automatiche: questo accade perché abbiamo ormai incorporato la tecnica di guida. In modo analogo osserviamo nei nostri simili queste azioni ripetute e tramandate e piano piano, sempre con minore consapevolezza da parte nostra, esse entrano a far parte anche dei nostri movimenti. Lo stesso succede, tra le altre cose, per la postura: una bambina, crescendo, riceverà continue indicazioni, verbali e non, su quale sia il modo di stare seduta e di camminare che si pensa più adatto a lei in quanto donna. È necessario sedere composte, con le gambe incrociate, la schiena eretta… Le prime volte abbiamo bisogno di concentrarci, di porre attenzione su quello che stiamo facendo, ma col tempo il nostro corpo impara i giusti movimenti e li esegue da sé. Accade lo stesso anche per quanto riguarda i bambini, ma in maniera diversa: a un bambino eccessivamente composto o che tiene le gambe incrociate si dirà che è una femminuccia, che è gay, che il suo modo di sedersi o di camminare mina la sua virilità. In sostanza, possiamo dire che il sistema di genere, ovvero quanto una società pensa sia adatto a maschi o femmine, plasma il nostro corpo e il nostro modo di muoverlo, di viverlo. In quanto donne siamo continuamente stimolate ad occuparci e preoccuparci del nostro aspetto: fin da piccole abbiamo imparato che “se bella vuoi apparire, un poco devi soffrire” e che “non esistono donne brutte, ma solo donne pigre”. Alle bambine viene insegnato che la bellezza è un valore e che fa parte della loro natura l’essere vezzose e vanitose. Molte donne pensano che sia più divertente avere una figlia, perché questo permette di sbizzarrirsi con fiocchetti, fiorellini e cuoricini, vestitini di ogni tipo, mollette, cappellini. Le bambine vengono viste come bambole da travestire, più che come esseri umani con dei desideri e delle esigenze personali. Il pensiero va ai concorsi di bellezza per bambine, ancora poco diffusi in Italia ma molto in voga negli Stati Uniti, dove le piccole vengono truccate, abbronzate, abbigliate in maniera grottesca, privandole della libertà di essere se stesse e di dedicarsi ad attività più congeniali alla loro età. Questa ossessione per l’aspetto fisico e per l’abbigliamento condiziona le bambine anche nei loro comportamenti ludici, impedisce loro di sentirsi completamente libere; e come potrebbero, visto che devono stare attente a non sporcarsi, a non scomporsi, a non spettinarsi? Una ricerca svolta negli Stati Uniti ha dimostrato come, nelle fasce orarie televisive dedicate al pubblico infantile, la metà delle pubblicità di giocattoli per bambine faceva riferimento alla bellezza, mentre nessuna parlava di aspetto fisico maschile2. Molte delle pubblicità per le bambine, infatti, anche in Italia, promuovono prodotti cosmetici per l’infanzia, contribuendo così all’adultizzazione precoce delle più piccole e ad instillare in loro la necessità di impegnarsi per il loro aspetto fisico fin dai primi anni di vita. Come se questo non bastasse, la Federazione italiana medici pediatri denuncia un aumento del 16,7% delle dermatiti da contatto o allergiche tra le bambine tra gli otto e i dodici anni, causato proprio dall’utilizzo del trucco3. Non si può dimostrare che le caratteristiche biologiche della donna la portino a curare in maniera maniacale il proprio aspetto fisico; sono invece evidenti gli stimoli della società, fin dalla prima infanzia, in questo senso. Le pressioni a conformarsi a un determinato ideale sono forti sia nei confronti delle bambine che dei bambini. I condizionamenti a cui siamo sottoposti nei primi anni di vita influiscono fortemente sulla nostra personalità e sulle nostre aspirazioni e interessi da adulti. Se continuiamo a crescere bambine e bambini rigidamente ingabbiati negli stereotipi del sistema di genere seguiteremo a seminare frustrazione e scontentezza e a limitare le reali inclinazioni dei più piccoli, impedendo loro di svilupparsi autonomamente secondo i loro desideri.
I media
 Insieme all’educazione ha un ruolo fondamentale, se non primario, nella formazione dei canoni estetici e dei modelli da seguire, tutto il mondo dei media, a cui si sono poi aggiunti negli ultimi anni anche i vari social network che hanno contribuito alla creazione di un mondo fatto di immagini, più improntato all’apparire che all’essere. I corpi (femminili) mostrati in televisione sono straordinariamente simili l’uno all’altro, giovani e snelli. “Si mostrano corpi che, paradossalmente, vengono rappresentati come strumenti di potere, grazie alla loro proprietà seduttiva, ma, contemporaneamente, sono oggetti di uno sguardo maschile interiorizzato” (S. Leonelli – G. Selmi, Genere, corpi e televisione, 2013). C’è una totale assenza di una rappresentazione plurale del femminile, e tale carenza si ripercuote poi nella difficoltà di andare ad esplorare modelli più articolati nella vita delle donne reali. Questo tipo di analisi peraltro risulta più difficile oggi rispetto ad un tempo. Negli anni ‘50 per esempio era più facile rendersi conto di questo fenomeno, dal momento in cui i modelli maschili e femminili erano meno complessi ed ancor più stereotipati (la donna per esempio era vista solo come madre e moglie). Adesso invece abbiamo repertori più complessi, e, così come nella vita reale, i media convincono lo spettatore di aver ormai raggiunto la libertà di scegliere chi e come essere, proponendogli immagini meno tradizionali. Mentre dunque sono diventate più complesse alcune rappresentazioni sociali di genere, la rappresentazione del corpo femminile si è invece fatta sempre più normativa: la tv è produttrice di corpi perfetti, ideali e dunque irreali ma che assumono statuto di realtà nel processo di interiorizzazione delle spettatrici. Questo è un passaggio fondamentale che ha reso, come vedremo, talent show e reality show tra i programmi più visti dalle ragazze. Il riproporre continuamente determinate immagini e stereotipi bombardando letteralmente la mente degli ascoltatori porta ad un’omologazione dei desideri collettivi e alla costruzione di un ideale di bellezza. I media dunque non forniscono solo modelli (di bellezza e di genere) che piacciono al pubblico, ma formano il gusto stesso degli spettatori. Riprendendo un’indagine (tratta da Genere, corpi e televisione di S. Leonelli e G. Selmi) fatta a ragazzi e ragazze del liceo (tramite questionario e lavori in gruppo) che ci aiuterà in questa analisi tramite diversi dati, si può notare infatti come alcune risposte “standard” ed alcuni stereotipi o omologazioni di sogni e desideri siano più presenti nei soggetti che passano più tempo dinanzi al televisore e che sono più esposti ad alcuni generi di programmi. La maggior parte delle ragazze guarda principalmente serie televisive e reality show, a differenza dei coetanei maschi che privilegiano cartoni animati e sport.
Insieme all’educazione ha un ruolo fondamentale, se non primario, nella formazione dei canoni estetici e dei modelli da seguire, tutto il mondo dei media, a cui si sono poi aggiunti negli ultimi anni anche i vari social network che hanno contribuito alla creazione di un mondo fatto di immagini, più improntato all’apparire che all’essere. I corpi (femminili) mostrati in televisione sono straordinariamente simili l’uno all’altro, giovani e snelli. “Si mostrano corpi che, paradossalmente, vengono rappresentati come strumenti di potere, grazie alla loro proprietà seduttiva, ma, contemporaneamente, sono oggetti di uno sguardo maschile interiorizzato” (S. Leonelli – G. Selmi, Genere, corpi e televisione, 2013). C’è una totale assenza di una rappresentazione plurale del femminile, e tale carenza si ripercuote poi nella difficoltà di andare ad esplorare modelli più articolati nella vita delle donne reali. Questo tipo di analisi peraltro risulta più difficile oggi rispetto ad un tempo. Negli anni ‘50 per esempio era più facile rendersi conto di questo fenomeno, dal momento in cui i modelli maschili e femminili erano meno complessi ed ancor più stereotipati (la donna per esempio era vista solo come madre e moglie). Adesso invece abbiamo repertori più complessi, e, così come nella vita reale, i media convincono lo spettatore di aver ormai raggiunto la libertà di scegliere chi e come essere, proponendogli immagini meno tradizionali. Mentre dunque sono diventate più complesse alcune rappresentazioni sociali di genere, la rappresentazione del corpo femminile si è invece fatta sempre più normativa: la tv è produttrice di corpi perfetti, ideali e dunque irreali ma che assumono statuto di realtà nel processo di interiorizzazione delle spettatrici. Questo è un passaggio fondamentale che ha reso, come vedremo, talent show e reality show tra i programmi più visti dalle ragazze. Il riproporre continuamente determinate immagini e stereotipi bombardando letteralmente la mente degli ascoltatori porta ad un’omologazione dei desideri collettivi e alla costruzione di un ideale di bellezza. I media dunque non forniscono solo modelli (di bellezza e di genere) che piacciono al pubblico, ma formano il gusto stesso degli spettatori. Riprendendo un’indagine (tratta da Genere, corpi e televisione di S. Leonelli e G. Selmi) fatta a ragazzi e ragazze del liceo (tramite questionario e lavori in gruppo) che ci aiuterà in questa analisi tramite diversi dati, si può notare infatti come alcune risposte “standard” ed alcuni stereotipi o omologazioni di sogni e desideri siano più presenti nei soggetti che passano più tempo dinanzi al televisore e che sono più esposti ad alcuni generi di programmi. La maggior parte delle ragazze guarda principalmente serie televisive e reality show, a differenza dei coetanei maschi che privilegiano cartoni animati e sport.La preferenza non è casuale, bensì indotta dalle pressioni esercitate sul soggetto in quanto appartenente ad un genere. Serie e reality ripropongono schemi piuttosto banali, sono quindi facili da vedere e appassionano le spettatrici che possono anche prevedere (ed essere da questo gratificate) ciò che accadrà. Ma soprattutto sono creati in modo che chi li guarda abbia la sensazione di riconoscersi in esperienze simili, nelle emozioni e nelle relazioni dei protagonisti, e dare quindi senso anche alla propria esperienza quotidiana. Mentre Hollywood è un mondo lontano da noi, questi personaggi ci sembrano invece molto più vicini, simili a noi, e dunque reali. Anche i corpi, così realistici, risultano più reali. “L’impulso verso la gente comune e verso il “reale” non è un avvicinamento al pubblico, ma una strategia di costruzione delle soggettività generalizzata”. La proposizione negli ultimi anni del modello curvy è l’esempio eclatante di questo meccanismo mediatico: se la coscienza popolare si oppone alla modella anoressica anni ‘90, troppo distante dalla realtà, i media creano un nuovo canone, che meglio si adatti alla società del momento. Ma non facciamoci ingannare da qualche chilo in più: non è un passo verso la libertà di scelta, solo un nuovo modello da seguire. Questo “realismo” è oggi, molto più che prima, estremamente richiesto anche dalle ragazze. Quando infatti viene chiesto loro a chi vorrebbero assomigliare e a chi non vorrebbero assomigliare, le risposte a questo secondo quesito si riferiscono nella quasi totalità a conduttrici e attrici che sono “troppo” rifatte, e dunque chiaramente irreali (nota bene: la chirurgia è più che accettata, purché nei limiti). Dalle risposte alla prima domanda appare poi in modo eclatante quanto lo strumento televisivo sia riuscito nell’omologazione di una generazione, tanto che la maggior parte delle giovani ha nominato le stesse tre show girls. D’altra parte non è facile allontanarsi dai modelli prodotti: le giovani donne avvenenti sono la quasi totalità delle figure femminili che possiamo vedere in tv; le donne “anziane” rappresentano solo l’8% (!) delle donne che vanno in televisione e sono normalmente politiche o esperte di altro tipo, dunque poco presenti e in ogni caso assenti nei programmi e nelle fasce orarie seguiti dai giovani. Per quanto riguarda i ragazzi, questi vorrebbero assomigliare a personaggi sportivi (le donne devono esprimere sensualità, gli uomini forza). Significative sono le risposte sul personaggio cui non vorrebbero somigliare: vengono nominati per la maggior parte personaggi televisivi omosessuali. Benché dunque la domanda si limitasse a parlare di estetica, gli adolescenti ritengono fondamentale sottolineare la loro mascolinità e il loro rifiuto del gay, ovvero del non-maschile, del non-uomo (concetto che invece non vale per le donne: l’essere lesbiche non è necessariamente visto in opposizione all’essenza femminile). L’omosessualità maschile, ancor più di quella femminile, deve essere ed è fortemente contrastata in quanto scardina alla base la gerarchia di potere uomo-donna del sistema patriarcale. Il piccolo schermo non ci fornisce dunque solo caratteristiche fisiche cui omologarsi, sarebbe altrimenti difficile assoggettarvi il pubblico. Nasce per questo la donna “bella e brava”, che ha spopolato nell’ultimo decennio. Questo binomio ci viene proposto già in tenera età nei cartoni animati, opposto al cattivo che è invece sempre “brutto e cattivo” come se appunto la bellezza esteriore coincidesse con quella interiore. Crescendo il concetto rimane, anche se con accezioni più complesse; nel caso televisivo il concetto di “brava” coincide per ragazzi e ragazze con quella conduttrice o attrice che oltre a saper fare il suo lavoro (e naturalmente essere bella) è anche una brava persona, il che converge nella donna con l’essere madre e moglie. La maggior parte delle donne in televisione non sposate risultano invece agli occhi degli studenti delle “poche di buono” (whore stigma = sanzione sociale in termini di onore e reputazione a partire dall’utilizzo che le donne fanno del proprio corpo e della propria sessualità; vedi Gail Pheterson, Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness, 1993).
Tutto questo scenario influisce chiaramente non poco sull’idea che gli adolescenti, ma soprattutto le adolescenti, hanno di loro stessi e del loro corpo. La differenza tra i due sessi la si può notare attraverso semplici dati. Il 30% delle intervistate si considera troppo grassa, mentre solo il 12% degli intervistati si ritiene tale (quando peraltro nel campione risultano sovrappeso solo il 7% delle ragazze e l’11% dei ragazzi). C’è in generale una incoerenza tra la visione che le ragazze hanno del proprio corpo e la realtà, cosa che non si riscontra tra i ragazzi intervistati. Un altro dato significativo emerge quando viene chiesto agli intervistati se e quali parti del proprio corpo cambierebbero: la quasi totalità delle ragazze attuerebbe una modifica, un po’ meno i ragazzi. L’oggettivazione del corpo femminile fa sì che esse suddividano idealmente il loro corpo in parti distinte, ognuna delle quali viene fatta passare per il rigoroso vaglio delle norme corporee: a maggior ragione sono dunque disposte a cambiarle con la chirurgia. Addirittura qualche decennio fa si facevano concorsi di bellezza che premiavano una sola parte del corpo coprendo le altre: abbiamo immagini di donne con sacchetti di carta in faccia con dei buchi per gli occhi (“miss occhi belli”) o immagini di sole gambe. Chiaramente, le parti che non piacciono alle fanciulle sono quelle che esprimono sensualità, ai loro coetanei quelle che esprimono forza. Le giovani donne si piacciono in ogni caso più magre di quanto non le vorrebbero i maschi stessi, e la volontà di perdere peso coinvolge molto più quelle che vedono reality rispetto alle coetanee che guardano più Tg o documentari! A tutto questo hanno poi fortemente contribuito i social network nati negli ultimi anni. Strumenti come facebook o instagram trasformano il soggetto da spettatore a protagonista, rendendo apparentemente ancor più vicine a noi le immagini fittizie di corpi perfetti, ma soprattutto creando nei giovani la necessità di mostrarsi. Qualunque attività deve essere ridotta ad un’immagine da condividere con la speranza di ottenere più like possibile. Le emozioni stesse, i sorrisi, a volte persino le lacrime, vengono trasportate sullo schermo e devono apparire in tutta la loro bellezza (a costo di utilizzare photoshop). Perché l’importante non è tanto viverli, quanto mostrare di averli vissuti e raggiungere un numero considerevole di “mi piace”. Per “piacere” è però necessario assimilarsi al gusto della comunità, che si esprime cliccando su un tasto. Un po’ come in un concorso di bellezza si vota per la ragazza (o il ragazzo, anche se più raramente) più bella, così scorrendo le immagini dei vari profili si decide chi merita o meno la nostra approvazione. E più l’immagine piace, più viene riproposta agli utenti del social, e più viene mostrata, più i destinatari si sentono in obbligo di assomigliarvi, nella speranza di avere anch’essi altrettanti “mi piace”… in un’incessante gara il cui traguardo non arriverà mai. È dunque evidente come le ragazze continuamente bombardate da immagini e stereotipi che le vogliono tutte uguali, tutte perfette secondo i canoni che la società stabilisce e appetibili per lo sguardo (protagonista) rigorosamente maschile, assorbano e si assoggettino a tali ideali, facendoli propri. Ridotte dal nostro sistema patriarcale cui si asserviscono i media ad essere corpi e non persone, e corpi che devono rimanere entro stretti e rigidi canoni, senza possibilità di trasgressione, quest’ultima severamente punita dallo sguardo della collettività. È importante che le donne, le ragazze e ancor prima le bambine riescano a riconoscere e mediare queste influenze deleterie per iniziare a ribellarsi all’omologazione e oggettivazione da sempre in atto sul nostro corpo e dunque sulla nostra persona ed esistenza.
Il caso di Kobane
Gli uomini di Kobane: i più belli del mondo
“Mi sono perso nel guardare le foto dei festeggiamenti dei curdi, l’altro giorno. Mi sono perso nei loro sorrisi, nei volti puliti, nei capelli sciolti e nei pugni sollevati al vento, contro il cielo nero, buio, di una notte illuminata a giorno. Non mi sono sentito rincuorato o felice quando ho letto la notizia di Kobane libera, lo sono stato quando ho visto queste foto, quando ai vincitori ho potuto associare un volto. Un volto di uomo, giovane; un volto finalmente libero – com’è finalmente libera Kobane – dall’ansia e dallo stress, ringiovanito dalla contentezza della vittoria, rilassato come non lo era da mesi. Non sono un attivista e non lo sarò mai. Non sono nemmeno uno dei sostenitori della prima ora, eppure anche io mi sono innamorato di Kobane, degli uomini di Kobane, i più belli del mondo. Belli di una bellezza nuova, rigenerata, ricostruita come una fiamma dall’incontenibile gioia di ritornare per le strade della propria città, come uomini liberi.”
Poche persone, leggendo un articolo del genere non lo reputeranno, se non assurdo, perlomeno insolito. È l’effetto prodotto dalla trasposizione al maschile di un articolo scritto per “celebrare” le guerrigliere curde. Raramente nelle cronache di guerra si è data così tanta importanza all’estetica come sta succedendo per quanto riguarda Kobane. L’unico motivo di questo fenomeno è che le soldate che difendono la città di Kobane sono donne, e in quanto tali vanno celebrate prima di tutto dal punto di vista estetico, perché si sa che è principalmente nell’aspetto fisico che risiede la dignità di una donna, la sua “femminilità”. Nell’aspetto fisico e in certe sue caratteristiche tipiche, come la docilità, la dolcezza, la maternità e l’abnegazione. Gli autori e le autrici di articoli di questo tipo sono nemici delle combattenti curde. Queste donne, insieme agli uomini, combattono contro un nemico reale, certo, ma anche contro tutti i disvalori che si porta dietro, compresa la sottomissione della donna. Trattare la donna in modo passivo, obbligarla a passare attraverso lo sguardo maschile, che mette sulla bilancia il suo aspetto fisico fino a bollarla come più bella del mondo, alla stregua di una qualsiasi miss da concorso di bellezza, è sottomissione: è non riconoscere alle donne lo statuto ontologico di individui, esistenti perché agenti, non in quanto passivi oggetti delle attenzioni e delle azioni di qualcun altro. Questo tipo di informazione continua a veicolare la passività che contraddistingue le donne agli occhi maschili in tutto il mondo, dal Medio Oriente alla civilizzatissima Europa, senza eccezioni. L’emancipazione femminile non si è conclusa con le battaglie delle suffragette per il diritto di voto o con le rivendicazioni salariali tese ad assicurare pari livelli di retribuzione a uomini e donne, uniti nell’oppressione: la donna occidentale continua ad essere in catene, legata da opinioni, pregiudizi e discriminazioni. In nessuna società in cui ad una liberazione ed equalizzazione dal punto di vista delle condizioni non si affianchi una pari dignità nella testa delle persone e nei rapporti interpersonali la donna può essere considerata libera. Nessuna lotta è davvero rivoluzionaria se non va di pari passo con la distruzione della subalternità tra i generi. Quindi, invece di scadere nel solito vizio di vestire con abiti occidentali tutto ciò che entra in contatto con noi, di fronte a situazioni come quella che si sta verificando nel Rojava dovremmo avere l’umiltà di farci insegnare qualcosa, da persone che stanno portando avanti sia la teoria che la pratica dell’antisessismo. Il nostro commosso apprezzamento paternalista ce lo possiamo risparmiare e ridare alle combattenti e ai combattenti la dignità che devono avere ai nostri occhi, quella di persone che difendono il proprio territorio, la propria vita e le proprie idee a tutti i costi, con il coraggio tipico dei resistenti, di chi non ha niente da perdere.
Che fare?
 “Avremo già fatto un passo avanti sotto il profilo politico quando avremo respinto il concetto propinato ostinatamente secondo cui l’aspetto esteriore di una donna è il suo linguaggio, e quando ci ascolteremo a vicenda al di là del mito della bellezza” (Naomi Wolf, Il mito della bellezza, 1991)
“Avremo già fatto un passo avanti sotto il profilo politico quando avremo respinto il concetto propinato ostinatamente secondo cui l’aspetto esteriore di una donna è il suo linguaggio, e quando ci ascolteremo a vicenda al di là del mito della bellezza” (Naomi Wolf, Il mito della bellezza, 1991)Già molti anni fa, nella prima metà del ‘900, Simone de Beauvoir parlava della costruzione della cosiddetta “donna narcisista”, che passa attraverso due processi: la delusione derivata dalla negazione della propria soggettività e della propria sessualità aliena la donna da se stessa e la passività cui è costretta la porta a cogliersi nell’immanenza della propria persona. La donna è portata così a trovare soddisfazione solo in se stessa e nella propria immagine e ciò è reso possibile dal fatto che, fin da bambina, le si è insegnato a vedersi come un oggetto. A ciò si aggiunge l’entrata in gioco della reciprocità rispetto al soggetto maschile: “Poiché è l’uomo che incarna per la donna il destino, è dal numero e dalla qualità degli uomini sottomessi al loro potere che le donne misurano in genere il loro successo” così la donna “diventa schiava dei suoi adoratori, si veste, vive e respira solo attraverso l’uomo e per lui”. Simone de Beauvoir relaziona così l’ossessione dell’immagine alla negazione stessa del femminile, e spiega poi con chiarezza il processo di oggettivazione e interiorizzazione della problematica operato dalle donne stesse. La geniale analisi dell’autrice necessita, ai giorni nostri, di un passo avanti, alla luce dei cambiamenti avvenuti nella società, ma resta comunque un ottimo punto di partenza per capire che vi è un legame stretto fra società attuale e “mito della bellezza”, ma ve ne è uno ancora più stretto fra questo mito e le relazioni di genere asimmetriche in generale. Nel mondo attuale non esiste più la donna narcisista di Simone de Beauvoir, perché siamo divenute tutte donne narcisiste; e non è più solo la noia, la passività o la negazione della propria soggettività a condurci su questa strada, poiché il “mito dell’immagine”, come lo chiamava Naomi Wolf, è divenuto lo strumento principe di riproduzione della società maschilista e capitalista. Maschilista perché è attraverso la schiavitù della bellezza che la donna riduce i suoi nuovi spazi d’azione, e capitalista perché l’industria della bellezza è divenuta ormai uno dei pilastri economici dell’era del consumo.
E ancora: maschilista perché viviamo una società che fin dalle favole imprime nella mente l’idea che non si può vivere senza l’amore, che una donna non può vivere senza un uomo accanto (ma non vale il contrario) e pur di ottenerlo o tenerlo al proprio fianco si può fare qualunque cosa. E questo provoca due risultati aberranti: il riconoscimento di un certo potere ed una certa superiorità dell’uomo dovuti alla nostra necessità di una sua presenza, ed una sempre maggiore rivalità tra donne nel raggiungimento della “perfezione” e della bellezza che ci assicureranno amore e felicità. Infine, capitalista perché le industrie ci forniscono continui stimoli che provocano in noi un sempre più forte disprezzo per il nostro corpo continuando a cercare di porvi rimedio attraverso cosmetici, diete, farmaci, chirurgia … sino a farsi del male per il raggiungimento di questo irreale ideale. Il nostro lavoro analizza solo una parte delle problematiche legate all’estetica: il fulcro del problema si trova infatti per noi nel controllo esercitato dal sistema sulle nostre scelte attraverso l’ossessione per l’apparire. All’interno di un percorso di lotta teso alla liberazione dei nostri corpi, mettere in discussione il bisogno di aderire ad uno (o più) modelli preconfezionati di bellezza diventa per noi un passaggio fondamentale. Il corpo è il centro dell’oppressione delle donne, quindi è da questo che dobbiamo partire. “Nel sistema patriarcale [...] il “corpo della donna” è visto come elemento fondamentale della reificazione e controllo esterno, cioè uno spazio primario di oppressione di genere: è stato considerato e valutato in una misura che assume e si esprime mediante una dedizione quasi esclusiva “agli altri”, cioè a tutto ciò che è fuori da se stessa”. In un contesto del genere, è normale guardare a noi stesse attraverso gli occhi degli altri. “Noi valutiamo noi stesse in funzione di una valutazione esterna che in grande misura dipende da quanto ci approssimiamo ad un ideale di bellezza irreale, inumana e nella maggior parte dei casi irraggiungibile”. Cosicché “la nostra stima ci è “esterna”, non dipende da noi stesse, e per questo comporta una perdita della nostra autonomia, del nostro controllo, della nostra sicurezza”4. Un primo passo potrebbe consistere nel prendere coscienza dei limiti che ci imponiamo: l’energia ed il tempo che impieghiamo giornalmente nella costruzione di una forma esteriore il più attraente possibile rappresentano, di per sé, un vincolo enorme. Un altro elemento che entra in gioco parlando di estetica è il desiderio. Sfruttando una definizione di Gilles Deleuze* potremmo dire che ogni nostra scelta legata all’estetica, dal colore dello smalto al modello di scarpe, non esprime semplicemente la voglia di un certo oggetto rispetto ad un altro ma piuttosto la volontà di adesione ad uno scenario o ad un ambiente che ci sembrano più accattivanti e vincenti di altri. Queste scelte incidono come abbiamo visto anche su componenti quali il linguaggio e la gestualità, che tenderemo a conformare a quelli richiesti dal contesto. Diventa perciò importante riappropriarsi del desiderio come costruzione personale piuttosto che replica infinita di un canone precostituito. La liberazione collettiva del genere femminile parte così innanzitutto da una rivoluzione interiore: dobbiamo problematizzare la tematica della bellezza femminile e cercare di liberarci dalla “tirannia della bellezza” attraverso l’accettazione di sé e la decostruzione dei modelli estetici imposti. Dobbiamo distaccarci da questi ideali borghesi di bellezza, e per farlo è necessario decostruire gli schemi e i valori su cui si regge la società attuale. Dobbiamo prendere coscienza di aver introiettato un dispositivo-estetica, che, insieme agli altri dispositivi imposti dalla società, guida la nostra percezione e i nostri gusti allo scopo di controllarci e farci aderire a un modello prestabilito, con un procedimento perverso che ci impedisce di riconoscerne il carattere coercitivo e per cui pensiamo di stare seguendo le nostre inclinazioni ed esprimendo la nostra personalità. Provare a liberarsi è provare a mutare l’ordine delle nostre priorità e togliere lo status di valore alla bellezza fisica, riuscendo a fare un passo avanti nel riconoscimento della donna come soggetto attivo e non più come mero oggetto del piacere maschile; togliere il peso dell’estetica dalle nostre relazioni e dalle valutazioni di merito, aprendoci ad un sistema alternativo in cui non si è più costantemente giudici e giudicati solo in virtù dell’aspetto esteriore. Questo ci permetterebbe di rifocalizzare ciò che conta e costruire nuovi percorsi di lotta.
* “Non si desidera mai veramente qualcuno o qualcosa. Si desidera sempre un ‘insieme’. Qual è la natura dei rapporti tra gli elementi perché ci sia desiderio, perché diventino desiderabili? Dice Proust, non desidero una donna, ma desidero anche un “paesaggio” che è contenuto in quella donna, un paesaggio che forse neanche conosco, ma che intuisco e finché non ho sviluppato questo paesaggio non sarò contento, cioè il mio desiderio non sarà compiuto, resterà insoddisfatto. Quando una donna dice “desidero un vestito” è evidente che non lo desidera in astratto. Lo desidera nel suo contesto, nella sua organizzazione di vita. Il desiderio non solo in relazione a un paesaggio, ma a delle persone, i suoi amici o no, la sua professione. Non si desidera mai qualcosa di isolato. [...] Desiderare è costruire un concatenamento, costruire un insieme. L’insieme di una gonna, di un raggio di sole … di una strada, il concatenamento di un paesaggio, di un colore. Ecco cos’è il desiderio” (Gilles Deleuze, L’abecedario)
note
1Mauss M., 1936, Les techniques du corps, in «Journal de Psychologie», XXXII. 2Ricerca di Sobieraj citata in Ricchiardi P., Venera A. M., 2005, Giochi da maschi, da femmine e… da tutti e due: studi e ricerche sul gioco e le differenze di genere. 3Redazione Salute Online – Corriere della Sera, 25/09/2012, Bambine che si truccano: boom di dermatiti, http://www.corriere.it/salute/derma…. 4Citazioni tratte da Annerys Carolina Gómez, La tirannia della bellezza.
Leggi anche:
























