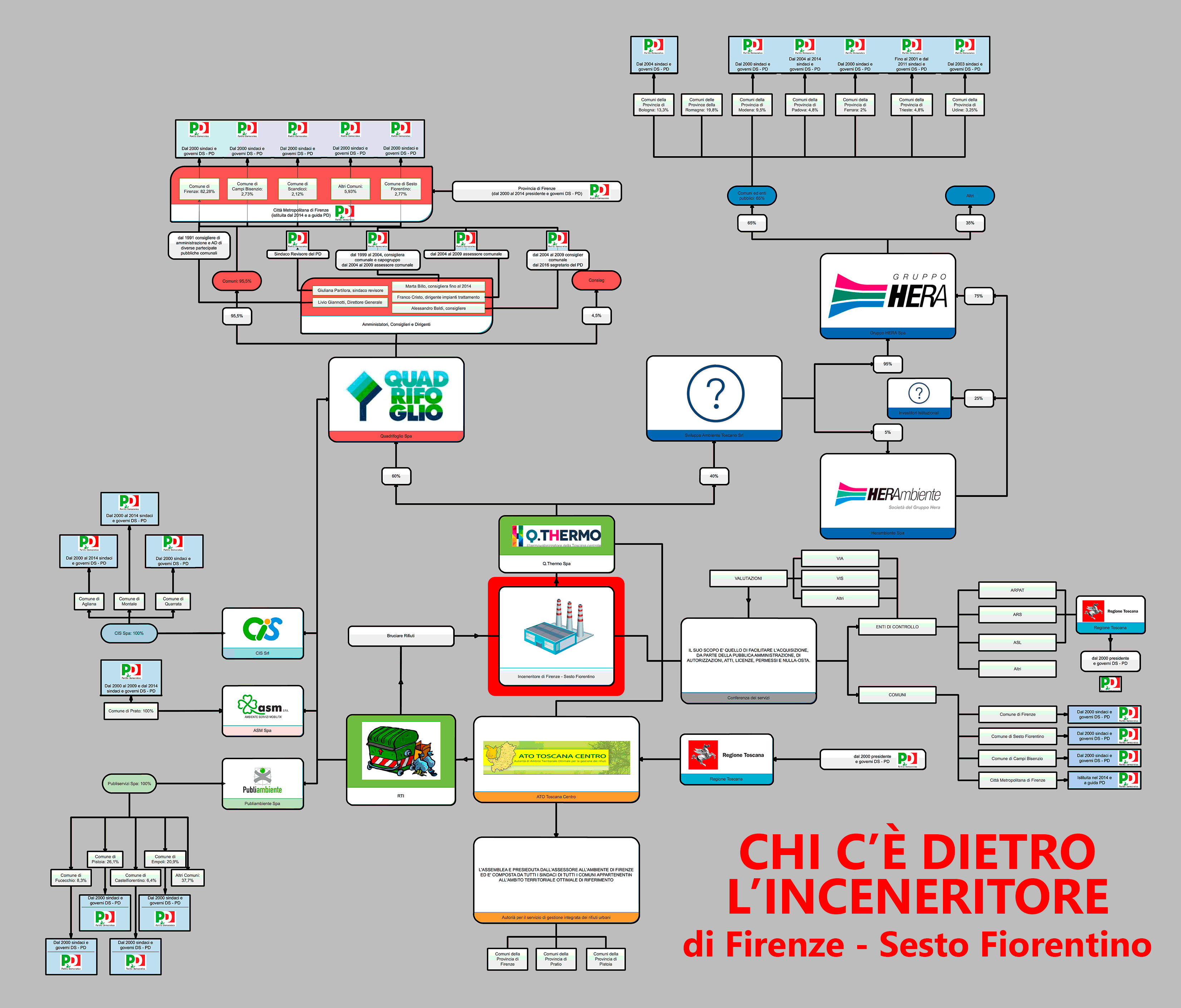Indagine su un partito al di sopra di ogni sospetto: il fu Partito comunista italiano
 Lodovico Festa, La provvidenza rossa, Sellerio Editore, Palermo, 2016.
Lodovico Festa, La provvidenza rossa, Sellerio Editore, Palermo, 2016.
Prossimo ai settant’anni, Lodovico Festa ha deciso di fare i conti con il fu Partito comunista italiano, al quale dedicò i migliori anni della sua vita, facendo comunque una bella carriera. Ci aveva già tentato, girandoci intorno, ma con approcci un po’ troppo seriosi (politologici & politically correct), per suscitare un’apprezzabile eco. Motivo per cui, ci tenta ora con la formula letteraria del giallo che, titillando morbose curiosità, è diventata sciaguratamente alla moda.
Anche un’inchiesta sul fu Partito comunista italiano titilla morbose curiosità, se il filo conduttore risponde ai più classici canoni del poliziesco e soprattutto del noir, considerando l’intreccio di sesso-affari-politica, in cui si districa l’apparatčik-detective, protagonista della vicenda. E alter ego dell’autore.
L’inchiesta è un viaggio nel Pci nel periodo in cui giungeva all’apogeo della sua parabola politica, con le affermazioni elettorali del 1975-1976 e il quasi approdo al governo centrale, grazie al compromesso storico e alla Solidarietà Nazionale, dopo trent’anni di quarantena relativa. Lo scenario è una Milano alle soglie di grandi trasformazioni, di cui già si avvertono le prime manifestazioni che sfuggono però al ceto politico e, in particolare al Pci, finalmente a capo della «capitale morale d’Italia».
Ma anche il Pci stava mutando. Nella sua composizione sociale occupavano sempre più spazio i ceti medi «emergenti» delle professioni, della cultura, delle arti, tra i quali brillano gli architetti-sociologi che sognano di riplasmare il volto urbano e sociale della città. Finiranno al servizio dei vari Li Calzi (Epifanio), Berlusconi, Ligresti (Salvatore) & Co. Questo, Festa non lo dice, lo lascia solo intuire, come molte altre deleterie conseguenze delle scelte politiche di quegli anni.
Banchieri, faccendieri e lenoni (rossi)
L’anomalo omicidio di una militante del Partito è il pretesto per l’indagine che coinvolge le svariate facce del Pci milanese di quegli anni, portandone allo scoperto i vizietti. E non solo sessuali.
Nel tentativo di essere veramente il Partito nazional-popolare proposto da Palmiro Togliatti, il Pci milanese si stava estendendo in un coacervo di ambienti dediti a piccoli e grandi intrallazzi, inoltrandosi in un variopinto sottobosco sociale in cui, tra banchieri «rossi» e entraîneuse (altrettanto «rosse»), si miscelavano tradizionalismo operaio e pragmatico affarismo borghese, appena mascherato da una residuale «etica comunista» che non è altro che la morale bacchettona piccolo borghese[1], prossima a mostrar la corda.
Festa dipinge un affresco sociale ricco di dettagli, in cui ritrae figure politiche, intellettuali e affaristiche di quegli anni. A parte quelle già consacrate dalla Grande Storia, le altre figure sono presentate con nomi di fantasia, spesso assai trasparenti: Marco Bagnoli è ovviamente Carlo Tognoli (p. 252), Fernando Borutta/Armando Cossutta (p. 290) Roberto Seco/Umberto Eco (p. 338 ), Gigino Ramò/Antonio Tatò (p. 506) … Con un’eccezione: Achille Occhetto, curiosamente definito «fantasioso». Forse, per tracciare una linea di continuità con l’innominato Segretario Nazionale.
La trama è intrigante e rende scorrevole la lettura delle 527 pagine del libro. Contribuiscono poi sprazzi di iperbolica comicità che, privilegiando il lato gastronomico, evocano situazioni fantozziane. Infine, chi ha vissuto, direttamente o indirettamente, quelle esperienze, le rivive con gli occhi di una satira impietosa, a partire dal linguaggio burocratico («la langue de bois», la lingua di legno, p. 35) che contraddistingueva il lessico dei militanti e della stampa del Partitone. Rivede atteggiamenti e persone che, allora, apparivano del tutto «normali». Ma apparivano «normali», perché simulavano, ci dice Festa:
«Solo i dirigenti del partito più intelligenti sapevano da avere molto da imparare dalle persone normali. Ma erano i più intelligenti, e secondo qualcuno si stavano rarefacendo» [p. 411]».
Coglioni & furbastri …
Dice che vuol pensare con la sua testa.
Che di solito l’è il modo per dii stupidad [p. 51].
Finita l’allegra lettura, si può avere l’impressione che il Pci fosse composto da una massa di coglioni («anime candide», p. 489) diretta da un pugno di furbastri … Misero epitaffio, per un partito che, in quasi mezzo secolo di vita, abbracciò almeno metà degli italiani, direttamente e indirettamente.
Mi sembra doveroso fare qualche riflessione supplementare.
Ci sono aspetti che il libro non tocca o lascia sullo sfondo, sfiorandoli appena. Festa fa essenzialmente riferimento alla sua esperienza che, sottolineo, avvenne in un momento cruciale e che coinvolse una parte significativa di una generazione, allora sui trent’anni, appartenente a un ambiente sociale analogo al suo, ovvero il ceto medio milanese.
 E’ doveroso allora chiedersi per quali motivi costoro aderirono al Pci?
E’ doveroso allora chiedersi per quali motivi costoro aderirono al Pci?
«Nel Pci si entrava o per grande coraggio, la volontà di sfidare il mondo, di aprire nuove vie all’umanità, o per grande paura, cercando la protezione di una imponente struttura assai organizzata e combattiva nei confronti di una società minacciosa. In ognuno dei militanti quasi sempre i due sentimenti s’intrecciavano con diverse gradazioni» [p. 324].
Nelle specifiche circostanze di quegli anni, Festa privilegia implicitamente la seconda opzione: la paura. Egli mostra disinteresse se non fastidio e avversione per i movimenti di contestazione che, in parte, investirono anche il Pci, col gruppo del Manifesto. Facendo di ogni erba un fascio, non ne coglie i presupposti sociali del Sessantotto che risiedevano nelle trasformazioni avvenute in Italia sulla scia del boom economico. Ne consegue una percezione politica per lo meno distorta.
Rievocando quel periodo (la vicenda si svolge nel fatidico 77), Festa non solo apprezza il ruolo («il senso dello Stato», p. 486) che il Pci ebbe nella lotta contro l’eversione (il «terrorismo»!), ma ne apprezza anche la capacità di controllare la classe operaia.
«Tamburi e fischietti erano un’invenzione propria dei comunisti milanesi. Quando nel ’61 i movimenti di lotta erano ripartiti con particolare vigore, in una direttiva della Federazione milanese del Pci in cui discuteva la situazione del movimento di lotta e i sindacalisti si preoccupavano degli estremisti verbali che durante i cortei avrebbero potuto eccitare troppo gli animi, il supercinico Renaioli [nome di fantasia, ndr] aveva suggerito di usare i fischietti: fanno chiasso, danno il senso della mobilitazione e impediscono di urlare scemenze. L’idea dei tamburi, sempre a Renaioli, era venuta riflettendo sulle manifestazioni naziste degli anni Trenta e la loro perfetta tambureggiante coreografia» [p. 272].
Chi a Milano ha partecipato e partecipa a cortei sindacali sa bene come questo espediente abbia avuto una deleteria pratica… tutt’ora applicata.
Questa digressione apre un sintomatico spiraglio che consente di dare significato a quel desiderio di una trasformazione del Partitone che, nel libro, emerge tra le righe e che, altrimenti, aleggerebbe nel vuoto[2].
Prima, ho accennato ai ceti medi «emergenti». Devo ora precisare che, nella loro adesione al Pci, diventava sempre più problematico il rapporto con una classe operaia che, nel libro, appare quasi come un «convitato di pietra». Di lì a poco, le ristrutturazioni industriali avrebbero notevolmente ridimensionato il ruolo politico degli operai. Dopo di che, qualche maître à penser avrebbe impunemente parlato di «scomparsa della classe operaia». E il Pci non avrebbe più avuto ragione di esistere. Ma ci voleva un colpetto.
Dalla rete di interessi al comitato d’affari
Col «crollo del muro» (e dell’Urss), il Pci si sarebbe avviato verso una serie di prevedibili (e timide) mutazioni genetiche. Festa avrebbe partecipato alla pattuglia di piccisti delusi (Meluzzi, Bondi …) che, al seguito di Giuliano Ferrara, avrebbe aderito al progetto berlusconiano di Forza Italia. Nonostante questa precisa scelta, il suo libro resta in mezzo al guado: non ci dice che cos’era il Pci. E che cosa non era.
Avanzo qualche sintetica ipotesi.
Alla fine degli anni Settanta, il Pci si era ramificato in una rete di interessi (e affari) assai vasta e articolata, in cui si dovevano incontrare e conciliare operai e ceti medi emergenti. Questa rete era gestita e controllata da un efficiente apparato politico che, tendenzialmente, avrebbe potuto rendersi autonomo[3]. L’ostacolo alla sua autonomizzazione era costituito dalla prospettiva politica-utopica del Partito che, nobilitando la natura prosaica della sua funzione, la giustificava, impedendo che essa prendesse il sopravvento. L’una era legata all’altra.
La prospettiva politico-utopica era originariamente il paradiso sovietico, incensato per anni da carismatici esponenti politici e da illustri intellettuali, non esclusivamente del Pci [4]. Poi, via via che le magagne e i crimini di quel paradiso venivano allo scoperto, l’utopia cercò nuovi orizzonti. Ma divenne più effimera, fatua (e reazionaria), offrendo solo gli occasionali spunti che davano dignità politica e culturale alla vita politica del Partito che, altrimenti, si sarebbe ridotta al livello di un puro apparato manageriale. Spassosissima è la campagna di tesseramento che fa da sfondo a tutta la narrazione!
Dopo di che … fu il nulla.
La «fine delle ideologie» ha ridotto l’attività dei partiti politici alla pura gestione dell’esistente. In Italia, la linea l’aveva indicata negli anni Ottanta il Psi di Bettino Craxi. Negli anni Novanta, Berlusconi le diede slancio e successo con Forza Italia. Il partito politico non aveva più il compito di gestire e conciliare una rete di interessi, a volte divergenti: assumeva direttamente
il ruolo di una lobby di affaristi & faccendieri.
I cascami del Pci (e della Dc) avrebbero avuto una gestazione molto più lenta. Su loro gravava la pesante ipoteca nazional-popolare e catto-comunista che doveva essere consumata e superata, senza troppi traumi. Il parto lobbistico è avvenuto con il governo Renzi-(Napolitano). Il prezzo (e il rischio) di questa evoluzione è il calo della «partecipazione» elettorale (astensione) e dei consensi, come già sta avvenendo. E questa segna la fine della loro democrazia. Anzi, della democrazia, sans phrase.
Dino Erba, Milano, 12 agosto 2016.
Per approfondire
– Maurizio Caprara, Lavoro riservato. I cassetti segreti del Pci, Feltrinelli, Milano, 1997.
– Massimo Caprara, Quando le Botteghe erano oscure, 1944-1969: uomini e storie del comunismo italiano, EST, Milano, 2000.
[1] Sulla morale «comunista», vedi: Franco Andreucci, Da Gramsci a Occhetto. Nobiltà e miseria del PCI 1921-1991, Della Porta Editori, Pisa-Cagliari, 2014, p. 267. Rimando a questo libro per una panoramica complessiva sul Pci.
[2] Negli anni Settanta, Gilles Martinet aveva ipotizzato una possibile evoluzione socialdemocratica del Pci, senza capirne la natura sostanzialmente reazionaria: un partito reazionario di massa. Ma questa è un’altra storia.
[3] Giulio Seniga usava il termine di «ciurla» per indicare «l’insieme di coloro che erano mossi non da un interesse ideale ma dall’appartenenza a un apparato, un partito, un servizio segreto; insomma tutti coloro che ricavavano uno stipendio, una prebenda o un tornaconto personale svolgendo attività politiche …», vedi: Giulio Seniga, Credevo nel partito, a cura di Maria Antonietta Serci e Martino Seniga, Biblioteca Franco Serantini, Pisa, 2011, p. 226.
[4] Vedi alcune perle in: Franco Andreucci, Da Gramsci a Occhetto, op. cit., p. 254 e ss.
Leggi anche: