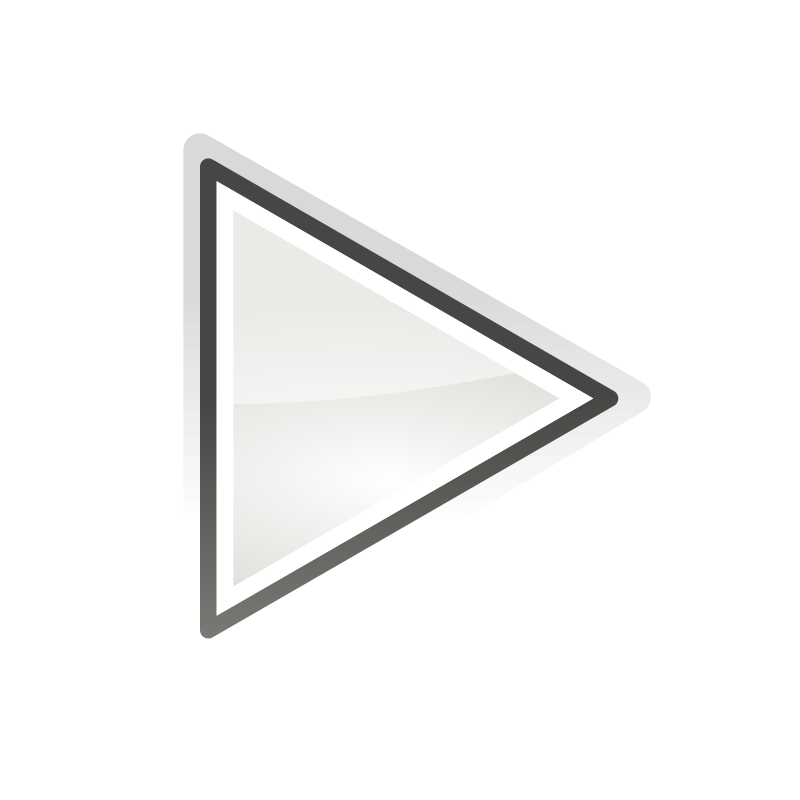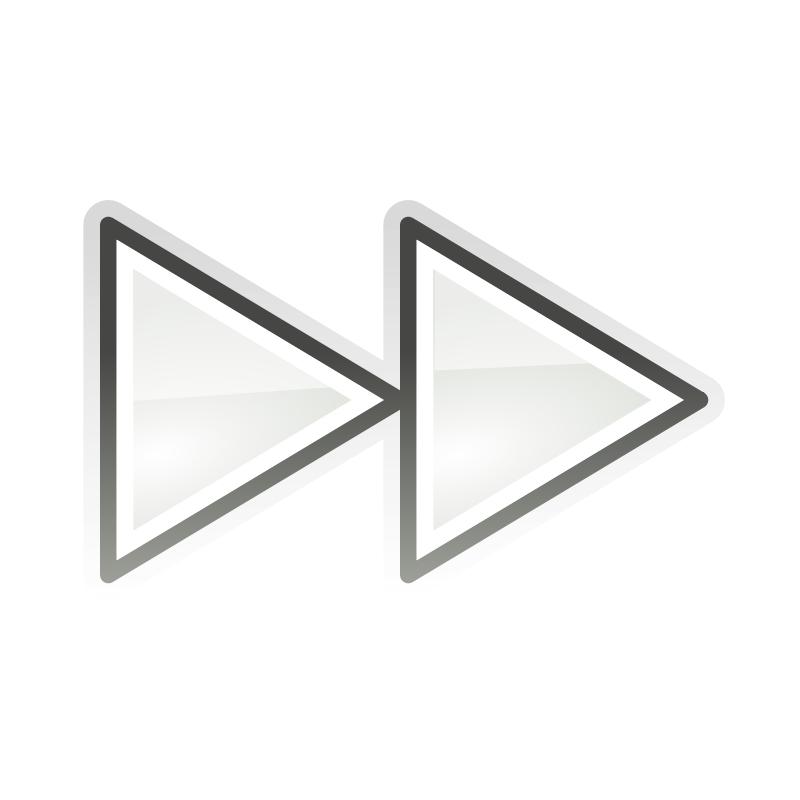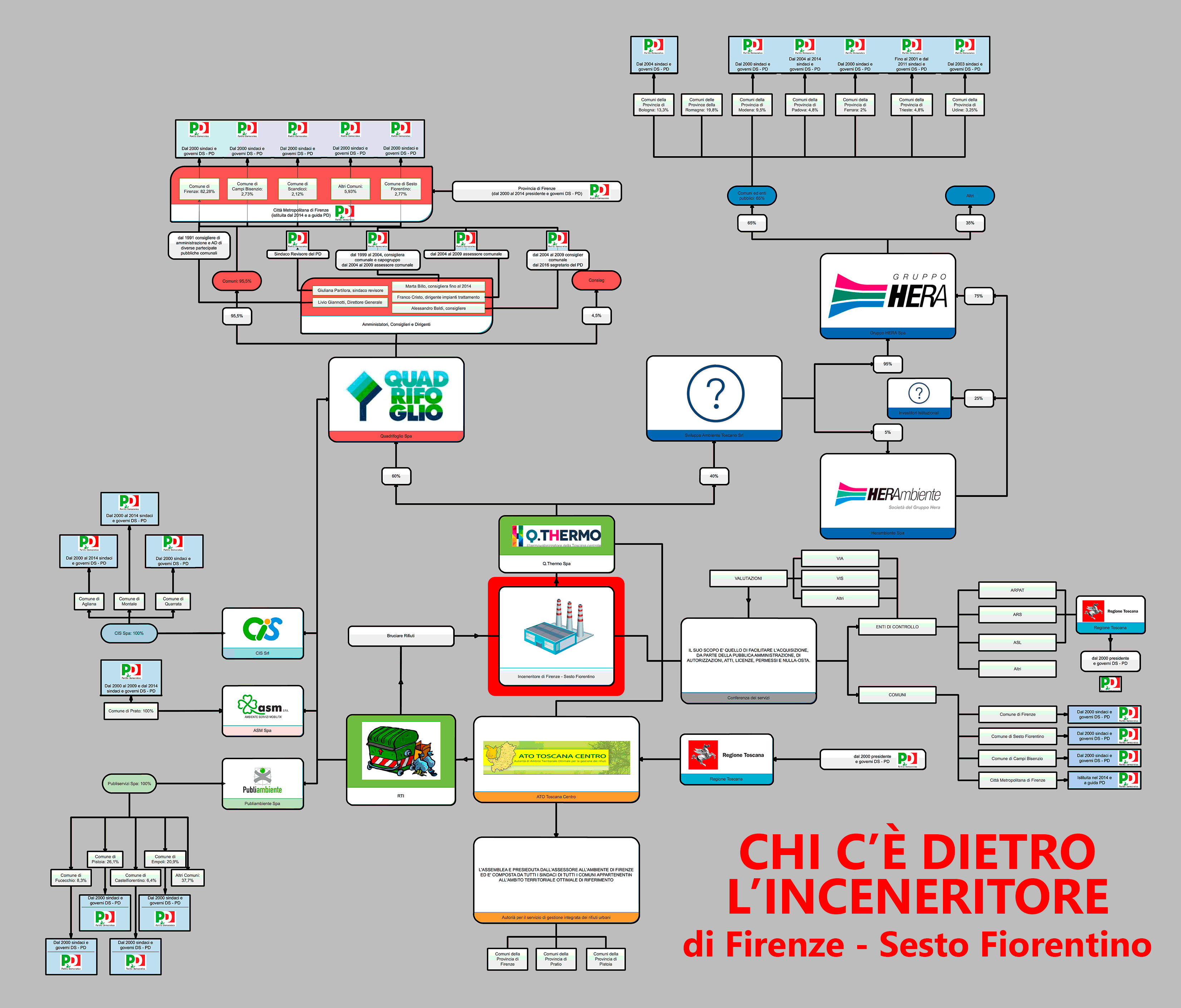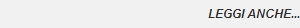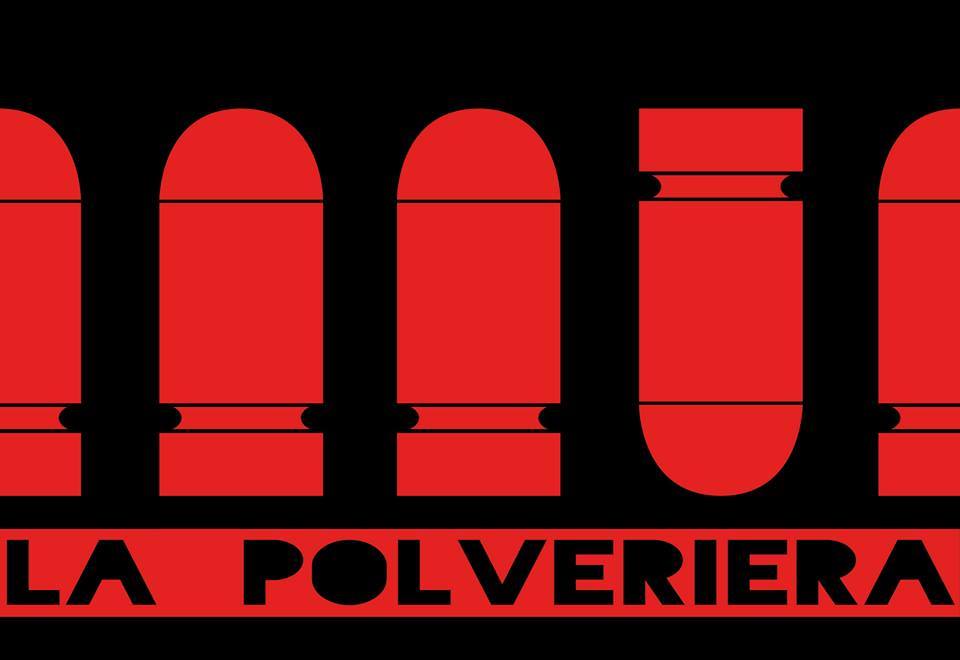Burkini sì – Burkini no. Se non ci fosse da incazzarsi, ci sarebbe da ridere
 Nel bel mezzo di un’estate infuocata da una guerra diffusa che, dal Medio Oriente, lambisce ormai l’Europa … l’attenzione viene indirizzata al burkini. Ci sono o ci fanno? Sembrerebbe uno scoop estivo in cui l’imbecillità si sposa con la disinformazione e la provocazione. Ma spesso l’ombra di una piuma cela un coacervo di mascalzonate razziste.
Nel bel mezzo di un’estate infuocata da una guerra diffusa che, dal Medio Oriente, lambisce ormai l’Europa … l’attenzione viene indirizzata al burkini. Ci sono o ci fanno? Sembrerebbe uno scoop estivo in cui l’imbecillità si sposa con la disinformazione e la provocazione. Ma spesso l’ombra di una piuma cela un coacervo di mascalzonate razziste.
L’enfasi mediatica è assolutamente sproporzionata rispetto alla reale entità di un fenomeno che riguarda gli integralisti islamici, ovvero una minoranza del poderoso flusso migratorio che sta investendo l’Europa occidentale. L’obiettivo implicito è irreggimentare il flusso migratorio complessivo, in cui sono presenti culture assai diverse. Il pretesto è stato offerto da un motivo assolutamente contingente, ancorché grave.
La scelta di colpire l’islam è infatti dettata dalle tensioni sempre più scottanti esplose con la catastrofe che si è abbattuta sui Paesi islamici del Medio Oriente e del Nord Africa. E che toccano da vicino l’Europa È una guerra sociale mascherata da «scontro di civiltà».
È una maschera logora, poiché queste civiltà, l’Occidente democratico come l’Oriente islamico, non hanno più nulla da dire. Hanno perso la loro spinta propulsiva ed entrambe queste «civiltà» sono giunte al capolinea.
Ci troviamo in un marasma in cui è difficile (se non impossibile) districarsi seguendo un filo razionale. Perché dove regnano le ideologie, la razionalità latita. C’è sempre una mistificazione di natura religiosa, anche quando indossa la veste del laicismo occidentale[1].
In Occidente, l’irrazionalità è mascherata da una patina ormai sbiadita: la patina del progresso. Non per nulla, la campagna contro il burkini arriva dalla Francia. La culla del progresso, della democrazia, dei diritti dell’uomo e del cittadino, della libertà … In breve, della modernità!
Qualche cosa non quadra, però. Se la libertà è libertà, l’abbigliamento non può essere imposto. In base a quali criteri viene stabilita la libertà di vestirsi in un modo o in un altro? L’abbigliamento viene scelto in base a specifiche esigenze di vita e di lavoro. Se poi l’abbigliamento si rivela scomodo, fastidioso, fonte di inconvenienti, basta cambiarlo. Ma questo non sempre avviene.
L’abito FA il monaco!
L’abito, oltre ad avere scopi pratici, «fa il monaco»: è segno di distinzione e discriminazione, in particolare nei confronti delle donne. Nelle attuali circostanze, l’abbigliamento ha assunto una chiara connotazione ideologica in una guerra che ha assunto un’altrettanto chiara connotazione ideologica di stampo religioso. Dove ideologie e religioni hanno solo la funzione di coprire e inasprire il conflitto sociale.
Come dicevo, è in corso una guerra di religione, uno «scontro di civiltà», che maschera e devia una guerra sociale. È una guerra sempre più diffusa e sempre più aspra, in cui disinformazione e mistificazione dominano la scena.
Gli occidentali giustificano il divieto del burkini sostenendo che ostacolerebbe l’integrazione. Ma per quale motivo chi si rifugia in Europa dovrebbe integrarsi? Ovvero perché dovrebbe rinunciare alla propria identità? E qui casca l’asino occidentale. E il burkini centra come i cavoli a merenda. Il burkini è un fenomeno di «costume» creato dal fashion, dall’industria della moda … giunto come il cacio sui maccheroni per spettacolizzare un evento folkloristico ma assolutamente inconsistente[2].
Lo scopo vero della campagna contro il burkini è omologare i profughi politici e, soprattutto, quelli economici alle leggi della civiltà capitalistica occidentale. È un fronte di lotta in cui i governi occidentali non perdono un’occasione per scendere in campo, varando misure securitarie. Le uniche che possono prendere.
L’integrazione avverrebbe in nome dei valori superiori di libertà e uguaglianza dell’Occidente. In Europa, questi valori hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, fondato sull’appropriazione privata (furto) e sullo sfruttamento del lavoro altrui.
Laddove il capitalismo e i suoi valori furono importati (o meglio imposti) dal colonialismo, i risultati furono quasi sempre problematici, se non deleteri, soprattutto nelle società non occidentali, fondate su modi di produzione autosufficienti (selfsustaining, diceva Marx), come l’Africa subsahariana, l’America e l’Oceania. Nonostante i disastri, finché il modo di produzione capitalistico visse una fase espansiva (XIX e XX secolo), fu possibile la convivenza tra nuove e vecchie consuetudini. Tra nuovi e vecchi costumi. Ma fu sempre una convivenza precaria, pregna di tensioni. In primis, i «progressisti» si appropriarono della terra, cui fece seguito il lavoro coatto, se non la vera e propria riduzione in schiavitù dei civilizzandi.
Nelle società in cui prevaleva il modo di produzione asiatico (il dispotismo orientale), come l’India e la Cina, il contatto con il capitalismo provocò grandi sconvolgimenti economici e sociali, sprigionando mutamenti con implicazioni parzialmente favorevoli agli strati popolari e alle donne. Tuttavia, le conseguenze erano pericolose non solo per il vecchio ordine asiatista ma anche per il nuovo ordine progressista, poiché, implicitamente, venivano messi in discussione i rapporti di subordinazione sociale e di genere. La soluzione fu un compromesso deteriore che saldò il dominio di vecchi e nuovi dominatori. Un esempio è il sistema delle caste in India che gli inglesi mantennero a proprio vantaggio, dopo averne distrutto le funzioni originarie che ne giustificavano l’esistenza. Questo avvenne nel 1793, con il Permanent Settlement, l’accordo che stabiliva i criteri per la riscossione delle imposte fondiarie, affidandone la gestione a funzionari nominati dalla Compagnia britannica delle indie orientali[3].
Un progresso a senso unico
Nei Paesi civilizzati dal colonialismo occidentale, il «progresso» capitalistico favorì essenzialmente le classi superiori: funzionari di alto livello, grandi proprietari terrieri, borghesia compradora e mercanti-banchieri. Le classi sfruttate e oppresse (contadini e piccoli artigiani) videro la loro condizione peggiorare notevolmente, vivendo presto i drammi di una violenta proletarizzazione[4].
In altre occasioni, ho precisato che nelle società non occidentali il modo di produzione capitalistico sia stato «innestato», dando vita a società ibride, né carne né pesce, dove però il capitalismo sprigiona i suoi aspetti più deleteri, trovando la massima libertà di sfruttare i proletari e distruggere la natura[5].
Nella seconda metà del Novecento, quando le colonie conquistarono l’indipendenza, la condizione sociale dei lavoratori delle campagne e delle città conobbe in generale miglioramenti, in una vaga, e spesso stonata, emulazione di modelli occidentali. Ma già negli anni Ottanta iniziò la controtendenza che ebbe il suo abbrivio traumatico in alcuni Paesi islamici, dove l’ibridazione capitalistica era avvenuta sulla base di una situazione particolarmente contraddittoria, ovvero pervertendo una possibile evoluzione economica autoctona. Emblematico fu l’Iran, con il passaggio dalla modernizzazione capitalistica forzata dello Shah Reza Pahlavi al capitalismo islamizzato dell’ayatollah Khomeini (altrettanto forzato). Un esempio che avrebbe fatto tanta strada … con Isis & co.
Nei Paesi islamici la regressione sociale assunse il volto di una vera e propria controriforma oscurantista di stampo religioso.
Questa controriforma oscurantista ha un’origine ideologica che nasce dal fallimento del modello economico statalista di matrice sovietica. Fallimento che avveniva nel momento stesso (fine anni Settanta del Novecento) in cui anche il modello capitalistico occidentale cominciava a perdere colpi. Ma l’oscurantismo religioso non risolve assolutamente i problemi causati dalla crisi sistemica del capitale, poiché non rappresenta un modello alternativo. L’oscurantismo serve solo a inasprire il controllo sociale. Creando più problemi di quanti ne vorrebbe risolvere, ha generato la leggenda dello scontro di civiltà.
Il persistente dissesto economico di una parte notevole di Paesi islamici alimenta da anni il crescente flusso migratorio verso l’Europa, dove l’accoglienza sta assumendo modalità da campo di concentramento, suscitando inevitabilmente rabbia e malessere. Il controllo di questo magma sociale esplosivo viene affrontato dall’Unione Europea ricorrendo alla via dell’integrazione, ossia l’accet-tazione dei valori occidentali. Ma questa via è solo un espediente di bassa lega, per cercare di sterilizzare, almeno, le manifestazioni ideologiche del contrasto (islam radicale), ricondurlo, appunto, al rispetto dei valori occidentali. E il serpente si morde la coda.
Il tempo è un invenzione di gente incapace d’amare
Jacque Camatte
Veniamo all’essenza del problema. Il concetto di progresso, su cui si fondano i «valori occidentali», è strettamente connesso al concetto di tempo lineare, ovvero il tempo del mercante (e degli affari) contrapposto al tempo ciclico del contadino (economia naturale)[6].
Il tempo ciclico si fonda soprattutto su criteri biologici e astronomici, ovvero sul ciclico succedersi delle stagioni che regola le attività agricole. In questa concezione, l’essere umano vive in simbiosi col cosmo. È significativo che, nelle antiche simbologie religiose, sia ricorrente l’immagine del cerchio e della ruota.
Molto più recente è il concetto di tempo lineare, il cui punto di riferimento sono soprattutto (ma non solo[7]) le cosiddette religioni rivelate (ebraismo, cristianesimo e islam), le quali contemplano un’origine (la creazione) e una fine del mondo (l’apocalisse). Esse trovarono un terreno fertile nei centri commerciali del Medio Oriente ellenico, dove l’economia naturale veniva scalzata dall’economia monetaria. Successivamente, sotto le sembianze del cristianesimo, e pur incontrando vive opposizioni interne ed esterne, questa concezione si diffuse in gran parte del Mediterraneo e dell’Occidente europeo. Essa rispondeva all’essenza del nascente modo di produzione capitalistico, ovvero al «tempo del mercante», basato sugli affari, sui commerci e sulla finanza, dove profitto e interesse aumentano (progrediscono) nel tempo.
Nel modo di produzione capitalistico domina il concetto di tempo lavoro: ogni attività viene misurata e calcolata per stabilire il tempo impiegato per produrre un bene o meglio una merce. Lo stesso criterio viene applicato per calcolare i vantaggi che da una determinata attività si possono trarre, in termini di profitto e interesse.
Il capitalista (il padrone) compra il tempo dell’operaio, o meglio glielo ruba, poiché in realtà paga solo una piccola parte della ricchezza che in quel determinato lasso di tempo l’operaio ha prodotto (il plusvalore)[8].
Anche l’evoluzione sociale, il progresso, viene misurata e calcolata secondo questa logica. Per cui il concetto di evoluzione si confonde con il concetto di sviluppo. Dove non c’è sviluppo, non c’è evoluzione e non c’è progresso … Artefice dello sviluppo è, ovviamente, il modo di produzione capitalistico, grazie al capitale, il valore che si valorizza per eccellenza (altrimenti perisce).
È un assioma che si è affermato nel corso di almeno cinque secoli e che, in Occidente, abbiamo introiettato come una verità rivelata. Ma da qualche tempo questo assioma inizia a mostrare la corda (i limiti dello sviluppo!). Da circa quarant’anni, lo sviluppo, il Pil, ristagna e recede. Lo stato di salute del Pil è diventato una drammatica ossessione che ci perseguita con ritmi sempre più incalzanti. E intanto si parla tranquillamente di stagnazione secolare[9].
A questo punto, se le parole hanno un senso, stagnazione secolare significa che il modo di produzione capitalistico è fermo, anzi, a ben vedere consuma più di quanto produca, perdendo la sua presunta funzione storica e quindi la sua giustificazione ideologica. I valori della civiltà occidentale non hanno più alcun fondamento reale. E si svelano per quello che in realtà sono: sporche menzogne razziste per giustificare secoli di rapine, soprusi e sfruttamento.
Dino Erba, Milano, 4 settembre 2016
I luoghi comuni dell’Occidente
Alcuni concetti che ci sembrano acquisiti da tempo, in realtà hanno un’origine abbastanza recente. Non solo. Per affermarsi, hanno dovuto affrontare forti opposizioni che riaffiorano ogni qualvolta la sostanza di questi concetti si scontra con i loro limiti intrinsechi. Ecco un paio di esempi evidenziati da Le Goff.
– Il concetto di proprietà ricomparve nel secolo XII e XIII col diritto romano che, per inciso, si applica esclusivamente ai beni mobili. Non alla terra. Jacques Le Goff, La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere, Mondadori, Milano 1992, p. 34
– Il concetto di progresso apparve solo in tempi recentisimi, nel XVIII secolo. Jacques Le Goff, La borsa e la vita, op. cit., p. 62.
Amadeo Bordiga forse non conosceva le opere di Le Goff tuttavia, nello stesso periodo in cui apparivano in Francia, egli scrisse:
«Nella forma dello scambio, della moneta, e delle classi, il senso della perennità della specie sparisce, e sorge ignobile quello della perennità del peculio, tradotta nell’immortalità dell’anima che contratta la sua felicità fuori natura con un dio strozzino che tiene questa banca esosa. In queste società che pretendono di essere salite da barbarie a civiltà si teme la morte personale e ci si prostra alle mummie, fino ai mausolei di Mosca, dalla storia infame».
Amadeo Bordiga, A Janitzio la morte non fa paura, «il programma comunista», a. X, n. 23, 15-29 dicembre 1961 [disponibile nel web].
[1] Ho affrontato la questione in occasione del raid stragista del daish, operato a Parigi il 13 novembre 2015: In nome dell’Occidente! Una crociata isterica e ipocrita, fuori tempo massimo, Milano, 20 novembre 2015.
[2] Karima Moual, Non dimentichiamo le musulmane che lottano in costume, «La Stampa», 20 agosto 2016. “Il burkini? Un falso problema, il divieto crea solo tensioni”, Intervista a Paul Cassia, docente di diritto pubblico alla Sorbona di Parigi: «Le ordinanze con scadenza al 31 agosto la dicono lunga sulla legittimità della polemica», «La Stampa», 20 agosto 2016. http://www.lastampa.it/2016/08/20/esteri/il-burkini-un-falso-problema-il-divieto-crea-solo-tensioni-WG2TcS3cfKeztjoToIZMLO/pagina.html
[3] Vedi: Karl Marx, Imposta fondiaria, rapporti di proprietà sulla terra, monopolio del sale, in Karl Marx e Friedrich Engels, India, Cina, Russia, Prefazione, traduzione e note di Bruno Maffi, Il Saggiatore, Firenze, 1965, p. 83. Per un approfondimento, Kevin B. Anderson, Marx aux antipodes. Nations, ethnicité et sociétés non occidentales, Edition Syllepse, Paris – Editeur M, Québec, 2015, Capitolo 1, p. 33.
[4] Vedi: Ivo Bergamini, Alle origini del movimento operaio indiano. Classi, caste e movimenti politici nell’India coloniale. 1857-1918, Pantarei, Milano, 2007, in particolare: Capitolo I, Il quadro storico.
[5] Dino Erba, Quale rivoluzione comunista oggi. Problemi scottanti del nostro movimento, All’Insegna del Gatto Rosso, Milano, 2014, p. 38.
[6] Jacques Le Goff, La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere, Mondadori, Milano 1992, Capitolo terzo. E Ibidem, Tempo della Chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo, Einaudi, Torino 1977, pp. 3-39.
[7] C’è anche la nascita della filosofia e della moneta. Sono tutte manifestazioni del medesimo processo di separazione dell’essere umano dal cosmo.
[8] Questi concetti sono diffusamente esposti da Marx nel Capitale, Primo Libro, Prima Sezione.
[9] Ho affrontato la questione in: Dino Erba (e molti altri), Classi in lotta in un mondo in rovina. Crisi del processo di accumulazione del capitale e disgregazione sociale, All’Insegna del Gatto Rosso, Milano, 2014
Leggi anche: